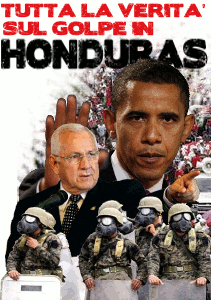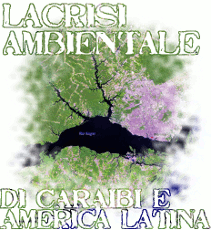Intervista all’architetto Jaime Sorín sul quartiere della Túpac Amaru a Jujuy.
L’ex decano della Facoltà di Architettura (UBA) riflette sul Cantri, città costruita dall’organizzazione guidata da Milagro Sala, e lo definisce come un’esperienza dove “l’abitazione è stata trattata come un problema integrale di inclusione”.
“Se questo governo lo intendesse, l’esperienza del quartiere della Túpac per questo sarebbe un apporto molto utile, perché quello che ha fatto l’organizzazione è stato di rendere realtà gli obiettivi del millennio stabiliti dall’Unesco”. Jaime Sorín è architetto, ex decano di Architettura dell’UBA, e in questa intervista riflette sulla città costruita dall’organizzazione che Milagro Sala guida ad Alto Comedero: il Cantri della Túpac Amaru, visitato da specialisti europei -racconta- che l’hanno visto come un possibile modello di città post-capitalista. La trama di case con scuola, centro comunitario, centro sanitario e parco acquatico ha come belvedere il tempio Kalasasaya, replica dello spazio sacro delle comunità aymara in Bolivia. Sorín è convinto che questo punto nella parte alta della valle spieghi anche perché è stato possibile fare questa città. “Nel trasformare uno strumento di politica della casa in una ‘altra’ politica, che metteva al centro la rivendicazione dei diritti sociali ed economici di soggetti fino allora stigmatizzati da un ordinamento gerarchico, etnico e sociale, la Túpac ha imposto il diritto alla città come spazio socialmente condiviso, introducendo la possibilità di costruire una città nella quale tutti abbiano il diritto di trasformarla per vivere degnamente”, dice Sorín.
–Quale è stata la sua prima impressione nel quartiere?
–È stata una sorpresa trovare una struttura urbana per nulla comune in quartieri tradizionali di piani federali, pensati come quartieri dormitorio. Ma la seconda è che entrando nel quartiere non solo vedi una trama urbana, ma una struttura sociale che sostiene un progetto di vita. Oltre a case, hanno fatto fabbriche, laboratori che contribuivano all’apparizione delle case. Ma in fondo trovi il Parco dei Dinosauri, per esempio, che è realmente impressionante perché nessuno si aspetta che in mezzo ad un quartiere ci sia un parco di divertimenti per ragazzi, con attività per famiglie, con spazi d’ombra e cannicci. Dopo, l’enorme spianata d’acqua, che non è stata pensata, attraverso geometrie, da professionisti. E salendo al tempio, quello che si vede dall’alto è notevole, perché parla soprattutto di un altro modo di guardare la vita, che non è quello dei professionisti, né dello stato. Da lì, si vede la valle con le cisterne d’acqua che hanno immagini di Túpac, del Che e di Evita. E dopo ci sono le frasi che vanno apparendo sui muri. Quando ti infili nella industria tessile -dove c’è una disciplina del lavoro che molti laboratori commerciali invidierebbero-, una parete ha un enorme cartello che dice: contadino, il padrone non mangerà altro dalla tua povertà. Tutto è sommamente impattante, una città fatta da disoccupati, perché il Collegio degli Architetti ha presentato degli onorari molto elevati e non c’è stata nemmeno una università per organizzare il lavoro. La gente si è auto-formata.
–Adesso hai parlato del tempio. Di che parla una città quando è attraversata da questa dimensione simbolica?
–Il tempio è il luogo da dove si vede la città. Ma anche, il luogo per le celebrazioni (NdR: dell’Inti Raymi, del giorno della Pachamamma, tra le altre cerimonie). Lì ti rendevi conto del perché si è potuto fare questo quartiere. Quando vedi la planimetria di un quartiere fatto dallo stato, noti la mano del professionista. In cambio, qui noti la mano della vita. Ti appare la scuola. Il centro sociale. Il centro sanitario. Questa scuola impressionante per chi ha delle capacità differenti. E dopo, i luoghi di lavoro. Credo che sia stato quello che fuori ha avuto un fortissimo impatto, per cui è stata presa d’esempio da riviste europee.
–Lei ha posto a confronto questo modello con i quartieri dormitorio e con il paradigma dell’abitazionismo, di pura costruzione di metri quadrati. Ci sono altri modelli così?
–No. Dai quartieri costruiti dagli inglesi in avanti, hai quartieri dormitorio, alcuni più integrati nella trama urbana, altri meno. Negli ultimi 30 anni sono stati fatti, inoltre, quartieri in periferia con la logica delle operazioni immobiliari. Quartieri nell’area metropolitana e all’interno del paese con abitazione a due o tre chilometri dai centri. Quando la gente ha un problema di salute, deve andare d’urgenza in una città. La stessa cosa con l’educazione. Questo è incominciato a cambiare negli ultimi anni con lo sviluppo dei centri di integrazione comunitaria.
–Quando lei ha conosciuto il quartiere, ha parlato di costruzione di cittadinanza.
–È centrale. Chi ha un problema di abitazione, quello non è il primo problema che ha. Si giunge ad un problema abitativo quando ci sono molti problemi precedenti: un problema di lavoro, unito in genere a problemi di salute e di educazione. Il problema abitativo è l’ultimo anello di una catena di problemi di una persona che finisce esclusa. Per questo contestiamo l’idea di risolvere il deficit abitativo a partire dalla costruzione di una casa. Per questo, l’esperienza della Túpac è anche singolare, perché l’abitazione è stata trattata come un problema integrale di inclusione. Lì si vede una scommessa nel costruire cittadinanza attraverso l’inclusione. Il quartiere non solo risolve l’abitazione, rivolte la sanità, l’educazione, il lavoro. Quando si unisce tutto questo, la persona si sente inserita come cittadino. In questo senso, credo che il quartiere della Túpac, a questo Governo, se lo comprendesse, gli darebbe molto perché quello che ha fatto la Túpac Amaru è stato rendere realtà gli obiettivi del millennio, che sono stati stabiliti dall’Unesco. Si tratta di otto punti tra i quali, abitazione, sanità, educazione. Non c’era il lavoro. Il lavoro è stato il punto 9 e lo ha incluso il governo nazionale nel 2004, come “lavoro decente”. Gli altri otto sono monitorati dalle Nazioni Unite. E la verità è che l’unico quartiere, l’unica opera, che in tutti questi anni può avere una punteggio positivo, dato che rispetta la totalità degli obiettivi, è questo quartiere. Come dire, che anche allo stato è servito molto. È certo che anche lo stato nell’ultimo decennio ha costruito molto, ma con la logica dell’abitazionismo: fare metri quadrati.
–I piani Procear?
–Tutto è metro quadrato. Solo nel 2009, quando appare il Programma di Integrazione Socio Comunitaria, si incomincia a comprendere che è necessario che i quartieri contengano logiche di integrazione. Si sono fatte riunioni di ministeri e hanno avuto un finanziamento dopo aver inteso che con le abitazioni non si risolveva l’emergenza abitativa. Che l’emergenza non era solo mettere un tetto, ma integrare popolazioni in ciò che sono i diritti cittadini. Dal 2009 in avanti, il finanziamento della Túpac è giunto nel quadro di questo Piano che permetteva di pensare ad un altro tipo di opere e ha autorizzato la formazione di cooperative, perché le opere erano per cooperative.
–Nella Túpac raccontano che all’inizio non credettero che lo avrebbero fatto.
–Gli dettero la prima opera, ma gli dissero: già sappiamo che non lo farete, ma vi diamo sei mesi per provarci. Lo fecero in quattro. Lì, il Governo notò che a Jujuy c’era una realtà diversa e hanno continuato. Questa è un’altra caratteristica: è stato fatto con il finanziamento dello stato ma senza un intervento dello stato. Hanno organizzato la produzione con squadre di lavoratori diverse dal sistema privato per utilizzare meglio il tempo e le risorse. I risparmi prodotti da questa amministrazione comunitaria sono stati reinvestiti in un altro tipo di opere.
–Allora, perché la persecuzione?
–Alle imprese tutto questo non gli conviene per nulla. Gli crea un problema, perché mostra che tutto si può risolvere con un minor costo e più rapidamente. Nemmeno alle burocrazie statali conviene, perché gli toglie potere. E nemmeno agli agenti immobiliari. Uno dei problemi più grandi è la gestione della terra. Quando le cooperative si espandono, discutono anche questo. Ed evidentemente ha dato fastidio alle imprese costruttrici di Jujuy. La Túpac è rimasta con una produzione enorme.
24-01-2017
Página/12
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Alejandra Dandan, “La utopía de la ciudad compartida” pubblicato il 24-01-2017 in Página/12, su [http://www.pagina12.com.ar/15898-la-utopia-de-la-ciudad-compartida] ultimo accesso 28-01-2017. |