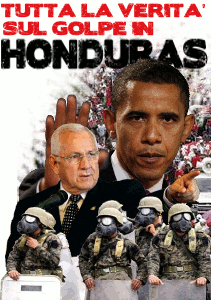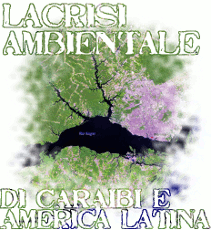L’ecologismo politico, inteso come movimento sociale antagonista, lontano dall’aver aumentato la propria potenza politica in questo contesto di effervescenza discorsiva verde sembra che stia implodendo.
L’ecologismo politico, inteso come movimento sociale antagonista, lontano dall’aver aumentato la propria potenza politica in questo contesto di effervescenza discorsiva verde sembra che stia implodendo.
Isidro López
L’attuale presentazione della crisi ecologica nelle società capitaliste occidentali racchiude un paradosso che aggiunge confusione politica in un mondo postpandemico di per sé tendente alla confusione. A prima vista, la crisi ecologica, con la crisi climatica come punto centrale, è più visibile che mai nei canali di comunicazione maggioritari di mezzo mondo e plasma ogni tipo di pratiche di distinzione in termini di consumo e stili di vita. E qualcosa di simile accade sul terreno dei grandi discorsi dei diversi tipi di sedie politiche ed economiche nelle loro differenti scale e relative posizioni gerarchiche.
Tutti gli organismi internazionali, inclusi quelli che fanno parte del Consenso di Washington (FMI, Banca Mondiale, OMC) mettono la crisi ecologica come prima priorità nelle loro agende. Tutti i governi nazionali, regionali e locali dell’Occidente capitalista parlano il linguaggio della crisi climatica, così come è stato fissato nella Riunione di Kyoto. Non c’è un solo programma di ripresa economica postpandemica che non parli il linguaggio della crisi climatica. In cima alla piramide del potere capitalista, le grandi case finanziarie di Wall Street adornano i propri discorsi corporativi con un velo di verde ben visibile. Perfino gli arci-nemici del movimento ecologista storico come le imprese energetiche o l’industria dell’auto si dichiarano agenti del cambiamento ecologico. Con un competitore insperato come è la Guerra dell’Ucraina e il suo utilizzo atlantista come asse di una poco probabile nuova guerra fredda, si può dire che la crisi ecologica e la sua soluzione capitalista sono l’asse su cui si regge la ristrutturazione di un capitalismo occidentale che non riesce a riprendere il volo da oltre quarant’anni e che è in visibile crisi, alternando da più di un decennio periodi di stagnazione con momenti recessivi.
Durante i lunghi anni dell’egemonia neoliberale, l’ecologismo politico globale si è caratterizzato come un contropotere dentro gli stessi apparati dello stato, nazionali o transnazionali
Il paradosso della situazione è che l’ecologismo politico, inteso come movimento sociale antagonista, lontano dall’aver aumentato la propria potenza politica in questo contesto di effervescenza discorsiva verde sembra che stia implodendo. Questo fatto è sconcertante dal punto di vista delle dinamiche storiche delle crisi sistemiche, queste tendono a formare soggetti politici in lotta, siano di classe, di genere o di razza, che sono modellati e modellano i propri profili e le proprie caratteristiche concrete nel conflitto, e da lì, generano dinamiche proprie di successione, concentrazione, cooptazione, frammentazione o ricomposizione.
Senza necessità di esempi più lontani, la nascita dell’ecologismo politico, così come lo conosciamo, è stato il risultato congiunto dell’incontro dei resti trasformati della scossa politica globale del 1968 con gli elementi centrali della crisi degli anni 70. Una crisi, nella cui scia ancora viviamo, che metteva fine a quarant’anni di espansione materiale fordista-keynesiana con le sue due crisi del petrolio e il riassetto americano del mondo conforme al potere del dollaro e dei combustibili fossili. Questo incipiente movimento ecologista si nutrì, e simultaneamente dette impulso, di una lettura della crisi energetica come primo avviso di un progressivo esaurimento delle risorse naturali, che stavano mettendo a rischio la sopravvivenza degli umani come specie. Da qui, l’ecologismo nascente non interpellava la classe sociale, il genere o l’etnia ma tutti, come “esseri umani” di fronte alla “natura”.
Da un punto di vista storico, i soggetti politici che componevano la prima ondata dell’ecologismo politico si diluirono tra coloro che scelsero la via dei partiti politici verdi -il caso della Germania è l’esempio da libro di testo- e coloro che trovarono comodo o furono direttamente cooptati dai partiti politici e dai sindacati socialdemocratici allora ancora rafforzati dal loro ruolo di direzione dentro i modelli di stato del benessere europeo precedenti all’ondata neoliberale degli anni 80 e 90.
Da queste posizioni, il processo di incastro istituzionale dell’ecologismo politico può essere letto come un filtrato dai movimenti, che progressivamente si erodono in quanto tali, verso posizioni “esperte” dello Stato, siano esse ministeriali o universitarie, da cui parte un progressivo tentativo di dirigere le politiche pubbliche verso un discorso “verde”. Questo tende a far pendere sulla scommessa delle fonti di energia rinnovabile. Si può prendere il Vertice di Rio del 1992 delle Nazioni Unite e la sua promozione del termine Sviluppo sostenibile come un buon punto di riferimento temporale che avrebbe segnato il passaggio dall’emergente fase movimentista dell’ecologismo alla fase di expertise istituzionale globale.
Durante i lunghi anni dell’egemonia neoliberale, l’ecologismo politico globale è andato così profilandosi come un contropotere dentro gli stessi apparati dello stato, nazionali o transnazionali, che si avvaleva dell’azione diretta non violenta, nata nei movimenti del 68. Come si può immaginare, Greenpeace è sicuramente l’esempio più immediato al momento di sostenere procedimenti di lobby che fanno pressione all’interno dello stato utilizzando obiettivi quantificati, normalmente ratificati da qualche agenzia transnazionale di valutazione delle politiche pubbliche. La pressione durante lo svolgimento delle riunioni delle agenzie transnazionali per il conseguimento di impegni quantificati e il tallonamento, sempre deludente, della loro implementazione su scala territoriale degli stati nazione, e le loro suddivisioni regionali e locali, sono andati costruendo il tronco centrale dell’ecologismo politico nelle sue aspirazioni di trasformazione sociale.
Il progressivo posizionamento dell’ecologismo nei conflitti all’interno dello stato ha influito al massimo nella costruzione dell’attuale discorso politico ecologista, non tanto segnando una linea unica, ma sì come asse vertebrale di quasi tutte le varianti e sottospecie di ecologismo esistente. In primo luogo, la relazione politica con il capitale è stata fondamentalmente prospettata dall’interno dello stato, come intervento sulle distinte aree di regolazione promuovendo cambiamenti legislativi in senso, generalmente, di una maggiore protezione territoriale e ambientale, e ogni volta di più come parte di totalità più o meno coerenti di politiche pubbliche che si reggono su diversi modelli di fiscalità “verde”. È in questo tipo di registro politico che la concezione dominante dell’ecologismo politico ha sviluppato una lettura della dinamica dell’accumulazione capitalista, nel suo sviluppo attraverso il saccheggio e la distruzione degli ecosistemi, come un fenomeno derivato dall’azione o inazione dello stato nella sua relazione con gli agenti capitalisti.
Lavoro salariato fordista e consumo di massa sono due facce della medesima moneta, che nell’ordine ideologico appaiono solo come figure separate
Il fatto che uno dei luoghi preferenziali per lo sviluppo istituzionale dell’ecologismo politico siano stati i sindacati fordisti, lontano dal portare l’ecologismo nei conflitti di lavoro vivi nel mercato del lavoro, lo ha allontanato da loro per convertirlo in una sorta di programma politico di futuro per un sindacato fordista così in decadenza nelle società capitaliste occidentali come lo stesso lavoro fordista e l’ideale socialdemocratico che sosteneva.
Nella misura in cui il gigantesco apparato produttivo fordista si è andato smantellando in modo disuguale in Europa e negli Stati Uniti, e la negoziazione collettiva è andata posizionandosi come una sorta di rituale condiviso da capitale e lavoro di smontaggio della civilizzazione industriale del XX secolo, si è posto al suo posto un progetto di generazione virtuosa di lavoro mediante l’investimento pubblico, che ripeterebbe i modelli e il modellamento del lavoro fordista, ma questa volta applicato ai grandi e ai vuoti del nascente capitalismo verde, come “la transizione giusta” o la “decarbonizzazione” dell’economia.
Il rapporto del 2008 dell’ILO, Green Jobs, prima formulazione di quello che oggi conosciamo come Green New Deal, sarebbe un buon esempio di questo tipo di legami dell’ecologismo politico con le strutture esperte dello stato. E anche un buon esempio dei pericoli che racchiude la lettura astorica della relazione tra conflitto di classe e conflitto ecologico come una contraddizione tra “lavoro” e “natura” senza maggiori precisazioni. Dietro ambedue i termini di solito si essenzializza un apparato produttivo fordista in decadenza e i suoi modelli d’azione sindacale di fronte alla realtà di un mercato del lavoro completamente atomizzato, informalizzato e frammentato che è incapace da sé di essere il motore della riproduzione sociale e necessita di un permanente rattoppo da parte degli stati, includendo sindacati e associazioni padronali, affinché il mercato del lavoro capitalista avanzato non si sgretoli.
L’altro grande fronte d’intervento dell’ecologismo politico è stato il consumo, inteso anche come un compartimento stagno che, in grande misura, mantiene acriticamente la separazione che stabilisce l’ordine capitalista tra i momenti della produzione e del consumo. Lavoro salariato fordista e consumo di massa sono due facce della stessa moneta, che appaiono solo come figure separate nell’ordine ideologico: il consumatore sovrano capace di assumere decisioni su come spendere il proprio salario, generoso e stabile, è una copia dello status del lavoratore fordista. E da quando è cominciato, già più di cinque decenni fa, l’era della pubblicità di massa, sappiamo che il consumo, in questo senso, è fondamentalmente consumo di “stili di vita”.
Un altro sintomo dei rischi delle letture astoriche del capitalismo e dei suoi effetti, il molto tempo dedicato dall’ecologismo politico a “coscientizzare” il consumatore affinché “scelga” modelli di consumo meno nocivi per gli ecosistemi, ha finito con l’aggiungere e legittimare nuove nicchie di consumo che un capitale in crisi permanente di domanda effettiva ha utilizzato come piccole nicchie di benefici straordinari, a partire da nuove linee di prodotti adattate a stili di vita “sostenibili” o “verdi”. Se i sindacati sono stati il veicolo istituzionale che ha disattivato la possibilità di un conflitto di classe ecologico, l’individuazione e la costruzione di nicchie gerarchizzate nell’ambito del consumo sono state realizzate attraverso un’infinità di ONG e di enti del terzo settore.
Se da qui si riprendono gli attuali dibattiti all’interno del movimento ecologista tra capitalismo verde o decrescita, o Green New Deal di fronte al collassismo, appaiono come due posizioni perfettamente integrate in ambedue i poli di questo modello di interpretazione: il punto di vista della produzione, ovviamente, preferisce il capitalismo verde con la sua promessa di crescita e lavoro alla maniera fordista ma decarbonizzato. E correlativamente il punto di vista del consumatore preferisce la “decrescita”, intesa all’inizio come un esercizio morale individuale di autocontenzione virtuosa e ora, sempre più, come uno stile di vita integrato pienamente tra le opzioni disponibili nel mercato.
Il capitalismo pospandemico è tornato a mettere in primo piano l’immensa quantità di contraddizioni demografiche, ecologiche e sociali che la crisi di sovrapproduzione provoca
Parte del successo di questi termini del dibattito tra capitalismo verde e decrescitismo è che in fondo non propongono grandi sfide all’ordine politico del capitalismo. Di fatto, la molto frequente inquadratura del dibattito nei termini classici delle lotte di classe del XX e del XIX: riformismo di fronte a radicalismo, gradualismo di fronte a massimalismo, possibilismo di fronte a catastrofismo è di per sé una fonte di retroalimentazione dei termini che, in mancanza di un’azione politica che li sostituisca con altri più adatti all’attuale realtà, minaccia di installarsi nell’assoluta sterilità e di non soddisfare altra necessità che quella di riempire riviste e telegiornali, alimentare il dibattito narcisista nelle reti sociali e produrre ogni tipo di papers e congressi specializzati. In tutti i casi, non c’è altra azione possibile di quella dello stato che regola e quella dell’individuo/consumatore che decide, in nessun caso si propone una qualche forma politica collettiva autonoma, né comunitaria, né associativa, né di nessun altro tipo. Non c’è altro noi che il “noi, lo stato” di fronte al “noi, i consumatori coscienti”.
La fase attuale della crisi capitalista, che si potrebbe chiamare di precipizio del neoliberalismo atlantico che ha dominato la globalizzazione capitalista degli anni 80, 90 e duemila, ha presupposto un altro passo nella disattivazione del discorso dell’ecologismo politico, ora molto toccato nella sua capacità di incarnarsi in movimenti politici dinamici capaci di aprire nuovi scenari politici di superamento di un capitalismo che ha strangolato le condizioni della riproduzione, tanto le sociali come le ecosistemiche, fino a renderlo praticamente inattuabile. E che si mantiene in vita grazie al permanente intervento dello Stato nel mantenere l’ordine capitalista con le sue posizioni di potere intatte.
Il capitalismo postpandemico è tornato a mettere in primo piano l’immensa quantità di contraddizioni demografiche, ecologiche e sociali che provoca la crisi di sovrapproduzione, la caduta di redditività e la scomparsa della figura della crescente produttività del lavoro. Lo spostamento, già consumato, del centro di gravità della produzione capitalista in Asia e più concretamente in Cina, ha lasciato le società capitaliste che sono state al comando del sistema-mondo in una posizione di confino che contrasta con alcuni discorsi ufficiali nei quali il mondo sviluppato continua ad essere posto negli USA, in Canada, Europa e Australia di fronte ad una massa di paesi emergenti che starebbero ancora nel processo di catching up.
Le finanze, sempre molto più rapide dei movimenti politici, durante i due anni di pandemia hanno inteso che qualsiasi possibilità di mantenere discorsivamente la propria egemonia sull’attuale capitalismo dipende dalla propria capacità situare la transizione ecologica e il capitalismo verde nei mercati finanziari come valori e capitali da negoziare. Ma le finanze non hanno il medesimo tipo di controllo sui processi produttivi asiatici che hanno tenuto durante il lungo smontaggio dell’apparato produttivo fordista, sanno che saranno gli stati a canalizzare il regime di benefici delle imprese private che dipendono dagli ambiziosi piani di reindustrializzazione verde del Next Generation in Europa o dell’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti. In questo quadro, se gli stati parlano il linguaggio del capitalismo verde, lo parleranno anche le case finanziarie e le imprese globali che aspirano a controllare tanto gli investimenti come il debito statale, nel momento in cui l’incapacità a competere privatamente di fronte alla Cina, che anche ha abbracciato il capitalismo verde, provocherebbe un forte aggiustamento globale, con catene di fallimenti transnazionali.
Il discorso tradizionale dell’ecologismo politico è rimasto schiacciato dai suoi usi istituzionali e imprenditoriali, come dire, dai suoi usi capitalisti
L’ESG, Environmental and Social Governance, è il nome che le finanze hanno dato a questo nuovo asse “verde” delle proprie attività di acquisizione di fonti di beneficio. In questo caso, i molteplici obiettivi quantificati servono come referenti di nuovi metodi di revisione contabile e di valutazione di attivi che, in ultima istanza, veicolano la canalizzazione dei flussi di capitale fittizio verso quello che vuol essere un nuovo ciclo di espansione finanziaria simile ai precedenti cicli tecnologici. La lettera di Larry Fink, CEO di BlackRock, la maggiore impresa che gestisce capitali nel mondo, agli azionisti all’inizio del 2021, parlava di crisi climatica e di esaurimento delle risorse, ma soprattutto prometteva che investire nel capitalismo verde può generare shareholder value in abbondanza. Anche se le forme tradizionali di conseguimento di redditività finanziaria, fondamentalmente dipendenti dalla privazione di possesso e dal saccheggio, l’ESG apre una via complementare di conseguimento di benefici garantiti dagli stati nazione e di tentativi di rilegittimazione delle finanze.
Lungo il cammino, il discorso tradizionale dell’ecologismo politico è rimasto schiacciato dai suoi usi istituzionali e imprenditoriali, come dire, dai suoi usi capitalisti. Alcuni dei più celebri “successi” dell’ecologismo politico come i mercati di emissioni di carbonio, dove si negoziano i diritti di emissione eccedenti a partire dai diritti di emissione che aggiudicano gli stati alle proprie imprese e che, a sua volta, si aggiudicano agli stati in queste nuove riunioni di Davos che sono le COP annuali, si sono trasformati in spazi preferenziali di speculazione finanziaria, allo stesso modo dei mercati energetici, centrali nel conseguimento di benefici in questa fase del capitalismo, hanno utilizzato a proprio beneficio uno dei ritornelli classici dell’ecologia, quello che dice che prezzi alti delle risorse naturali e dell’energia, che inglobano i cosiddetti effetti esterni, sono fondamentalmente per scollegare la crescita dall’uso delle risorse.
In questo contesto, l’ecologismo politico è rimasto completamente indeterminato o si è disintegrato. Che oggi gli stati, le imprese energetiche, le grandi case finanziarie o i grandi mezzi di comunicazione parlino il linguaggio della crisi ecologica e si propongano come gli agenti del suo superamento in termini propriamente capitalisti ha lasciato senza spazio un discorso dell’ecologismo politico che forse è troppo svincolato dai movimenti politici reali, per risiedere nei corridoi dei ministeri, nelle grandi riunioni globali, nei dipartimenti delle università e le campagne mediatiche di coscientizzazione cittadina.
Tutti i dibattiti politici dell’attuale ecologismo sono attraversati da questo soppiantamento dei discorsi orientati alla, e provenienti dalla, costituzione di nuovi soggetti politici in lotta capaci di portare alla luce qualche alternativa di uscita dalla crisi dell’ecologia del capitale nella quale viviamo che non sia totalmente orientata dalle politiche pubbliche o sia una forma di stilizzare e abbellire le decisioni di consumo. Questo include le versioni che si voglio più radicali come la decrescita o il collassimo, che sono appena forme a fortiori dei medesimi discorsi di “coscientizzazione” e “autocontenimento” che oggi sono dominanti nel mondo capitalista.
*Isidro López è membro della Fundación de los Comunes.
22 giugno 2023
El Salto
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Isidro López, “Crisis ecológica, crisis capitalista, crisis del ecologismo político”, pubblicato il 22-06-2023 in El Salto, su [https://www.elsaltodiario.com/analisis/crisis-ecologica-crisis-capitalista-crisis-del-ecologismo-politico] ultimo accesso 29-06-2023. |