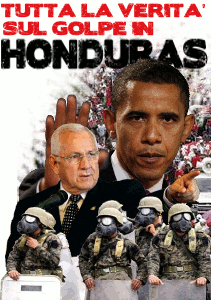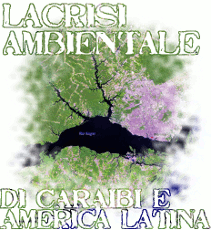Raúl Zibechi
Raúl Zibechi
Sebbene i movimenti anti-patriarcali e anticoloniali abbiano allargato le ali negli ultimi decenni, i risultati visibili nella cultura politica egemonica sono ancora molto deboli. Anche i media non egemonici e le sinistre continuano a riflettere, nei loro servizi giornalistici e nei loro discorsi, l’enorme difficoltà di trascendere le forme più tradizionali del dominio.
Le recenti elezioni in Ecuador ne sono la prova. L’attenzione riservata alla possibilità che Yaku Pérez raggiunga la presidenza con il Pachakutik non è paragonabile a quella ottenuta dalla rivolta indigena e popolare dell’ottobre 2019.
Per quanto questa rivolta possa essere stata uno spartiacque nella storia recente del paese andino, gli sguardi si puntano ancora una volta sulle urne, sebbene queste non riescano mai a modificare davvero i rapporti di forza. Il voto raccolto da Yaku è vicino al 20 per cento, il risultato più alto nella storia del movimento indigeno, un chiaro riflesso della potenza espressa dalla rivolta di ottobre.
La candidatura di Yaku è esplosa nella selva, ottenendo il 50 per cento dei voti a Morona Santiago. Negli altopiani ha superato il 40 a Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar e Azuay, cosa che non è però riuscita a ripetere a Pichincha, Imbabura e Carchi, nella regione andina del nord del Paese. Sulla costa ha prevalso Andrés Arauz, il candidato del progressismo, una corrente divenuta egemonica durante il decennio del governo di Rafael Correa grazie alla rottura della tradizionale egemonia della vecchia destra.
Questa divisione geografico-politica del Paese che merita una spiegazione
Yaku Pérez incarna la resistenza delle comunità rurali – e, sempre più, quella delle città di medie dimensioni – all’estrattivismo minerario che si sta sviluppando negli altopiani andini e nella selva, ma anche all’espansione della frontiera petrolifera. È un’alternativa al progressismo che insisteva su uno “sviluppismo” ancorato all’industria mineraria e che legalizzava e criminalizzava la protesta indigena e popolare attaccando la Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie), i sindacati e i gruppi studenteschi.
È stato uno delle centinaia di leader perseguiti e imprigionati dal governo di Correa. Proviene dalla resistenza anti-mineraria nella provincia di Azuay, dove le comunità si stanno mobilitando contro l’estrazione dell’oro che inquina le sorgenti dei fiumi e i paramo che generano acqua. Nel 2019 è stato eletto prefetto di Azuay e nelle recenti elezioni l’81 per cento degli abitanti di Cuenca, capoluogo della provincia e terza città del Paese, si è espresso a favore della cessazione dell’attività mineraria.
Il sostegno degli ecuadoriani a Yaku Pérez non è un assegno in bianco alla sua persona, ma piuttosto il modo per incanalare dal punto di vista politico la rivolta di ottobre. In quel mese, per dieci giorni, decine di migliaia di manifestanti hanno preso il controllo del centro di Quito per rovesciare il pacchetto di misure neoliberiste prese dal governo Lenín Moreno. Hanno vinto e quella vittoria è ciò che ci permette di dire che c’è stata una rottura in Ecuador.
Come già accaduto in precedenti levantamientos, sin dal primo del 1990, la regione costiera si è mantenuta ai margini e la mobilitazione si è concentrata nelle regioni a maggioranza indigena. Mentre in esse predomina l’economia agricola, sostenuta da migliaia di comunità rurali, sulla costa predomina la produzione agro-export in cui le banane giocano un ruolo di primo piano.
Le città, poi, sono una questione a parte: Quito, con i suoi 3,5 milioni di abitanti e una numerosa popolazione indigena e meticcia (solo il 6% di essa si definisce “bianca”), il peso del settore terziario e finanziario, con il suo corollario di massiccia economia informale, sta diventando un bastione della destra legata al capitale finanziario.
Per quanto ci possa dispiacere ammetterlo, un governo di Yaku Pérez, che nella peggiore delle ipotesi ha comunque sfiorato il passaggio al secondo turno, non potrebbe conseguire i suoi obiettivi principali: fermare la mega-industria mineraria e lasciarsi alle spalle il neoliberismo. Con appena il 20 per cento dei seggi, sarebbe obbligato ad accordarsi con le altre forze che sostengono con fervore l’estrattivismo.
L’insurrezione di ottobre è riuscita a fermare il pacchetto di misure neoliberiste, ma non è stata sufficiente a delegittimare il neoliberismo. La continuità di quel movimento, però, non può essere ricercata nelle elezioni, né in quelle passate né in quelle future. Lo stesso levantamiento ha segnato la rotta: la sua creazione principale è stato il Parlamento indigeno e dei movimenti sociali, dove sono state chiamate a partecipare più di 180 organizzazioni.
“Una Minga por la Vida” è il nome del programma preparato da quel Parlamento, che nella campagna elettorale è stato ripreso da Yaku Pérez come piattaforma di governo.
Quel “Parlamento de abajo“, non si è affatto estinto. Ha percorso parte del paese promuovendo il programma alternativo sviluppato dai suoi componenti, riunendo movimenti locali e generando dibattiti. Ha iniziato a percorrere un cammino lento e laborioso, necessario per organizzare quelli e quelle che stanno “in basso” fino a quando la campagna mediatico-elettorale ha fatto piazza pulita dei problemi centrali dell’Ecuador.
Il futuro non uscirà dalle urne ma dalla capacità dei movimenti e dei popoli di continuare a muoversi attraverso le brecce aperte dalla rivolta, approfondendole fino a neutralizzare un modello di morte e di espropriazione dell’acqua e della terra.
15 febrero 2021
Desinformémonos
Traduzione per Comune-info: Marco Calabria
Comune-info
https://comune-info.net/le-insurrezioni-popolari-non-entrano-nelle-urne/
| Traduzione per Comune-info di Marco Calabria: |
| Raúl Zibechi, “Las insurrecciones populares no caben en las urnas” pubblicato il 15/02/2021 in Desinformémonos, su [https://desinformemonos.org/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/] ultimo accesso 23-02-2021. |