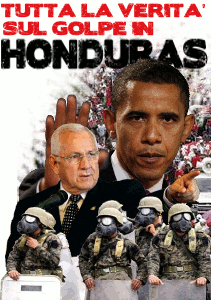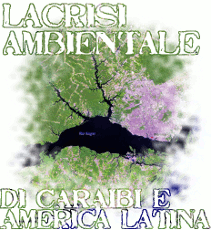L’analisi delle conseguenze che la diffusione del Covid-19 sta provocando nel continente latinoamericano raggiunge ora Bolivia, Perù e Colombia, dopo aver attraversato il Cono Sud e il Centro America.
Ciascuno di questi tre paesi presenta una situazione differente e specifica in termini di forze politiche al governo, conflitti sociali pregressi alla crisi pandemica e varietà dei territori che raccoglie, tuttavia possono leggersi anche alcuni elementi comuni. Nei contesti nazionali che descriviamo in questo articolo si osserva la difficoltà crescente della maggioranza della popolazione nel far fronte alle necessità primarie della sopravvivenza, mentre la gestione statale si rivela insufficiente, oppure addirittura colpevolmente negligente, davanti all’emergenza sanitaria, economica e sociale che l’espansione del coronavirus sta acutizzando.
Bolivia: razzismo e repressione di fronte alla pandemia*
Il coronavirus in Bolivia si diffonde in un contesto politico fortemente polarizzato e caratterizzato da un processo autoritario iniziato nell’autunno del 2019 con il colpo di Stato ai danni di Evo Morales e l’auto-proclamazione di Jeanine Añez alla presidenza. Domenica 3 maggio si sarebbero dovute tenere le prime elezioni dopo il golpe, che sono state invece rimandate a causa della pandemia. Mentre l’obiettivo della Añez sarebbe quello di utilizzare il coronavirus come scusa per rimandare le elezioni in maniera indefinita, sabato 2 maggio il Congresso, ancora guidato da una maggioranza del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha sottolineato che la Costituzione boliviana impone di svolgere l’appuntamento elettorale non oltre 90 giorni dalla data precedente, quindi entro inizio agosto.
Dopo i primi due casi di contagio a inizio marzo, il governo guidato da Añez ha decretato la quarantena obbligatoria, che è iniziata con un divieto di uscire prima di mezzogiorno ed è diventata via via sempre più severa fino ad oggi, per cui le famiglie possono mandare una sola persona a fare la spesa una volta alla settimana, con multe per la violazione che vanno da 1000 a 2000 pesos boliviani (133 e 266 euro secondo il cambio attuale). Il sistema sanitario boliviano viene considerato uno dei peggiori del mondo e dispone di appena 35 posti di terapia intensiva a fronte di 11 milioni di abitanti. Sebbene con il governo di Morales sia stata introdotta un’assicurazione medica universale, il sistema di salute pubblico è estremamente precario. Il comparto sanitario privato è molto più efficiente ma è anche uno specchio delle diseguaglianze del paese; non è un caso che il primo morto per coronavirus in Bolivia sia deceduto nel tragitto da una clinica privata, dove si erano rifiutati di curarlo, a un ospedale pubblico.
Fortunatamente il contagio non ha seguito una curva esponenziale, finora ci sono stati 1.802 contagi e 86 morti (dati del 5 maggio) e si è quindi evitato il collasso di un sistema sanitario praticamente inesistente. Tuttavia, lo scorso weekend, i nuovi contagi hanno registrato un aumento di 241 casi in 24 ore, mostrando un’impennata che ha destato non poca preoccupazione. Non si sono messe in campo reali politiche sanitarie per rifornire gli ospedali delle attrezzature mancanti. I medici sono costretti a comprarsi i dispositivi di protezione personale, situazione per cui hanno minacciato scioperi e hanno denunciato la mancanza di strumenti e infrastrutture. Sono stati registrati vari casi di Covid-19 tra il personale medico e due infermiere, che non disponevano di misure di biosicurezza, sono morte per via del coronavirus. In generale, i morti sono soprattutto anziani e gran parte di essi sono deceduti senza essere nemmeno arrivati a un respiratore. Così come in molti altri paesi, anche in Bolivia non ci sono abbastanza tamponi per pianificare una somministrazione di massa per cui accedono al test soltanto le persone che presentano sintomi del Covid-19. Di conseguenza, si ipotizza che il reale numero di contagi sia molto maggiore rispetto a quello ufficiale. La sinergia tra i centri di salute comunitaria, privi di risorse basiche, e i municipi locali non sta ancora funzionando ma potrebbe essere una strategia vincente per proteggere una popolazione per la maggior parte indigena e legata a modelli di vita e di cura comunitari.
Dal punto di vista economico sono stati distribuiti dei bonus per le famiglie svantaggiate tramite un credito di 327 milioni di dollari appena approvato dal governo con l’FMI, a cui si aggiungono altri crediti richiesti alla Banca Interamericana per lo Sviluppo (BID per la sua sigla in spagnolo) e alla Corporación Andina de Fomento (CAF), per un totale di 1 miliardo di dollari, che è stato quindi la scusa per riportare il paese sotto il ricatto delle istituzioni finanziarie internazionali, e quindi con forti rischi di imposizioni di politiche di austerità e nuove privatizzazioni in futuro. La situazione economica, che aveva registrato i maggiori tassi di crescita sotto il governo di Morales, è oggi a rischio tracollo, dato che si basa soprattutto sull’estrazione e l’esportazione di idrocarburi, il cui prezzo in queste settimane è crollato in modo vertiginoso. Si preannuncia quindi una grave crisi economica che colpirà la società boliviana durante l’estate. Nel frattempo nelle zone di El Alto, dove più del 70% della popolazione vive del commercio al dettaglio, le famiglie fanno fatica a pagare l’affitto, ci sono stati suicidi dettati dalla fame e dalla povertà nella città di Montero (nel dipartimento di Santa Cruz de la Sierra), mentre a Cochabamba diverse famiglie sono rimaste senz’acqua.
Il governo di Añez sta portando avanti un discorso militarista di guerra al virus e a chi non rispetta le misure della quarantena. Da questo punto di vista, è evidente che le politiche del governo si siano focalizzate più sulla repressione del dissenso che sul garantire la salute dei cittadini. Con la scusa del controllo della quarantena è aumentata la repressione verso quei settori che avevano mostrato maggior resistenza al golpe di novembre. In zone come la città di El Alto, storico epicentro di lotta indigena, ma anche nella zona cocalera del Chapare, si è inasprita la militarizzazione, con pattugliamento costante dei carri armati e controllo cibernetico totale. Numerose persone sono state arrestate, 80 sono state processate in direttissima e sono state condannate da 3 a 10 anni di carcere per delitti come rompere la quarantena, attentato alla salute e sedizione. In alcuni di questi casi il crimine è consistito nell’aver diffuso informazioni contro il governo sui social network o aver promosso virtualmente cacerolazos (proteste rumorose con battitura di pentole) da casa. Gli episodi di repressione del dissenso si sono mescolati in molti casi a forme di vero e proprio razzismo: di fatto, dal golpe di novembre il discorso razzista di criminalizzazione del commercio informale, principale pratica di sussistenza della popolazione indigena urbana, è aumentato enormemente, e in questa fase si salda con il clima di guerra alla pandemia, per cui la popolazione più povera viene colpevolizzata perché non può permettersi di seguire le norme della quarantena, In questo senso, un episodio particolarmente grave è avvenuto nel dipartimento di Beni, nell’Oriente del paese, dove il 31 marzo delle donne che hanno convocato una manifestazione contro la fame sono state arrestate e minacciate di condanne fino a 10 anni di prigione: l’iniziativa è stata organizzata per gettare luce sulle condizioni di estrema miseria in cui versa la gran parte delle donne boliviane, che vive di commercio informale. Un altro episodio rilevante è stato il caso dei più di mille migranti boliviani rimasti bloccati alla frontiera, dal lato del Cile, dove erano andati per svolgere lavori di raccolta stagionali. Il governo li ha accusati di essere sabotatori del Movimiento Al Socialismo (MAS, partito di Evo Morales) o turisti usciti dal paese per fare le vacanze. Dall’altro lato della polarizzazione, non sono mancati tentativi di manipolazione politica da parte di alcuni esponenti del MAS che hanno negato la pericolosità della pandemia e definito il virus come un’invenzione di Añez.
In questa situazione di forte scontro sociale e repressione politica, un problema ulteriore è la diffusione del virus tra le forze dell’ordine, che sono gli attori principali incaricati dal governo per far mantenere la quarantena, e che rappresentano circa il 10% dei contagi. Questo espone al pericolo in primo luogo gli stessi poliziotti, che non godono di nessuna misura di biosicurezza, ma anche delle persone che sono in contatto con loro, ossia i gruppi sociali più perseguitati. La popolazione vive quindi uno stato costante di paura, dove la minaccia epidemiologica si somma a, e a sua volta rafforza, quella politica della repressione. Le comunità e le organizzazioni sociali stanno provando a organizzare la resistenza, rigettando il discorso militarista del governo e proponendo iniziative dal basso. Si sono diffuse per esempio le ollas comunitarias (distribuzione di pasti solidali) per le persone più in difficoltà a cui si aggiungono le collette alimentari. Dove il governo ha cercato di colpevolizzare, tramite la geo-localizzazione, le zone più afflitte dai contagi, le persone hanno risposto organizzandosi per disinfettare le strade e diffondere le norme di salute pubblica in lingua aymara invece che invocare l’aiuto dei militari. I cocaleros del Tropico di Cochabamba hanno inviato alimenti a vari luoghi del paese, e soprattutto ai familiari delle vittime dei massacri di Sacaba e Senkata dello scorso novembre, ma anche in questo caso molti autisti dei camion con cui si stavano organizzando le spedizioni sono stati arrestati.
Nel frattempo, il governo fa di tutto per proteggere gli interessi economici del grande capitale: sono state disposte agevolazioni alle banche, mentre lo sfruttamento delle materie prime, che è sempre stato l’aspetto centrale dello sviluppo capitalista in Bolivia, e che è stato fortemente accelerato sotto il governo di Evo Morales, non si sta fermando nemmeno con il governo Añez, anzi viene rilanciato con incentivi per l’industria della soia e i progetti di fracking. Il governo ha infatti siglato nuovi contratti con le imprese estrattive di gas e sta obbligando i lavoratori di queste aziende a continuare a lavorare a dispetto della quarantena. Lo stesso avviene nei giacimenti di litio, il cui controllo è stato oggetto di una lunga disputa geopolitica che ha avuto un ruolo non indifferente negli eventi che hanno portato al colpo di Stato. Come ormai è noto, l’espansione della frontiera estrattivista e dell’agrobusiness è una delle cause del diffondersi di questa pandemia e delle altre che hanno colpito il mondo in anni recenti. Proprio in Bolivia un’altra epidemia, del cosiddetto arena-virus, si era già diffusa a causa della distruzione degli ecosistemi nella zona nord del paese.
* Si ringraziano Feminismo Comunitario Antipatriarcal e Chaski Clandestina per aver condiviso informazioni e riflessioni sulla situazione.
Perù: la risposta rapida al virus non è sufficiente
Il Perù si considera il paese in America Latina che più rapidamente e con più decisione ha affrontato l’emergenza sanitaria Covid-19. Con una serie di decreti d’urgenza l’apparato esecutivo statale ha prontamente reagito alla pandemia mettendo a punto una serie di misure tecniche volte a supportare i cittadini nel loro compito di arginare la diffusione del virus. Ma l’emergenza evidenziato i problemi strutturali che minano alla base la compagine sociale peruviana.
Sembra inevitabile che in epoca di crisi la risposta efficiente dello stato venga relazionata alla frequenza dei discorsi che i presidenti in carica rivolgono alla Nazione. In questo momento, ad accomunare tutto il mondo non è solo il virus SARS-CoV2 ma anche la sensazione di sospensione e attesa che scatena la dicitura “in diretta” abbinata, su uno schermo, all’immagine del capo del governo. È come se ogni popolazione trattenesse il fiato in attesa di conoscere il suo destino. Dalla sua prima apparizione live, avvenuta il 6 marzo in concomitanza con la scoperta del primo caso positivo, il presidente in carica Martín Vizcarra ha comunicato direttamente con i suoi cittadini per ben 34 volte, informandoli sullo sviluppo della pandemia e delle decisioni del governo. La curva dell’intensità delle sue raccomandazioni è andata crescendo insieme a quella dei casi positivi al virus.
Dopo nemmeno 10 giorni dall’apparizione del primo caso, e con un totale di 117 contagi accertati, il 15 marzo, il presidente Vizcarra ha comunicato a tutti i peruviani le misure che sarebbero state adottate con il nuovo decreto di emergenza: chiusura delle frontiere e inizio del lockdown. Misure che sono state di giorno in giorno rafforzate da provvedimenti come la quarantena obbligatoria o il coprifuoco; di fatto dal 19 marzo ai peruviani è stato impedito di uscire nelle ore notturne. Per un periodo si è addirittura arrivati a chiedere ai cittadini di recarsi a svolgere le attività di estrema necessità a giorni alterni in base al sesso: lunedì, mercoledì e venerdì solo gli uomini potevano uscire di casa; mentre il martedì, giovedì e sabato solo le donne; la domenica, giorno del signore, tutti a riposo. Questa misura, oltre a essere discriminatoria verso le persone trans, è stata ritirata in quanto inefficace, dato che non teneva conto del carico disuguale del lavoro domestico che ricade principalmente sulle donne, le quali si sono ritrovate in grossi assembramenti fuori dai negozi nei giorni in cui potevano uscire per fare la spesa. Nonostante il tono rassicurante del presidente nei suoi interventi televisivi, il Congresso ha approvato in piena crisi sanitaria una legge che deresponsabilizza l’uso della forza da parte della polizia e che è stata segnalata con allarme da diversi organismi internazionali per i diritti umani.
Al 5 maggio, giorno 52 dello stato d’emergenza, i casi positivi accertati erano 51.189 e i morti 1.444, dati che posizionano il paese al secondo posto in America Latina per numero di contagi. Per quel che riguarda la distribuzione dei malati, non stupisce che nella capitale sia stato rilevato il 65% dei casi positivi, Lima è infatti residenza di un terzo della popolazione totale, mentre altri dipartimenti duramente colpiti sono Loreto, regione totalmente immersa nella selva amazzonica, Lambayeque e Piura, situati nella costa nord. Dato più grave, quello del divario nella mortalità relativa ai quattro dipartimenti più colpiti: 1,79% Lima, 4,72% Loreto; 9,92% Lambayeque e 11,27% Piura. Una discrepanza che riflette la disuguaglianza tra centro e periferia nell’efficienza delle strutture sanitarie.
Nonostante la quantità di misure messe in campo dallo Stato peruviano per combattere il virus SARS-CoV2, i deficit strutturali del sistema sanitario statale rendono l’epidemia estremamente difficile da gestire. Tra gli impegni positivi presi dal governo ci sono: il grande aumento di posti letto in terapia intensiva, che sono passati da poco più di 100 a quasi 800 a fine aprile, l’acquisizione di attrezzature e materiale sanitario e la collaborazione del settore pubblico con quello privato. Non possiamo tuttavia dimenticare il tremendo stato di abbandono in cui versano gli ospedali provinciali che non solo non disponevano di spazi adeguati ma nemmeno di sufficiente personale per fronteggiare il lavoro di tutti i giorni, nemmeno prima della pandemia. A peggiorare notevolmente la situazione sono state infatti anche le crisi sanitarie pregresse come quella dell’epidemia di dengue che tra febbraio ed aprile aveva colpito il dipartimento di Loreto. A fronte di queste evidenti difficoltà, molti professionisti della sanità ed epidemiologi hanno applaudito la scelta radicale di un lockdown ferreo. Ma cosa succede se al quadro sanitario descritto fino ad ora si aggiunge l’alto tasso di occupazione informale del paese?
In Perù il 72,6% (INEI, 2019) della popolazione lavora nel settore informale, il che significa che a fronte dei 4,6 milioni di lavoratori che possiedono un contratto di lavoro e determinati diritti e benefici, 12 milioni non lo possiedono. Per quella gente che tutti i giorni scendeva in strada per guadagnarsi il pasto del giorno dopo, la quarantena significa semplicemente la fame. Molte sono state le persone che hanno perso il lavoro e che hanno quindi deciso di tornare in provincia, iniziando una lunga marcia che avrebbe portato loro, e probabilmente il virus, a casa. Il Perù è un paese “megadiverso”, non solo per quel che riguarda il clima e gli ecosistemi, ma anche per la sua popolazione. Gli abitanti della costa, della sierra (Ande) e della selva (foresta amazzonica) vivono condizioni di vita differenti, e spesso, lo stato non riesce ad adeguare le sue politiche secondo queste diversità. Il caso del Covid-19 non ha fatto eccezione, e nel disegnare le misure di aiuto alle famiglie in difficoltà sono stati utilizzati i criteri urbani della capitale, ignorando i bisogni dei contadini nelle zone rurali e delle comunità indigene.
Una delle misure emergenziali emessa dal governo centrale è stata quella della distribuzione di beni di prima necessità che però è avvenuta in assenza di misure rigorose che evitassero il contagio o linee guida da adottarsi nei contesti indigeni. Così si è assistito alla sfilata dei delegati dei comuni che entravano nelle comunità indigene, fino a quel momento risparmiate dal contagio, senza meccanismi di protezione. L’agire irresponsabile dei funzionari è aggravato dal fatto che in seguito all’invio da parte delle organizzazioni indigene di proposte chiare e concrete riguardanti i protocolli d’azione, tali suggerimenti sono stati completamente ignorati mettendo a rischio intere comunità.
Nel caso del Bono Familiar Universal, a venire alla luce sono di nuovo i problemi strutturali. Si tratta di una misura d’emergenza che prevede la distribuzione di 760 soles a circa 6 milioni di famiglie (pari al 75% della popolazione) come sostegno economico durante la quarantena. Purtroppo, ad oggi, i dati a disposizione del governo per identificare gli aventi diritto sono alquanto lacunosi e spesso non rappresentano la reale situazione del paese, tagliando fuori dagli aiuti molte delle famiglie più indigenti che vivono in zone difficilmente raggiungibili. Per sopperire a questa mancanza il governo ha previsto un lavoro di coordinazione tra diversi ministeri affinché questo sussidio possa raggiungere tutte le persone in difficoltà ma le lacune causeranno ritardi consistenti. Il problema non è la maggiore vulnerabilità delle popolazioni indigene della sierra o della selva, ma la mancanza di infrastrutture, l’eccessiva centralizzazione e la scarsa sensibilità verso le differenze culturali da parte del governo. Uno dei messaggi più importanti e reiterati che il presidente Vizcarra ha rivolto alla popolazione durante le sue 34 conferenze è stato “la necessità di cambiare le abitudini” come unico mezzo per il successo della battaglia contro il virus. Sebbene il messaggio sia rivolto ai cittadini, questo cambiamento è un requisito altrettanto o più decisivo per le “abitudini” delle istituzioni pubbliche.
Colombia: la persecuzione politica uccide più del virus
L’arrivo del virus Covid-19 in Colombia si inserisce nel clima politico esplosivo degli scioperi generali che hanno fatto tremare il governo alla fine del 2019 e che sono rimasti senza risposte. Inoltre, negli ultimi mesi si sono moltiplicate le denunce di corruzione ai membri del governo, sono aumentati in modo drammatico gli omicidi di leader sociali ed ex guerriglieri mentre la frontiera con il Venezuela si fa incandescente. A questo si aggiungono le insufficienze del sistema sanitario e una gestione del tutto inadeguata della crisi pandemica che sta producendo emergenza alimentare, rivolte nelle carceri e reclami da parte delle comunità indigene e contadine.
Quando il ministero della Salute e Previdenza Sociale ha annunciato il primo caso di Covid-19 in Colombia, lo scorso 6 marzo, il presidente Ivan Duque aveva già cominciato da settimane a rilasciare dichiarazioni in cui sosteneva che lo Stato era preparato ad affrontare il virus. Tuttavia, una delle prime misure messe in campo dal governo, dopo i primi 16 contagi nel paese, è stata la chiusura della frontiera con il Venezuela, che registrava solo due casi, mentre restava aperto il confine con l’Ecuador, con 26 persone positive e un morto. La vicepresidente venezuelana ha definito la decisione di Duque come un atto di “irresponsabilità grottesca”, perché significava lasciare la frontiera nelle mani dei paramilitari colombiani. La tensione lungo il confine con il Venezuela è cresciuta esponenzialmente nelle settimane seguenti e si continuano a denunciare tentativi di destabilizzazione del governo di Maduro da parte di gruppi paramilitari con base in Colombia, appoggiati dagli Stati Uniti. Nemmeno il dialogo diplomatico è stato adottato come atto responsabile per far fronte all’emergenza, e il presidente Duque ha rifiutato gli aiuti da parte del governo venezuelano che offriva due macchinari cinesi per il test del coronavirus.
Nel frattempo, il 17 marzo il presidente Duque ha dichiarato lo Stato d’Emergenza a causa della pandemia, mentre la Commissione d’Indagine e Accusa della Camera dei Rappresentanti ha aperto un’indagine parlamentare contro di lui per frode elettorale. L’ipotesi di un accordo per benefici in cambio di voti emerge da alcune intercettazioni di José Guillermo Hernández Aponte, conosciuto como El Ñeñe, ucciso nel 2019 in Brasile, in un regolamento di conti tra narcotrafficanti. La vicinanza del Ñeñe con Alvaro Uribe, padrino politico di Duque ed ex presidente colombiano, aggiunge elementi allo scandalo che ha preso il nome di “ñeñepolítica” e che ha danneggiato ulteriormente il consenso a Duque, già molto basso a partire dagli scioperi e le proteste di novembre e dicembre scorsi, e che a fine febbraio toccava il 73% di disapprovazione.
Tra marzo e aprile sono emerse altre prove che rafforzano l’ipotesi di brogli elettorali e legami dell’attuale classe politica con il narcotraffico, tuttavia il crescere dei contagi e delle emergenze correlate hanno in parte spostato l’attenzione politica e mediatica dalle accuse contro Duque, il quale ha riguadagnato terreno nei sondaggi nonostante la pessima gestione dell’espansione del virus. Un esempio della gestione ambigua dell’emergenza è il decreto 418, emesso il 18 marzo, che concentra nelle mani dello stato nazionale la gestione dell’ordine pubblico, come misura volta a contenere l’espansione del Covid-19. Tra la confusione generata dal decreto nazionale nelle diverse regioni colombiane, che ha messo in dubbio e costretto a modificare le direttive già attivate dalle singole autorità locali, si è imposta con forza la voce di Claudia Lopez, sindaca di Bogotà. La sua iniziativa di applicare all’intera capitale un “simulacro di quarantena” della durata di tre giorni, dal 21 al 23 marzo, ha generato una pressione politica tale da costringere Duque all’istituzione del lockdown nazionale a partire dal 24 marzo. Durante il primo giorno di quarantena centinaia di persone sono scese in strada a Suba, nel nord-est di Bogotá, sfidando l’obbligo di restare in casa e protestando per la scarsità di risorse e alimenti per affrontare l’emergenza che ha lasciato senza un ingresso economico l’intero settore dei lavoratori informali, venditori ambulanti e impiegati nel settore delle costruzioni.
Altrettanto polemico è stato il decreto 444, che centralizza in un Fondo di Mitigazione dell’Emergenza (Fome) risorse delle regioni e del sistema pensionistico per far fronte all’emergenza Covid-19. Claudia Lopez ha puntato nuovamente il dito contro Duque dichiarando che il governo intendeva utilizzare i soldi degli enti territoriali per garantire liquidità a banche e imprese. Diversi sindaci del paese hanno denunciato che questa misura ridurrà le risorse di cui dispongono le amministrazioni locali per garantire rifornimento di alimenti, accesso ai medicinali e funzionamento dei servizi di salute durante la quarantena. Non è un dato minore che nelle elezioni di comuni e dipartimenti dello scorso 27 ottobre sia uscito sconfitto il Centro Democratico, il partito di Uribe che era riuscito a imporre Duque come presidente nel 2018. Lo scacchiere politico nazionale ha subito una torsione che ora, con la gestione della pandemia, mostra tutti gli attriti tra governo nazionale e poteri locali.
Ad aggravare la situazione, anche il programma di aiuti economici messo in atto dal governo è stato oggetto di uno scandalo a inizio aprile, quando diversi cittadini hanno cominciato a denunciare sui social le irregolarità nell’assegnazione dei sussidi attraverso la piattaforma web dedicata, che accettava come beneficiari identità di persone inesistenti o scomparse. Inoltre la Procura Generale ha aperto un fascicolo sul ministro dell’Agricoltura Rodolfo Zea, per presunta corruzione nell’assegnazione di fondi destinati a garantire la produzione agricola durante la pandemia. In questo contesto, la Colombia ha richiesto e ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale un credito di circa 10.800 milioni di dollari per far fronte alla diffusione del Covid-19.
A partire da metà aprile si sono svolte nuove manifestazioni in diversi punti del paese nonostante la quarantena, in alcuni casi con blocchi stradali e requisizione di autobus, per reclamare gli aiuti promessi dalle autorità di fronte alla crisi e mai arrivati, e denunciare come le condizioni di sopravvivenza senza un reddito si stiano facendo insostenibili per una gran parte della popolazione urbana del paese. La prima risposta è stata autoritaria e in molti dipartimenti a disperdere le manifestazioni sono intervenuti gli squadroni dell’Esmad, forza di polizia già duramente contestata per il suo agire violento durante le proteste di novembre e dicembre scorsi.
In parte diversa è la situazione delle zone rurali e della selva, tanto nel nord come nella zona del Cauca e nel sud-est del paese, dove le organizzazioni indigene e contadine hanno preso tempestivamente decisioni autonome rispetto alle direttive del governo per far fronte all’espansione dei contagi, chiudendo l’accesso alle comunità e preoccupandosi dell’autosufficienza alimentare, oltre a implementare protocolli di sicurezza sanitaria e cercare di arginare la presenza di gruppi armati. Ciononostante lo sviluppo del contagio sta mettendo in difficoltà anche le comunità, che a più riprese sono intervenute pubblicamente reclamando allo stato le misure minime necessarie per affrontare la crisi.
Un altro settore fortemente colpito dall’incapacità del governo di gestire la pandemia è quello della sanità, dove medici e infermieri stanno lavorando senza la strumentazione minima necessaria per il trattamento dei pazienti contagiati. Il 9 aprile hanno rinunciato al loro incarico 22 medici della clinica San José de Torices a Cartagena denunciando l’impossibilità di svolgere il loro lavoro nel pieno della pandemia, seguiti il 20 aprile da un’altra trentina di medici dell’ospedale San Rafael nel dipartimento di Amazonas. La risposta del governo, il 13 aprile, è stata il decreto 538, che ha scatenato le proteste di 35 organizzazioni sindacali nel paese: la direttiva obbliga lavoratori della salute e studenti dell’ultimo anno a compiere le loro funzioni durante la crisi epidemica, senza però garantire loro gli elementi di protezione contro il virus.
Le proteste si sono concentrate con forza anche nelle carceri di tutto il paese. Già a partire dal 15 marzo tra i detenuti così come da parte delle organizzazioni dei diritti umani si è reclamato l’intervento dello stato per prevenire il contagio di Covid-19 nei centri di reclusione, dove non sono state distribuite né mascherine, né guanti o sapone, mentre in alcuni centri è insufficiente anche la somministrazione dell’acqua. In particolare il carcere di Villavicencio presenta un livello di sovraffollamento del 101,9% che ha permesso al contagio di diffondersi esponenzialmente: attualmente il centro supera i 400 casi e sono già morte 3 persone. L’apice delle proteste è avvenuto la notte del 21 marzo quando, nel carcere La Modelo di Bogotá, la rivolta è stata repressa con una violenza spropositata che ha lasciato 23 morti e 83 feriti. Il governo ha emesso il 14 aprile il Decreto 546 per la scarcerazione di alcune categorie di detenuti che però risulta del tutto insufficiente (coinvolge il 5% della popolazione carceraria) e discriminatorio (per i criteri di selezione dei beneficiari), tanto che anche la Corte Costituzionale è intervenuta indagando il rispetto dei diritti umani nel testo del decreto, mentre sarebbe sufficiente l’applicazione del codice penale per migliorare le condizioni inumane di sovraffollamento in cui le carceri vengono mantenute da anni, nonostante i costanti reclami.
Attualmente in Colombia si sono registrati 378 morti e 8.613 contagi, di cui 6.222 sono attualmente attivi, e la percentuale di 7 vittime per milione di abitanti è piuttosto bassa, soprattutto se confrontata con la situazione di altri paesi del continente. Allo stesso tempo però è cresciuto il numero di morti per omicidio tra i leader sociali e tra gli ex-guerriglieri, questo è forse il più grave tra i problemi che sta affrontando il paese durante la pandemia, e che non si è placato ma anzi si è aggravato con l’isolamento obbligatorio della popolazione in casa. L’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), gruppo guerrigliero ancora in azione sul territorio, ha dichiarato un cessate al fuoco durante il mese di aprile come gesto umanitario a causa della pandemia che già a fine marzo investiva il paese, e invitava al dialogo il governo di Duque per gestire l’emergenza. La violenza però non è diminuita e si sono moltiplicati gli appelli di organismi internazionali come l’ONU per garantire protezione a ex-guerriglieri e leader contadini che vengono uccisi nelle loro case, aumentando la violenza di un massacro che il paese registra almeno dal 2016, quando sono stati firmati gli accordi di pace con le FARC. Molti istituti di difesa dei diritti umani hanno richiamato il governo colombiano a garantire l’incolumità di tutte le persone impegnate nella costruzione del processo di pace e delle loro famiglie, e hanno preteso che si faccia chiarezza negli oltre 70 omicidi perpetrati dall’inizio del 2020. “In Colombia il virus più pericoloso è la guerra” si legge nella campagna di denuncia lanciata dall’Associazione Censat – Agua Viva nel paese in cui gli omicidi che ostacolano il processo di pace sono il doppio dei morti per coronavirus.
6 maggio 2020
l’America Latina
| Fabrizio Lorusso, “Come reagisce l’America Latina al Covid-19? Bolivia, Perù e Colombia” pubblicato il 06/05/2020 in l’America Latina, su [https://fabriziolorusso.wordpress.com/2020/05/06/come-reagisce-lamerica-latina-al-covid-19-bolivia-peru-e-colombia/?fbclid=IwAR2pXe04LR19Eejul339Zg21nXjDO-BiERWq0OepIwen-d0UDb7i0RsfIyE] ultimo accesso 20-05-2020 |