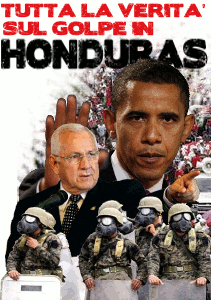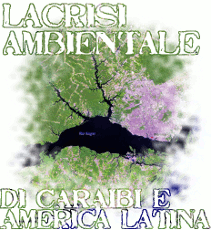Lo scorso 16 febbraio, il governo di Michel Temer ha consegnato la sicurezza di Río de Janeiro alle forze armate. Dai corpi di polizia fino ai pompieri e alle carceri, sono passati alla gestione dei militari. La scusa, come sempre, è la violenza e il narcotraffico; che esistono e sono enormemente pericolosi per la popolazione.
Río è una delle città più violente del mondo. Nel 2017 ci sono stati 6.731 morti e 16 sparatorie quotidiane con un saldo minimo di due persone morte in ciascuna, quasi sempre neri. Delle 50 città più violente del mondo, 19 sono brasiliane e 43 latinoamericane (goo.gl/CvnFQU). Contemporaneamente, il Brasile è tra i 10 paesi più disuguali del mondo, alcuni dei quali anche i più violenti, come Haiti, Colombia, Honduras, Panama e Messico (goo.gl/XPKd7Y).
Nel caso di Río de Janeiro, l’azione degli uomini in uniforme ha una caratteristica speciale: si focalizza nelle favelas, ossia vanno contro la popolazione povera, nera e giovane. Nelle 750 favelas di Río dove vivono un 1.5 dei 6 milioni di abitanti della città. I militari si pongono alle uscite e fotografano tutte le persone, le chiedono i documenti e verificano la loro identità. Mai era stato fatto questo tipo di controllo in modo così massiccio e così specifico.
Non è la prima volta che i militari si incaricano dell’ordine pubblico in Brasile. L’anno scorso a Río i militari sono intervenuti 11 volte, nel contesto delle missioni Garanzia della Legge e dell’Ordine (GLO), una legislazione che è stata applicata nei grandi eventi come le visite del Papa e il Mondiale di Calcio. Dal 2008, in 14 occasioni hanno assunto funzioni di polizia. Nonostante ciò, ora si tratta di un’occupazione militare che abbraccia tutto lo stato.
Molti analisti hanno messo in rilievo che l’intervento è destinato al fracasso, giacché i precedenti, anche se precisi, non ottennero un gran ché. Aggiungono il fracasso delle Unità di Polizia Pacificatrici (UPP), che a suo tempo furono glorificate come la grande soluzione al problema della insicurezza, giacché si installavano nelle stesse favelas, come una polizia di quartiere.
Contemporaneamente, gli analisti ricordano che la guerra contro le droghe in Messico è uno strepitoso fracasso, che per ora si è saldato con più di 200 mila morti e 30 mila scomparsi, mentre il narcotraffico è lontano dall’essere stato sconfitto e si è rafforzato.
 Nonostante ciò, credo che bisognerebbe segnalare che queste letture sono parziali, perché in realtà questi interventi sono sommamente di successo per raggiungere gli obiettivi non confessabili delle classi dominanti e dei suoi governi: il controllo e lo sterminio della popolazione potenzialmente ribelle e non integrabile. Questa è la ragione che in America Latina porta a militarizzare interi paesi, senza toccare la disuguaglianza, che è la causa di fondo della violenza.
Nonostante ciò, credo che bisognerebbe segnalare che queste letture sono parziali, perché in realtà questi interventi sono sommamente di successo per raggiungere gli obiettivi non confessabili delle classi dominanti e dei suoi governi: il controllo e lo sterminio della popolazione potenzialmente ribelle e non integrabile. Questa è la ragione che in America Latina porta a militarizzare interi paesi, senza toccare la disuguaglianza, che è la causa di fondo della violenza.
Penso che si siano quattro ragioni che confermano l’impressione che siamo di fronte ad interventi sommamente di successo, in Brasile, ma anche in Centroamerica, Messico e Colombia, per segnalare i casi più evidenti.
La prima è che la militarizzazione della sicurezza riesce a blindare lo stato come garante degli interessi dell’1 per cento più ricco, delle grandi multinazionali, degli apparati statali armati e dei governi. Bisogna domandarsi perché sia necessario, in questo periodo della storia, blindare quei settori. La risposta: perché due terzi della popolazione è all’intemperie, senza diritti sociali, a causa dell’accumulazione dovuta al saccheggio/quarta guerra mondiale.
Il sistema non dà nulla alle maggioranze nere (il 51 per cento in Brasile), indigene e meticce. Solo povertà e pessimi servizi sanitari, educativi e dei trasporti. Non gli offre lavoro degno né remunerazioni adeguate, le spinge alla sottoccupazione e alla così mal chiamata informalità. A lungo termine, una popolazione che non riceve nulla o quasi nulla dal sistema, è chiamata a ribellarsi. Per questo militarizzano, compito che per ora stanno compiendo con successo.
La seconda è che la militarizzazione su scala macro si integra con un controllo sempre più raffinato, che fa appello alle nuove tecnologie per vigilare da vicino e da dentro le comunità che considera pericolose. Non può essere casuale che in tutti i paesi sono i più poveri, ossia coloro che possono destabilizzare il sistema, coloro che stanno venendo controllati in modo più implacabile.
Appena un esempio. Quando “donarono” lamiere per le case nel Chiapas, si preoccuparono di dipingerle affinché dall’alto si potessero identificare le famiglie non zapatiste. Le politiche sociali che i progressisti lodano, fanno parte di quei modi di controllo che nei fatti funzionano come metodi di contro-sovversione.
 La terza questione è che il doppio controllo, macro e micro, generale e individuale, sta attanagliando le società in tutto il mondo. In Europa sono multe o carcere per coloro che escono dal copione. In America Latina è morte e scomparsa per coloro che si ribellano o, semplicemente, a coloro che denunciano e si mobilitano. Non si reprimono più solo coloro che si sollevano in armi, come negli anni 60 e 70, ma tutta la popolazione.
La terza questione è che il doppio controllo, macro e micro, generale e individuale, sta attanagliando le società in tutto il mondo. In Europa sono multe o carcere per coloro che escono dal copione. In America Latina è morte e scomparsa per coloro che si ribellano o, semplicemente, a coloro che denunciano e si mobilitano. Non si reprimono più solo coloro che si sollevano in armi, come negli anni 60 e 70, ma tutta la popolazione.
Questa mutazione delle modalità controllo, isolando e sottomettendo coloro che possono giungere ad essere ribelli, o non obbedienti, è uno dei cambiamenti più notevoli che il sistema sta applicando in questo periodo di caos, che può terminare con il capitalismo e il dominio dell’1 per cento.
La quarta sono delle domande. Che vuol dire governare quando siamo di fronte a forme di controllo che accettano solo di votar ogni quattro, cinque o sei anni? Che utilità ha mettere tutto l’impegno politico nelle urne se fanno frodi e lo consolidano con i militari nelle strade, come succede in Honduras? Non dico che non bisogni votare. Mi domando perché.
Si tratta di continuare a riflettere sulle nostre strategie. Lo stato è un’idra mostruosa al servizio dell’1 per cento. Questo non cambierà se noi giungeremo al timone del comando, perché al vertice della piramide continueranno gli stessi, con tutto il potere per allontanarci quando lo stimeranno conveniente.
2 marzo 2018
La Jornada
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Raúl Zibechi, “Brasil tras los pasos de México” pubblicato il 02/03/2018 in La Jornada, su [http://www.jornada.unam.mx/2018/03/02/opinion/016a2pol] ultimo accesso 05-03-2018. |