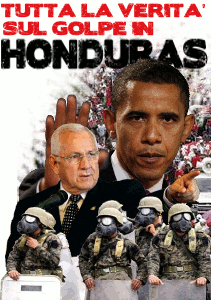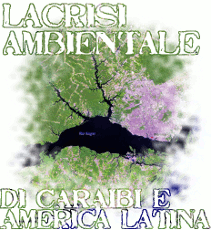Seconda puntata (qui la prima) del reportage da Rio de Janeiro, un anno dopo la fine del decennio dei grandi eventi globali che l’ha attraversata. Eravamo rimasti alla descrizione di Porto Maravilha, uno dei più grandi progetti di “rigenerazione urbana” dell’America Latina.
Seconda puntata (qui la prima) del reportage da Rio de Janeiro, un anno dopo la fine del decennio dei grandi eventi globali che l’ha attraversata. Eravamo rimasti alla descrizione di Porto Maravilha, uno dei più grandi progetti di “rigenerazione urbana” dell’America Latina.
In proposito l’autore ha riportato le parole di due persone: un attivista dei movimenti sociali coi quali si chiacchiera in un capannone occupato; col direttore del CEDUPR, ente pubblico insignito della gestione del progetto Porto Maravilha. L’articolo riparte da qui per poi riflettere sui “punti di vista” di Rio, sui suoi conflitti e le sue passioni.
Rio è una città fiera e orgogliosa, tantissimi mi dicono che i carioca non hanno mai accettato lo spostamento della capitale federale a Brasilia. Ha anche una forte appartenenza di quartiere, che ne fa una città a suo modo “provinciale”. Me lo dice Sandro: “Sai, in fondo Rio non è una città grandissima, non è una metropoli come São Paulo”. Certo, quando il termine di paragone sono i suoi 12 milioni (20 nell’area metropolitana) di abitanti contro i 6.5 (12 nell’area metropolitana) di Rio… Questione di punti di vista. Rio ha quindi una forte identità, unitaria e fratturata al contempo. La polarità tra il capannone di Roberto e la sala del CEDUPR, e quella fra le due Rio, la esprime bene. rappresenta uno dei sensi più profondi della città, anche se i bordi tra le due sono spesso porosi e ibridati e le favela rappresentano una normale eccezione a questa opposizione. A Rio d’altronde, più che altrove, la costitutiva molteplicità dei punti di vista che caratterizza le città letteralmente esplode in una miriade di frammenti. Nella sede del municipio, un edificio di taglio coloniale, c’è una mostra sulla cultura black con un ritratto di Malcom X, e lì fuori un homeless nero è accasciato in un angolo. Da un appartamento borghese sui promontori di Gloria degli accademici quarantenni fanno una festa, fumano marijuana guardando dalla finestra la favela sulla collina opposta, commentandomi il problema del trafico nella favela stessa (chissà dove l’avranno comprata l’erba!). Sono quelli che qui chiamano i “comunisti Nutella”, per indicare la sinistra hip e cool. Si passa per mercatini hipster a Botafogo o per i localini e gli atelier artistici della favela gentrificata di Santa Teresa o nei morbidi paesaggi di Ipanema, dove residenze altolocate inframmezzano il lembo di terra tra l’oceano e la laguna Rodrigo de Freitas. Il nuovo palazzo della Petrobras (la compagnia pubblica del petrolio) a Centro, fatto di vuoti e tagli, fa da compendio al grattacielo di vetro poco lontano, che riflette i colori di una favela. La curva di Copacabana sembra quella degli occhi di una donna che raccoglie mozziconi di sigaretta per strada, mentre la piazzetta europea di Laranjeiras si riempie di giovani universitari per l’aperitivo. Un’altra mendicante mulatta col volto emaciato e gli occhi profondi che guizzando di follia passa sotto i cavi elettrici che serpeggiano sulle strade attraversate da frotte di taxi, mentre in alcuni baretti bettola si beve duro ammassando bottiglie di birra sui tavolini in plastica e mangiando piatti con un mix di riso, fagioli, spaghetti e patate fritte con sopra fette di carne. E poi i mercati di frutta e verdure sconosciute, i ragazzi gangsta con tatuaggi, collanine d’oro, magliette del Flamengo e professionisti bianchi in smoking e ventiquattr’ore…
A Providência, arrivato alla fine di una scalinata ripidissima e variopinta, ho visto una donna nera che saliva sul tetto della sua abitazione, inerpicata su una scarpinata in cima alla collina, separata dalle altre e che non ci si può che chiedere come faccia a non crollare (mi dicono d’altronde con orgoglio che molti ingegneri vengono qui a studiare le stupefacenti tecniche costruttive della favela). Smuove un panno viola steso al sole, e per un attimo si volta nella direzione opposta a quella dove sono io. Provo a guardare col suo punto di vista. Si vedono tutti i grattacieli, il Cristo e il Pão de Açúcar, l’oceano in lontananza. Uno spettacolo, la vista dal grattacielo dei poveri. Non raccomandano di fermarsi col buio, ma da qui si vede la metropoli incendiata al tramonto dal sole accecante dell’inverno, che poi si accende dell’energia elettrica all’imbrunire in una sostituzione secca e mozzafiato che si estende all’infinito, con le luci che oscillano creando un movimento magnetico, inquieto e frizzante che ispira il silenzio. Si vede anche il piccolo aeroporto in mezzo alla baia Guanabara, con gli aerei che arrivano e partono laggiù in basso. L’acqua della baia è pressoché non balneabile per l’inquinamento, anche se da qui le sue onde illuminate dai fari delle spiagge nella notte sembrano ferme come uno splendido quadro e nonostante le promesse olimpiche contemplassero una mai avvenuta bonifica del grande bacino acqueo. Un altro atto profondamente ingiusto. Luiz mi spiega infatti che le spiagge non sono ancora state racchiuse e separate per le diverse classi sociali, e rappresentano in fondo i luoghi più democratici di Rio.
—
I punti di vista di Rio, dunque. Infiniti brandelli. Ma non collocati sullo stesso piano. Non sono tra loro equivalenti, bensì disposti lungo scale gerarchiche, composti come geroglifici terremotati. Ana Paula mi dice: “non vorrei risultare come una sciocca donna bianca middle class, ma preferirei davvero tu non andassi in certi posti”. Certo, Adriano mi racconta che a lui è capitato più volte di essere rapinato a Santa Teresa anche da ragazzini che ti puntano la pistola in faccia, ma sempre Ana mi spiega che oggi non è tanto questo il problema. È della polizia che bisogna avere più paura (stessa cosa dicono molti abitanti delle favelas: “La polizia non ha rispetto, entra nelle nostre case, ruba. I ragazzi del trafico sono del quartiere, a volte aiutano con le medicine, non ci rubano”). Se si guarda il quotidiano O Globo la prima pagina aggiorna ogni giorno sul numero di poliziotti uccisi. All’attuale siamo a oltre 100 da inizio anno qui a Rio, una media di uno ogni 57 ore, che si avvicina al precedente picco di uno ogni 53 ore raggiunto nel 2006, dando una macabra conferma di chi sostiene che “siamo tornati a dieci anni fa”.
André, che attualmente lavora presso il dipartimento pubblico Rio Cinema ma per anni ha fatto il giornalista, mi dice però di fare attenzione. Se si guarda “dentro la notizia” bisogna notare che molti di questi poliziotti non sono morti in servizio. Ma non perché la polizia sia inseguita sotto casa, quanto perché una delle sue attività note ma spesso ipocritamente taciute è la vendita di armi nelle favelas. Quando infatti si leggono notizie sui raid nelle favelas per il sequestro di armi, André mi spiega che la maggior parte delle armi sequestrate vengono illegalmente detenute dai poliziotti, che non le dichiarano e le rivendono ai traficantes. Quando qualche banda scopre che un poliziotto vende armi a un gruppo avversario, lo uccide.
Ma il punto è che ogni poliziotto ammazzato è spesso anche il frutto di un’incursione nelle favelas e in ogni caso dà il la a una rappresaglia di 1 a 20. A voi il calcolo totale dei morti. Più in generale uno dei discorsi che tiene banco sui media è sul ruolo che stanno svolgendo le UPP, giovani della Polizia Militare reclutati da poco e con scarso addestramento che svolgono il “lavoro quotidiano” nel territorio. A differenza di quei corpi speciali di cui si parla nei film Tropa de Elite, il cui vessillo svetta in una delle tante caserme che incontro nei quartieri: una bandiera nera con un teschio al centro. All’attuale sono 9000 le unità di UPP dispiegate in queste operazioni di controllo della città e nell’assedio a sette favelas in particolare. A Jacarezinho (un po’ più a nord del Maracanã), ci sono check point ovunque e militari armati fino ai denti presidiano il circondario. “Bisogna capire che c’è una guerra in corso” afferma Junior. Sono questi i termini del dibattito qui, come ascolto nella discussione “É guerra?” a Casa Pública, dove giornalisti ed ex poliziotti che ora hanno “cambiato campo” convergono sulla correttezza dell’utilizzo di tale concetto. Stessa cosa mi dice João, ex responsabile comunicazione del sindaco (!): “Chi di solito non usa la parola guerra sono i paesi che invadono altri paesi. Ma qui la polizia invade le favela, ci sono blindati granate mitragliatrici, stanno matando tutti i giorni!”. “Certo, qui nell’asfalto (modo per dire le parti non favelas della città) questa cosa non si sente, ma nelle comunità sì. Ed è ipocrita negare a quelle persone il diritto di chiedere di far finire la guerra”.
Mentre sono a pranzo con alcuni compagni non a caso un giovane insegnante di una scuola di Pavuna, ultima fermata della metro a nord ovest, me lo presentano dicendo “parla con lui che sta al fronte”, e poco dopo racconta dei due suoi studenti ammazzati quest’anno dalla polizia (insegna alle elementari). È infatti una logica di occupazione del territorio prettamente militare quella che caratterizza la polizia qui, ed è questa che contribuisce a rendere il Brasile uno dei paesi con più omicidi al mondo, decine e decine di migliaia ogni anno (circa 60 mila nel 2016). All’Observatório de Favelas mi dicono che i 154 morti di media al giorno superano i 149 che si registrano attualmente in Siria. Il dieci per cento delle persone assassinate ogni giorno al mondo è brasiliana. È questo il continuo “genocidio della gioventù negra e favelada” di cui mi raccontano più voci. Qualcosa che ricorda, su differenti proporzioni, quanto avviene nell’America del nord, a segno che la lacerazione schiavistica non è mai scomparsa in tutto il continente. “Devi però capire che le favelas sono tenute così”, mi dice André, perché la classe media (che qui si usa per indicare la il 5% della popolazione più benestante), “quelli come me”, non vuole che i loro figli vadano a scuola con i favelados. Ha paura che salti il confine tra favelas e il resto di Rio. Un confine che “è già molto permeabile, la cultura di Rio è fortemente influenzata dalle favelas, guarda come si vestono i giovani, l’importanza della musica, il modo in cui parliamo la lingua…”.
—
Non a caso in un bel libro, “Rio de Janiero: la furia e la danza” l’autore, Luiz Eduardo Soares, che ha avuto in passato due incarichi nei dipartimenti di giustizia per riformare la polizia, conclude l’ultimo capitolo in maniera inaspettata schierandosi contro la polizia e dalla parte del black bloc che nel 2013 durante l’onda dei movimenti contro la crisi aveva coinvolto anche il Brasile, poco dopo piazza Taksim in Turchia. Le giornate di giungo, mentre milioni di brasiliani erano scesi per le strade, erano state anche il momento nel quale per la prima volta i giovani delle favelas avevano potuto attraversare liberamente la città e praticare un confronto con la polizia che, visti i numeri e la visibilità della protesta, non poteva sparare ad altezza d’uomo al primo accenno di rischio, come di solito abituata a fare. Quella rivalsa giovanile nel salire sui carri blindati del Bope che di solito attraversano le favelas smitragliando grazie all’impreparazione della polizia al conflitto di piazza aveva dunque riscosso un diffuso consenso.
Per comprendere queste posizioni basta guardare una foto, dice César mostrandomi un’immagine istituzionale della Corte di giustizia brasiliana. Una quarantina di membri. Tutti bianchi. In uno dei paesi più mezclados del mondo. “È uno dei lasciti della fine del regime militare nel 1988, questa democrazia autoritaria dove viviamo impiantata dai militari” riflette Talita. “Il razzismo istituzionale struttura la storia dello Stato brasiliano”, continua César, e quindi “non è tanto Rio a essere dividida, è lo Stato brasiliano a esserlo”. Certo, le sfumature del colore della pelle col declinare del meridione al settentrione si rivelano con una certa nettezza, inscurendosi progressivamente più ci si allontana dal sud benestante. Ma il punto, come mi raccontano alcuni attivisti della ONG Rio on Watch, è che lo Stato devolve più fondi per finanziare la polizia di quanti ne investa in educazione e sanità messe assieme.
Un professore dell’UFRJ (dove gli stipendi non vengono pagati da tre mesi), che arriva stranamente in orario all’appuntamento in questo luogo in cui la giunzione tra i tempi della metropoli e quelli tropicali dilata al massimo i ritmi, mi dice che nelle favelas ovviamente sparano, e in quella vicino a casa sua ieri notte hanno fatto fuoco un sacco… anche se solo verso il cielo e per festeggiare la vittoria del Fluminense. Beppo, un professore italiano qui da anni con una storia legata all’autonomia dei Settanta, mi fa sentire su Whatsup una registrazione di un confronto a fuoco vicino all’università qualche settimana fa. Dovevamo andare a fare un giro per Rocinha una domenica, ma il giorno prima il suo contatto dice che è meglio rimandare. La mattina capisco il perché, quando su Facebook vedo girare un sacco di video di intensissime sparatorie proprio a Rocinha, come d’altra parte segnala l’app OTT (Onde tem tiroteio, costante monitoraggio sui conflitti armati in corso a Rio). Ma molte persone a Rio hanno imparato a riconoscere le armi dal suono degli spari. Tuttavia la questione è che il quarto della popolazione che vive nelle favelas, sotto assedio in luoghi splendidi e degradati al tempo stesso, scrive sui muri: “i ricchi chiedono la pace per continuare a essere ricchi, noi chiediamo la pace per continuare a essere vivi”. L’ho vista a Santa Marta, una piccola favela di Botafogo, creola come tante altre parti della città, alla quale si arriva dopo aver attraversato ampie aree residenziali con palazzi tutti cintati da cancellate, inferriate e filo spinato, emblemi dell’urbanesimo-fortezza del modernismo brasiliano degli anni Ottanta. Lungo una strada che costeggia una parete rocciosa ci sono varie scritte: A rua è tua!; Fora Temer!; Aborto ilégal: ricas abortam pobres morrem; e una contro Marcelo Crivella, il nuovo sindaco ex vescovo evangelico che sta tagliando i soldi alle scuole di samba delle favelas per boicottare la “festa peccaminosa” del Carnevale… Poi per le ruas intricate si incontra la variegata umanità del pueblo, dura, affascinante, ricca e contraddittoria, radicalmente altra rispetto a quella dei rooftop nei quartieri ricchi. Ecco un’altra delle contraddizioni evidenti che attraversano e mettono in forma Rio. Tra questi mondi popolari e la global class che possiede le zone pianeggianti. Qui tutti vogliono bere birra Heineken, ascoltano le hit estive che sentiamo anche in Europa, usano Whatsup negli smartphone ultimo modello, prendono il caffè da Starbucks e mangiano sushi, guardano serie tv su Netflix, ragionano di business e start up, e parlano della cordialidade brasilera, l’unico paese dell’America Latina a non aver avuto rivoluzioni, come se la violenza endemica quasi non esistesse, se non come fastidioso rumore di fondo…
—
Rio in definitiva è un quartiere pazzesco della metropoli planetaria nella quale viviamo. Riesce a contenere, in forma instabile, tellurica, aperta, una quantità spasmodica di contraddizioni. Non siamo a Parigi o Londra, dove la storia urbanistica ha già da molti decenni costruito i confini più o meno visibili tra centri e periferie in maniera netta. Non siamo nelle nuove metropoli cinesi erette ex novo dove sono progettate da principio le gradazioni gerarchiche dell’abitare sociale, né nelle inedite agglomerazioni urbane africane dove si sta confusamente costruendo uno dei più importanti nuovi pezzi di storia della città nel proliferare di slum e gated community. Non siamo nemmeno a Chicago o New York, dove dagli anni Settanta le core zone sono state comprate a basso costo dal capitale finanziario per farne altrettanti snodi per i flussi globali. A Rio la sensazione è quella di una conflittualità indecisa, dove gli avamposti dei ricchi e quelli dei poveri si guardano negli occhi per determinare le centralità.
Ad ogni modo, per queste che non sono altro che note impressionistiche su questa metropoli dalle passioni forti, Rio ha molto da insegnare. Insegna perché è giusto amare nelle sue notti. Spiega perché è giusto tagliare le sue complessità nel lottare per l’eguaglianza sociale contro le sue violente ingiustizie. Fa capire perché si odia la polizia che da piazza Indipendenza a Roma fino a Jacarezinho svolge lo stesso ruolo di schiacciare le povertà, tentando di cancellarne lo sguardo molteplice dal volto delle città.
nc, Rio de Janeiro, agosto/settembre 2017
28 settembre 2017
InfoAut
| “Quando si spengono i riflettori dei grandi eventi (2) – Rio de Janeiro tra fantasmagorie globali e guerra ai poveri” pubblicato il 28-09-2017 in InfoAut, su [https://www.infoaut.org/approfondimenti/quando-si-spengono-i-riflettori-dei-grandi-eventi-2-rio-de-janeiro-tra-fantasmagorie-globali-e-guerra-ai-poveri] ultimo accesso 05-10-2017 |