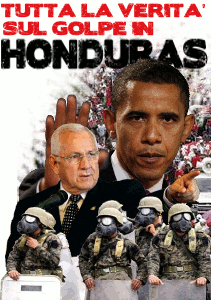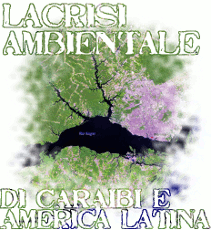In occasione dell’uscita del volume quarto di Autonomi edito da Derive Approdi riprendiamo l’intervista a Giorgio Ferrari pubblicata sul sito “Giorni che valgono anni – cronache immagini e racconti dal ’77 romano”
In occasione dell’uscita del volume quarto di Autonomi edito da Derive Approdi riprendiamo l’intervista a Giorgio Ferrari pubblicata sul sito “Giorni che valgono anni – cronache immagini e racconti dal ’77 romano”
Nel libro parli del vostro modo di “essere compagni tra i compagni”, del differente approccio al lavoro di massa che vi distingue dagli autoproclamati dirigenti del movimento (che siano dei gruppi, degli “undici” o di una delle tante riviste della galassia autonoma), un metodo che ripropone il classico schema prassi-teoria-prassi in anni in cui la verbosità della sinistra extraparlamentare rende questo approccio inconsueto.
Il rischio che vedo è quello di ridurre questo aspetto quasi a una differenza antropologica, per questo mi interesserebbe capire in che misura e in che modo lo “stile di militanza” (o metodo politico) che avete espresso è, dal tuo punto di vista, condizione specifica e irripetibile e in che forme invece è riproponibile oggi.
Giorgio Nel libro ho cercato di dare un’idea dell’ambiente politico-culturale che si era consolidato a partire dagli anni ’60 all’interno delle organizzazioni rivoluzionarie. Un ambito molto ricco di analisi e fortemente ideologizzato che aveva dato vita ad una formazione del pensiero marxista (o neo marxista, secondo alcuni) di grande intensità. Dentro questo contesto la difformità della nostra esperienza è stata sia teorica che pratica, ma non chiamerei in causa l’antropologia quanto, invece, la pedagogia.
L’essere compagni tra compagni rimanda ad un aspetto della politica che non può che definirsi pedagogico se con questo intendiamo, non tanto l’ambito educativo, ma quello formativo. Che il compito sia la formazione dell’uomo nuovo di Gramsci o la nuova umanità di ispirazione anarchica, è indubbio che l’azione politica se ne debba far carico. Ma come agire questo processo di formazione delle masse? E prima ancora: come formare chi formerà le masse (cioè compagne e compagni)?
Questi aspetti, in quegli anni, vennero gradatamente rimossi dai gruppi della sinistra rivoluzionaria o rinviati ad un inveramento politico organizzativo (il partito o comunque l’”Organizzazione”) che però rispondeva ad altre esigenze, prima fra tutte la presa del potere. In questo senso trovo emblematici i versi scritti da Luciano della Mea (non a caso) nel 1972
Può sembrare una questione secondaria se non addirittura astratta, ma non lo è se lo si rapporta al problema, ad esempio, della comprensione-adesione delle masse alle tesi di questi gruppi che spesso erano involute, cosa che accade anche oggi. Il fatto è che noi, noi compagne e compagni, ci poniamo (o almeno ci proviamo) all’altezza delle massime contraddizioni della vita; ne indaghiamo la complessità, ne sveliamo le trame ma poi non sempre riusciamo a renderle semplici ed esplicite. E’ cosa che riguarda il linguaggio, certo; ma il linguaggio è anche forma di comunicazione e se noi non riusciamo a infrangere i codici della comunicazione militante e a tradurli in concetti di massa, rischiamo di parlare solo a noi stessi perché, in definitiva, siamo detentori di un sapere separato e come tale lo esercitiamo. Invece dovremmo, come diceva Mao, “spiegare alle masse con precisione ciò che abbiamo ricevuto da esse con confusione”, sempre che -mi permetto di aggiungere- abbiamo correttamente interpretato il messaggio delle masse.
Altro aspetto pedagogico dell’essere compagni tra compagni è quello di non costituirsi come contraddizione per lo stesso corpo militante, sapendo rinunciare, se necessario, al proprio ruolo. E’ difficile, e non ci sono “regole” che aiutino a capire se e quando ciò vada fatto, ma è un tratto importante della militanza perché consente di sviluppare la partecipazione e la soggettività degli altri compagni/e. Se una leadership si pone come esempio inarrivabile od insostituibile agli occhi degli altri, essa ha fallito il suo obiettivo principale perché rischia di replicare gli stessi processi che le élite dominanti usano nei confronti degli oppressi stabilendo una gerarchia della conoscenza avulsa dalla realtà e a diffondere, sia pure involontariamente, la cultura del “capo”.
L’irripetibilità a cui alludo nel libro non riguarda il nostro “stile di militanza” (che anzi è del tutto replicabile anche oggi) ma il contesto generale di quegli anni.
Una composizione di “operai senza mani callose” con il camicie o la tuta da elettrico, di disoccupati, di giovani proletari. La lotta travalica il luogo e il momento della produzione (o della formazione) e investe l’ambito riproduttivo: dalla casa, alle bollette fino all’accesso alla sanità e all’autodeterminazione femminile. Il territorio come spazio della circolazione del conflitto in cui motore della mobilitazione sono tanto i lavoratori tanto gli utenti, quanto gli abitanti dei quartieri. Un processo di ricomposizione di classe che non si dà intorno alla centralità di un soggetto ma nella materialità di alcune vertenze di massa che diventano punto di riferimento per una classe che (ri)scopre in quegli anni la crisi permanente che nel mercato del lavoro si traduce in disoccupazione strutturale e precarietà. Guardando all’esperienza di quel ciclo di lotte quali credi che fossero i punti di forza e quali i limiti? Come le realtà autonome si sono misurate con questa dimensione?
Giorgio Il tema della ricomposizione di classe, inteso come asse portante della lotta politica in quegli anni, era di per sé un punto di forza, ma sarebbe rimasto un enunciato teorico senza la disponibilità a lottare da parte dei proletari e senza la soggettività che noi vi immettemmo. Il primo aspetto rimanda, di nuovo, alla specificità del contesto storico; il secondo al metodo di intervento e questo, a sua volta, si basava su due aspetti principali: la condizione proletaria e il rapporto che avevamo stabilito con essa.
Il mancato soddisfacimento di bisogni diversificati da parte dei proletari costituiva il complemento delle rivendicazioni che animavano le lotte nei luoghi di lavoro, sul salario, sull’organizzazione del lavoro o sulla nocività. E non si trattava solo di bisogni “primari” (casa, servizi etc) ma anche di quelli che con la riproduzione “biologica” della forza lavoro avevano poco a che fare come il vestiario, divertimento o generi vari considerati di lusso. Se questa società sforna continuamente merci luccicanti presentandocele come uno status simbol, perché non vi possono accedere i proletari? Perché, si diceva, non pasteggiare anche noi a champagne, non poter andare a un concerto perché il biglietto costa troppo o essere costretti a comprare i vestiti a Porta Portese? Insomma oltre al pane volevamo anche le rose, ma non per vivere, in definitiva, come i ricchi, quanto per rendere esplicito il feticismo della merce annullandone, attraverso la riappropriazione diretta, il suo valore di scambio e farne risaltare il suo valore d’uso. Se la base di partenza infatti era il soddisfacimento dei bisogni, il punto di arrivo riguardava la critica alla società della merce, il discernere tra bisogno e consumo, il suo farsi elemento qualificante di una società liberata dallo sfruttamento.(1)
L’altro punto di forza era l’internità alla condizione proletaria e la piena conoscenza del territorio. Ciò che avveniva nei quartieri era monitorato costantemente e quando qualcosa ti sfuggiva, erano i proletari a dartene informazione perché, appunto, si riconoscevano in quello che facevi. Lo stesso accadeva nei posti di lavoro, quando capitava che un lavoratore veniva a dirti cosa succedeva nel suo reparto o magari di un provvedimento della direzione che ti era sfuggito perché, anche se non aderiva del tutto alle iniziative che proponevi, riconosceva la tua funzione di contrasto e se ne sentiva complice. Ma per ottenere tutto questo occorsero impegno, costanza e preparazione. Non a caso dedicavamo particolare attenzione al dibattito interno all’organizzazione che si sviluppava sia dentro i collettivi che nelle discussioni plenarie (gli attivi dei militanti) svolte con frequenza costante e a cui partecipavano ogni volta dai 200 ai 300 compagni/e.
Quanto ai limiti essi furono principalmente dovuti all’insufficienza dei mezzi a nostra disposizione rispetto alle necessità che avevamo di fronte e questo era evidente soprattutto fuori dell’ambito cittadino in quanto si richiedeva una disponibilità e una mobilità dei compagni a tempo pieno che non potevamo permetterci. A differenza di oggi, dove i mezzi di comunicazione consentono di interagire facilmente con situazioni anche lontane, all’epoca -per intessere relazioni- dovevi muoverti di persona, recarti in un posto, incontrare gente.
Un elemento ricorrente nel libro è la critica all’insurrezionalismo, alla idea che l’Italia fosse ad un passo dal ritorno al fascismo o viceversa all’alba della rivoluzione proletaria. Questa critica estende ben oltre le forme della clandestinità e della lotta armata la distanza dalle organizzazioni combattenti. Come questa critica si è coniugata con la necessità dell’uso della forza? Come avete inteso il rapporto tra le temporalità delle lotte quotidiane e i momenti di piazza più intensi, “i giorni che valgono anni”?
Giorgio Oddio, l’uso della forza! Dopo la saga di Guerre Stellari mi sembra sempre più difficile parlarne, anche se devo riconoscere che l’idea di “forza” suggerita dal film è molto suggestiva.
Parlando seriamente, la nostra idea di uso della forza era intimamente connessa all’effettiva esistenza di due società contrapposte. Al di fuori di questo dualismo reale la forza si esplicitava quasi esclusivamente come contrapposizione di idee, e dunque come simulazione di un conflitto ancora tutto da costruire. Il problema era, in una fase che noi consideravamo ancora pre-rivoluzionaria, come applicare la forza e come renderne il suo esercizio sistematico da parte di sempre più larghi settori di classe. Due i principi guida che avevamo adottato: proporzionalità dell’azione e sua replicabilità.
Rompere un uovo con un martello è uno spreco di energie e si rischia anche di non poterlo nemmeno utilizzare per farci una frittata. Ma se devo rompere una noce di cocco, allora la sola forza delle mani non basta.
L’azione poi deve poter essere, possibilmente, quanto più riproducibile sia per tipologia di mezzi impiegati che per capacità delle persone ad usarli. In buona sostanza direi che di Cavalieri Jedi è meglio farne a meno perché, nel bene e nel male, la loro esistenza separa l’uso della forza dalla sfera più propriamente politica che poi porta alla specializzazione e alla compartimentazione delle funzioni che si è sempre rivelata deleteria. Come diceva Lenin, le baionette sono indispensabili, ma è la politica che deve stabilirne l’impiego.
Quanto al rapporto tra quotidianità delle lotte e scontri di piazza il nesso era molto stretto, non solo perché si trattava in larghissima parte degli stessi soggetti, ma perché il livello di scontro nei luoghi di lavoro, fatte le dovute proporzioni, non era poi così dissimile da quello di piazza: vedere una carica di polizia fra le corsie di un ospedale era più violento di un blindato lanciato contro un corteo di manifestanti; qualcosa di osceno che mi richiama alla mente l’incursione alla Diaz, con la differenza che a Genova la polizia fu decisamente più brutale.
“Autonomia”, come noti giustamente, è un concetto assimilato da alcuni a un mero “fenomeno comportamentale” e da altri a una “premonizione della teoria marxista”, queste due interpretazioni hanno trovato negli ultimi anni un certo successo editoriale, forse perché di fatto ne inibiscono il portato sovversivo… Tu invece proponi di considerare l’autonomia una “categoria strutturale” dentro un processo duplice di costruzione del nuovo e di distruzione del vecchio che o si da contestualmente o finisce per darsi su uno solo dei due poli. In questo processo che ruolo svolge l’organizzazione politica? Ci sono esperienze in giro per il mondo o dalle nostre parti che anche limitatamente a singoli aspetti ti sembrano assolvere a questa funzione?
Giorgio L’organizzazione politica può essere assimilata ad una cellula embrionale che però non si riproduca per autopoiesi, ma interagisca con l’ambiente circostante fino a modificarlo del tutto. A quel punto la cellula scompare, non ha più ragione di essere perché la cellula è diventata il tutto.
Detto così è facile, ma in pratica è tutta un’altra cosa perché, l’ambiente circostante reagisce all’azione della cellula e il risultato finale può anche portare alla “morte” della cellula, oppure ad una indesiderata mostruosità.
Fuor di metafora l’organizzazione politica è lo strumento principale di cui si può disporre, ma secondo il nostro punto di vista non deve mai anteporsi al fine che abbiamo stabilito che non è solo (si fa per dire!) quello di prendere il potere con la rivoluzione, ma di cambiare le persone: e non è mai troppo presto per cominciare a farlo.
Alcune esperienze ci sono state nel mondo, penso all’Argentina e alla Grecia, ma come rilevi tu uno dei due poli ha finito per prevalere finendo per replicare meccanismi già noti e minoritari: o l’ennesimo partitino, o un movimento di opinione che fa dell’autarchia sociale uno scudo protettivo. Credo che in definitiva nelle esperienze della Zanon argentina o della Vio.me greca sia mancata proprio l’essenza della proposta autonoma, la sua strutturale potenza moltiplicatrice che avrebbe condotto queste “cellule embrionali” verso ben altri risultati politici. In Bretagna poi c’è l’esperienza di Notre-Dame-des-Landes e in Italia, ovviamente, la Val Susa, ma non saprei dire quanto i compagni abbiano investito sul potenziale della proposta autonoma, né tantomeno se condividano quello che era il nostro punto di vista.
Nel libro emerge un antagonismo senza possibile mediazione tra il movimento e il partito comunista e il sindacato. Volendo cercare la data simbolica di questo antagonismo sicuramente la cacciata di Lama rappresenta il momento più noto e clamoroso di uno scontro quotidiano in cui i militanti del pci e del sindacato si distinguono per delazione e crumiraggio sui posti di lavoro tanto quanto per la diffamazione a mezzo stampa. D’altra parte sarebbe sbagliato pensare all’autonomia romana come “esperienza autistica” rispetto alla storia del movimento di classe. A titolo di esempio mi pare significativo il rapporto con alcune figure storiche della resistenza antifascista (di cui più d’uno straccerà la tessera del partito). Come descriveresti il vostro rapporto con la “sinistra”?
Giorgio Nel libro parlo della esperienza romana come di un’anomalia nell’anomalia generale rappresentata dall’Autonomia nei confronti della sinistra storica. In qualche modo (ed estremizzando) si può dire che noi abbiamo tentato di costituire la negazione del concetto di sinistra che si era consolidato, almeno dal secondo dopoguerra in poi. La frattura epistemologica di cui parlo in relazione al significato che noi davamo all’Autonomia era perciò in antitesi con tutto ciò che la sinistra rappresentava in quel periodo. Faccio degli esempi: nel novembre del 1975, all’indomani della proclamazione dell’indipendenza dell’Angola, convocammo una manifestazione di appoggio al Mpla in cui, tra i punti di richiamo, c’era quello di essere “contro l’imperialismo comunque colorato” e quattro anni dopo, a seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan, ne convocammo un’altra che doveva terminare sotto l’ambasciata dell’Urss. Una cosa mai successa a sinistra, ma a nessuno venne in mente di assimilarla alle gazzarre che solitamente imbastiva la destra sull’argomento, perché il segno che avevamo impresso alla nostra critica era inequivocabile ed estremo. Sul nucleare il nostro maggiore avversario era il Pci e fu evidente che la rottura non stava nella contingenza di una scelta tecnologica, ma sul concetto di scienza e di progresso per di più consumata non all’interno di una cerchia ristretta di saperi, ma di fronte a quelle masse su cui il Pci esercitava non poca influenza. E il risultato fu che proprio a causa della scelta filonucleare del Pci, molti dei suoi iscritti o simpatizzanti lo abbandonarono.
Salvo qualche sporadica convergenza (a livello periferico) sul tema dell’antifascismo, il contrasto col Pci era totale. Del resto quale dialettica poteva darsi tra noi se il più grande partito comunista in Europa arrivava a scrivere un fondo sulla prima pagina dell’Unità dal titolo: “Se comandasse Pifano”?
Erano letteralmente ossessionati dai Volsci e noi ci guardammo bene dal guarirli da questo stato psicologico.
La questione ambientale: tra imbroglio ecologico e lotta alle nocività. La lotta contro il nucleare ha rappresentato un’anticipazione importante di una tematica che ha impegnato i movimenti e diversi territori in questi 40 anni. Alla luce di ciò quale è l’attualità dell’approccio autonomo alle vertenze ambientali?
Giorgio Hai fatto bene a ricordare le lotte contro la nocività perché ebbero una grande importanza che travalicò i confini della fabbrica. Ma queste purtroppo, appartengono al passato e lo testimoniano la diffusione delle patologie da lavoro oltre che le morti da e per il lavoro.
Oggi sul tema dell’ambiente viviamo questa situazione: l’ambientalismo tradizionale è in crisi perché -come avevamo denunciato 40 anni fa- è diventato parte del sistema e tutto si è spostato sul piano della gestione “politicamente corretta”.
L’agricoltura biologica è un business e le energie alternative pure. Ci tacitiamo la coscienza con i gruppi di acquisto solidale o con i prodotti a Km zero, ma non vediamo che il territorio, nel suo complesso, è la nuova frontiera dello sfruttamento del terziario. Il fatto è che la macchina del capitale è un tritatutto che ingloba anche le cose apparentemente più radicali (penso al veganismo) purché non venga intaccato il meccanismo di accumulazione. Solo una cosa non è in grado di riassorbire: la violenza di classe.
Senza di questa non c’è verso di appellarsi alla sopravvivenza della vita sulla terra perché, come scriveva Dario Paccino, l’ecologia è fondamentalmente ideologia della natura e come tale finisce anch’essa al servizio del capitale. Solo con forti iniezioni di materialismo si può invertire la tendenza il che vuol dire mettere in discussione la proprietà (per esempio occupando le terre); anteporre il bisogno al consumo; contrastare la mercificazione della natura oltre quella degli esseri umani: in definitiva si tratta ancora una volta di mettere il valore d’uso contro il valore di scambio. Qualche risultato significativo c’è, è vero, come quelli ottenuti da Campagne in lotta o dalle vertenze su discariche e inceneritori come nel caso dei Castelli romani, ma sono gocce in un mare di generale indifferenza.
Negli ultimi anni, soprattutto per l’insufficienza delle esperienze di mobilitazione nel mondo della formazione, diversi collettivi sono tornati a cimentarsi col intervento territoriale. Sono nati collettivi, soprattutto nel quadrante est, contro gli sfratti, sedi territoriali, comitati di quartiere. I Volsci fecero del l’organizzazione di massa nei quartieri proletari un intervento strategico cosa pensi sia utile riportare di quella esperienza cosa invece è ormai irrimediabilmente cambiato?
Giorgio Partiamo da un dato oggettivo: è cambiato (quasi) tutto. La composizione sociale; le forme di comunicazione; i bisogni; il controllo del territorio da parte dello stato e della criminalità e (non da ultimo) la soggettività di compagni e compagne. Che fare?
In questa situazione misurarsi col passato potrebbe risultare inconcludente oltre che ingeneroso e quindi, giocoforza, bisogna porre l’attenzione sul presente. Ma quale presente? Quello delle molte suggestioni del pensiero, o quello delle poche iniziative di lotta che ci sono? Bisogna prima sforzarsi le meningi, o aspettare che dalla realtà ci venga un segnale su cui poi decidere il da farsi?(2)
Ancora oggi non ho una risposta compiuta e definitiva. Penso però che del passato si possano utilizzare i metodi di lavoro che di volta in volta ne hanno caratterizzato i periodi. Tra questi c’è sicuramente quello della ricerca, dell’inchiesta politica che si fa metodo di intervento e da cui poi possono dipanarsi percorsi di lotta e di organizzazione. Un buon esempio è quello descritto da Danilo Montaldi in tempi in cui, tra l’altro, gli strumenti di indagine erano decisamente inferiori rispetto ad oggi; anche se oggi si tratta di capire come usare la grande potenzialità di questi strumenti che non di rado fungono da disincentivo rispetto all’impegno e alla partecipazione delle masse.
(1) L’argomento è complesso. Per un’analisi del rapporto tra bisogni, consumi e merce rimando a un mio saggio scritto nel 1982 dal titolo “Il tempo della politica e i meccanismi di riproduzione sociale”.
(2) “Fatti o parole, scienza o filosofia, teoria o prassi, esemplificano spesso l’umano dilemma tra il comprendere il mondo e l’agire su di esso come se l’una cosa escludesse l’altra in virtù di una consapevolezza a priori dell’efficacia di una tesi, ovvero dell’inefficacia dell’altra: non c’è azione che tenga senza prima aver compreso e, viceversa, è possibile comprendere solo dopo aver prodotto dei risultati.” Anche in questo caso rimando alla lettura del saggio “il tempo della politica e i meccanismi di risproduzione sociale” per una trattazione del tema.
01 Maggio 2017
InfoAut
| “1972-1992 l’Autonomia Operaia a Roma. Intervista a Giorgio Ferrari” pubblicato il 01-05-2017 in InfoAut, su [http://www.infoaut.org/index.php/blog/approfondimenti/item/18652-1972-1992-lautonomia-operaia-a-roma-intervista-a-giorgio-ferrari] ultimo accesso 01-05-2017. |