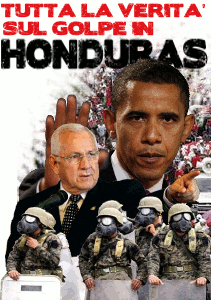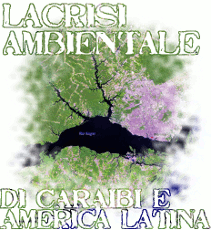La frenesia per un imminente mondo senza frontiere, il baccano per la costante riduzione degli stati-nazionali in nome della libertà d’impresa e la quasi religiosa certezza che la società mondiale avrebbe terminato di unirsi in un unico spazio economico, finanziario e culturale integrato, finiscono di crollare di fronte all’ammutolito stupore delle élite globalofile del pianeta.
La rinuncia della Gran Bretagna a continuare nell’Unione Europea -il progetto più importante di unificazione statale dei recenti cento anni- e la vittoria elettorale di Trump -che ha issato le bandiere di un ritorno al protezionismo economico, che ha annunciato la rinuncia ai trattati di libero commercio e ha promesso la costruzione di mesopotamici muri di frontiera-, hanno annichilito la maggiore e di grande successo illusione liberale dei nostri tempi. E che tutto questo provenga dalle due nazioni che 35 anni fa, indossate le loro corazze di guerra, hanno annunciato l’avvento del libero commercio e della globalizzazione come l’inevitabile riscatto dell’umanità, parla di un mondo che si è capovolto o, ancor peggio, che ha esaurito le illusioni che lo hanno mantenuto sveglio per un secolo.
La globalizzazione come meta-racconto, questo è, come orizzonte politico ideologico capace di incanalare le speranze collettive verso un unico destino che permetterebbe di realizzare tutte le possibili aspettative di benessere, è scoppiata in mille pezzi. E oggi al suo posto non esiste niente di mondiale che organizzi queste aspettative comuni. Ciò che si ha è un ripiegamento timoroso all’interno delle frontiere e il ritorno ad un tipo di tribalismo politico, alimentato dall’ira xenofobica, di fronte ad un mondo che non è più il mondo di nessuno.
La misura geopolitica del capitalismo
Chi ha iniziato lo studio della dimensione geografica del capitalismo fu Karl Marx. Il suo dibattito con l’economista Friedrich List sul “capitalismo nazionale”, nel 1847, e le sue riflessioni sull’impatto della scoperta delle miniere d’oro della California nel commercio transpacifico con l’Asia, lo situano come il primo e più diligente ricercatore dei processi di globalizzazione economica del regime capitalista. Di fatto, il suo apporto non risiede nella comprensione del carattere mondializzato del commercio che incomincia con l’invasione europea dell’America, ma nella natura planetaria espansiva della stessa produzione capitalista.
Le categorie di sussunzione formale e sussunzione reale del processo di lavoro al capitale con le quali Marx svela l’infinito auto-movimento del modo di produzione capitalista, presuppongo la crescente sussunzione della forza lavoro, dell’intelletto sociale e della terra, alla logica dell’accumulazione imprenditoriale; come dire, la subordinazione delle condizioni di esistenza di tutto il pianeta alla valorizzazione del capitale. Da lì il fatto che nei primi 350 anni della sua esistenza, la misura geopolitica del capitalismo ha proceduto dalle città-stato alla dimensione continentale e è passata, nei 150 anni successivi, alla dimensione geopolitica planetaria.
La globalizzazione economica (materiale) è quindi inerente al capitalismo. Il suo inizio può essere datato 500 anni fa, a partire dal quale dovrà aumentare ancora molto di più di densità, in modo frammentato e contraddittorio.
Se seguiamo gli schemi di Giovanni Arrighi, nella sua proposta di cicli sistemici di accumulazione capitalista guidata da uno stato egemonico: Genova (secoli XV-XVI), Paesi Bassi (secolo XVIII), Inghilterra (secolo XIX) e Stati Uniti (secolo XX), ciascuno di questi egemoni è stato accompagnato da una nuova maggiore consistenza della globalizzazione (prima commerciale, dopo produttiva, tecnologica, cognitiva e, alla fine, ambientale) e da una espansione territoriale delle relazioni capitaliste. Nonostante ciò, quello che sì costituisce un avvenimento recente all’interno di questa globalizzazione economica, è la sua costruzione come progetto politico-ideologico, speranza o senso comune; come dire, come orizzonte d’epoca capace di unificare le convinzioni politiche e le aspettative morali di uomini e donne appartenenti a tutte le nazioni del mondo.
La “fine della storia”
La globalizzazione come racconto o ideologia di un’epoca non ha più di 35 anni. Fu iniziata dai presidenti Ronald Reagan e Margaret Thatcher, liquidando lo stato del benessere, privatizzando le imprese statali, annullando la forza sindacale operaia e sostituendo il protezionismo del mercato interno con il libero mercato, elementi che dalla crisi del 1929 avevano caratterizzato le relazioni economiche.
Certamente, c’è stato un ritorno amplificato alle regole del liberalismo economico del XIX secolo, inclusa la connessione in tempo reale dei mercati, la crescita del commercio relativamente al prodotto interno lordo (PIL) mondiale e all’importanza dei mercati finanziari, che già sono stati presenti in quel tempo. Nonostante ciò, quello che sì ha differenziato questa fase del ciclo sistemico, che nel XIX secolo ha prosperato, è stata l’illusione collettiva della globalizzazione, la sua funzione ideologica legittimatrice e la sua esaltazione come presunto destino naturale e finale dell’umanità.
E coloro che si sono emotivamente affiliati a questa convinzione del libero mercato come salvezza finale non sono stati semplicemente i governanti e i partiti politici conservatori, ma anche i mezzi di comunicazione, i centri universitari, i commentatori e i dirigenti sociali. L’abbattimento dell’Unione Sovietica e il processo, che Antonio Gramsci ha chiamato trasformismo ideologico, di ex socialisti diventati furibondi neoliberali, ha chiuso il cerchio della vittoria definitiva del neoliberalismo globalizzatore.
Chiaro! Se di fronte agli occhi del mondo l’URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), che era considerata fino ad allora il referente alternativo al capitalismo della libera impresa, abdica alla lotta e si arrende di fronte alla furia del libero mercato -e perfino i combattenti per un mondo diverso, pubblicamente e in ginocchio, abiurano le proprie precedenti convinzioni per proclamare la superiorità della globalizzazione di fronte al socialismo di stato-, ci troviamo di fronte alla costituzione di una narrativa perfetta del destino “naturale” e irreversibile del mondo: il trionfo planetario della libera impresa.
L’enunciato hegeliano della “fine della storia” con il quale Francis Fukuyama ha caratterizzato lo “spirito” del mondo, aveva tutti gli ingredienti di una ideologia d’epoca, di una profezia biblica: la sua formulazione come progetto universale, il suo scontro con un altro progetto universale demonizzato (il comunismo), la vittoria eroica (fine della guerra fredda) e la riconversione degli infedeli.
La storia era giunta alla sua meta: la globalizzazione neoliberale. E, a partire da questo momento, senza avversari antagonisti da affrontare, la questione non era più lottare per un mondo nuovo, ma semplicemente regolare, amministrare e perfezionare il mondo attuale, non c’era alternativa di fronte a lui. Per questo, strategicamente nessuna lotta valeva la pena, tutto ciò che si fosse tentato di fare per cambiare il mondo, alla fine sarebbe finito per essere sottomesso di fronte al destino inamovibile dell’umanità, che era la globalizzazione. Allora è sorto un conformismo passivo che si è impadronito di tutte le società, non solo delle élite politiche e imprenditoriali, ma anche di ampi settori sociali che hanno aderito moralmente alla narrativa dominante.
La storia senza fine né destino
Oggi, quando risuonano ancora gli ultimi petardi della lunga festa “della fine della storia”, risulta che chi ne è uscito vincitore, la globalizzazione neoliberale, è morto lasciando il mondo senza finale né orizzonte vittorioso; come dire, senza alcun orizzonte. Donald Trump non è il boia dell’ideologia trionfalista della libera impresa, ma il medico legale al quale tocca ufficializzare un decesso clandestino.
I primi scivoloni dell’ideologia della globalizzazione si fanno sentire agli inizi del XXI secolo in America Latina, quando operai, plebei urbani e indigeni ribelli disattendono il mandato della fine della lotta di classe e si uniscono per prendere il potere dello stato. Combinando maggioranze parlamentari con l’azione di massa, i governi progressisti e rivoluzionari forniscono una varietà di opzioni post-neoliberali, mostrando che il libero mercato è una perversione economica suscettibile di essere rimpiazzata da modi di gestione economica molto più efficienti per ridurre la povertà, generare uguaglianza e promuovere crescita economica.
Con questo, la “fine della storia” comincia a mostrarsi come una singolare truffa planetaria e di nuovo la ruota della storia -con le sue inesauribili contraddizioni e opzioni aperte- si mette in marcia. Successivamente, nel 2009, negli Stati Uniti, il fin allora vilipeso stato, che era stato oggetto di scherno essendo considerato un ostacolo alla libera impresa, è tirato per la manica da Barack Obama per statalizzare parzialmente la banca e tirar fuori dalla bancarotta i banchieri privati. L’efficientismo imprenditoriale, colonna vertebrale dello smantellamento statale neoliberale, viene così ridotto in polvere di fronte alla propria incompetenza nell’amministrare i risparmi dei cittadini.
Dopo viene il rallentamento dell’economia mondiale, ma in particolare del commercio da esportazioni. Durante i recenti 20 anni, questo cresce il doppio del prodotto interno lordo (PIL) annuale mondiale, ma a partire dal 2012 giunge appena a uguagliare la crescita di questo ultimo, e già nel 2015 è anche minore, per cui la liberalizzazione dei mercati non costituisce più il motore dell’economia planetaria né la “prova” dell’irresistibilità dell’utopia neoliberale.
Da ultimo, i votanti inglesi e statunitensi fanno inclinare la bilancia elettorale a favore di un ripiegamento verso stati protezionisti -se è possibile murati-, oltre a rendere visibile un malessere, già planetario contro la devastazione delle economie operaie e di classe media, causato dal libero mercato planetario.
Oggi, la globalizzazione non rappresenta più il paradiso desiderato nel quale si depositano le speranze popolari né la realizzazione dell’anelato benessere familiare. I medesimi paesi e le medesime basi sociali che decenni fa l’hanno inalberata, si sono trasformati nei suoi maggiori detrattori. Ci troviamo di fronte alla morte di una delle maggiori truffe ideologiche dei recenti secoli.
Nonostante ciò, nessuna frustrazione sociale rimane impune. C’è un costo morale che, in questo momento, non porta alla luce alternative immediate ma -è il cammino tortuoso delle cose- le chiude, almeno temporaneamente. Il fatto è che alla morte della globalizzazione come illusione collettiva non le si contrappone l’emergenza di una opzione capace di catturare e incanalare la volontà desiderante e la speranza mobilitatrice dei popoli colpiti.
La globalizzazione, come ideologia politica, ha trionfato sulla sconfitta dell’alternativa del socialismo di stato; questo è, della statalizzazione dei mezzi di produzione, del partito unico e dell’economia pianificata dall’alto. La caduta del muro di Berlino, nel 1989, mette in scena questa capitolazione. Allora, nell’immaginario planetario rimase una sola rotta, un solo destino mondiale. Ciò che ora sta succedendo è che anche questo unico destino trionfante muore. Come dire, l’umanità rimane senza destino, senza direzione, senza certezze. Ma non è la “fine della storia” -come preconizzavano i neoliberali-, ma la fine della “fine della storia”. È il nulla della storia.
Ciò che oggi rimane nei paesi capitalisti è un’inerzia senza convinzione che non seduce, un fascio decrepito di illusioni sfiorite e, nella penna degli scrivani fossilizzati, la nostalgia di una globalizzazione fallita che non illumina più i destini.
Allora, con il socialismo di stato sconfitto e il neoliberalismo morto per suicidio, il mondo rimane senza orizzonte, senza futuro, senza speranza mobilitatrice. È un periodo di assoluta incertezza nel quale, come intuiva bene William Shakespeare, “tutto quanto è stabile svanisce nell’aria”. Ma anche per questo è un tempo più fertile, perché non si hanno certezze ereditate alle quali afferrarsi per ordinare il mondo. Queste certezze bisogna costruirle con le particelle caotiche dei questa nube cosmica che lascia dietro di sé la morte delle passate narrazioni.
Quale sarà il nuovo futuro mobilitatore delle passioni sociali? Impossibile saperlo. Tutti i futuri sono possibili a partire dal “nulla” ereditato. Il comune, il comunitario, il comunista è una di queste possibilità che è annidata nell’azione concreta degli esseri umani e nella loro imprescindibile relazione metabolica con la natura.
In qualsiasi caso, non c’è società umana capace di privarsi della speranza. Non c’è essere umano che possa prescindere da un orizzonte, e oggi siamo obbligati a costruirne uno. Questo è comune negli umani e questo comune è quello che può portarci a disegnare un nuovo destino diverso da questo emergente capitalismo erratico che finisce col perdere la fede in sé stesso.
28-12-2016
La Jornada
*Álvaro García Linera è il vicepresidente della Repubblica Plurinazionale della Bolivia.
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Álvaro García Linera, “La globalización ha muerto” pubblicato il 28-12-2016 in La Jornada, su [http://www.jornada.unam.mx/2016/12/28/opinion/013a1pol?partner=rss] ultimo accesso 05-01-2017. |