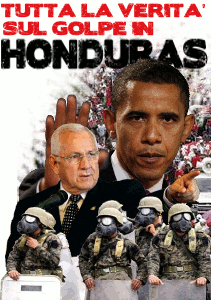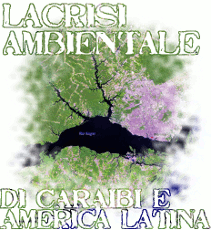In questa intervista per ROAR (autore Sardar Saadi, traduzione della redazione di InfoAut) uno dei massimi geografi marxisti riflette su Rojava, Baltimora e la vita metropolitana come terreno per la lotta di classe contemporanea. Originale in lingua inglese qui.
In questa intervista per ROAR (autore Sardar Saadi, traduzione della redazione di InfoAut) uno dei massimi geografi marxisti riflette su Rojava, Baltimora e la vita metropolitana come terreno per la lotta di classe contemporanea. Originale in lingua inglese qui.
David Harvey insegna antropologia e geografia al Graduate Center della City University of New York (CUNY). È stato a Diyarbakir per visitare la regione e partecipare a una discussione alla fiera del libro di Amed riguardo al suo ultimo libro, Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo, tradotto in turco dall’editore Sel. Il collaboratore di ROAR Sardar Saadi lo ha incontrato per un’intervista.
Sardar Saadi: Professor Harvey, benvenuto in Kurdistan! Grazie per aver accettato di essere intervistato per ROAR. È stato difficile ottenere un appuntamento, lei è molto impegnato. Ci può raccontare cosa la porta in Kurdistan? Ho saputo che è stato anche a Kobane…
David Harvey: Beh, questa è la mia terza visita in questa parte della Turchia, e ho dei rapporti personali stretti con alcune persone che insegnano all’Università di Mardin Artuklu. Mardin è un bellissimo posto da visitare, e così ho avuto modo di unire l’utile al dilettevole. Ma sono qui anche per via della situazione complessiva in Turchia e in particolare anche nel Rojava. Il versante siriano è affascinante ma allo stesso tempo terrificante, così ho cominciato a interessarmene più di recente. Ho cercato anche di raggiungere Kobane, ma il governo turco ha di fatto chiuso le frontiere.
Come sa, il governo turco e la regione curda dell’Iraq hanno imposto un embargo permanente sul Rojava. Come mette in relazione tutto ciò con quanto sta accadendo nel Rojava?
Posso solo congetturare che nessuno voglia dare risalto internazionale a qualunque cosa stia succedendo nel Rojava, e che nessuno voglia che qualunque cosa stia avvenendo lì abbia successo. Questa è la mia ipotesi, mi sembra la più ovvia.
Ci sono moltissime iniziative per ricostruire Kobane. I raid aerei e i bombardamenti hanno lasciato la città quasi interamente distrutta. Qual è la sua prospettiva sulla ricostruzione di Kobane, e sulla possibilità di creare un’alternativa anticapitalista in quell’area?
Ho visto una mappa con dati satellitari sui vari livelli di distruzione, e Kobane è chiaramente distrutta per circa l’80%. La ricostruzione verterà essenzialmente sugli edifici di superficie e su riportarne indietro gli abitanti. Ciò offre una gamma di occasioni per pensare creativamente a un’urbanizzazione alternativa.
Una delle difficoltà più grandi, credo, sarà affrontare il diritto di proprietà vigente in modo tale che la popolazione esistente possa ristabilirvisi. Probabilmente vorranno riportare i diritti di proprietà a com’erano prima, il che reintrodurrebbe un’urbanizzazione di vecchio stampo, cosa che forse accadrà – nel qual caso la vera domanda sarà da dove provengono le risorse.
Comunque credo che sussistano delle possibilità per esplorare alternative anticapitaliste. Se questa occasione verrà colta o meno non lo so, ma nella misura in cui il pensiero curdo è stato influenzato da persone come Murray Bookchin penso che ci sia la possibilità che la popolazione esplori alternative differenti. Mi è stato detto che ci sono forme di governo assembleari in atto nel Rojava, ma non ho ancora visto nulla. La cosa mi preoccupa un po’: sai, la sinistra a volte ha di questo romanticismo. Gli zapatisti dicevano: “rivoluzione”, e tutti avevano un’idea romantica di quello che loro stavano facendo.
In effetti mi è capitato di fare un paragone tra la rivoluzione nel Rojava e gli zapatisti. Ho posto la questione se il Rojava stia diventando come il Chiapas o come il Medio Oriente. Pensa che esista un’analogia tra le due lotte?
Non tanto, nel senso che gli Zapatisti erano organizzati, hanno preso il controllo del territorio e sono riusciti a proteggerlo in un modo particolare e in un momento particolare. Non erano martoriati dalla guerra, non avevano molti dei problemi che la gente nel Rojava deve affrontare. In compenso avevano delle strutture comunitarie già in atto, quindi lì c’era già una forma di governo: non hanno dovuto attuare nulla da zero. Quindi credo ci siano molte differenze.
Credo che l’analogia stia nel romanticismo che ha la gente di sinistra in Europa e in America, del tipo: “oh bene, ecco il luogo, finalmente!” Al che io rispondo sempre che il posto in cui dovremmo costruire il socialismo rivoluzionario sono gli Stati Uniti, anziché sperare che qualcosa in Chiapas o nel nord della Siria ci salvi dal capitalismo [ride]. Non succederà mai.
In che modo pensa che il movimento di solidarietà internazionale possa aiutare il Rojava in modo produttivo?
Ci sono alcune cose basilari, direi. Qualunque cosa accada, credo che l’emancipazione del popolo curdo – fintantoché esiste un livello di autogoverno – sia qualcosa che valga la pena sostenere. Io stesso sono ben felice di sostenerla. Nella misura in cui queste comunità stanno sperimentando nuove forme di governo e vogliono provare nuove forme di sviluppo urbano, credo che mi interesserebbe molto parlare con loro. Mi fa piacere che la gente stia pensando a fare qualcosa di diverso, e finché sono in grado di portare loro aiuto o di aiutare a portare aiuto, vorrei poterlo fare.
Ovviamente, ciò che possiamo già vedere è che ci saranno degli ostacoli; dovremo trovare il modo di aggirarli. Ad esempio, c’è un gruppo alternativo di persone dall’Europa e dal Nord America che stanno effettivamente provando a riprogettare l’urbanizzazione a Gaza. Penso che se sono veramente in grado di fare qualcosa lì saranno anche in grado di mobilitarsi per fare qualcosa anche nel Rojava.
Ci sono insomma delle possibilità concrete. Ma parlando a titolo personale vorrei andarci cauto nel dire: “oh, sono successe grandi cose, è tutto bellissimo.” Preferisco dire: “guardate, penso che le cose si muovano in una direzione interessante che merita di essere supportata e discussa, e noi dobbiamo fare del nostro meglio per supportare qualunque cosa la popolazione stessa stia cercando di portare avanti.”
In un’intervista con l’agenzia giornalistica Firat durante una conferenza ad Amburgo, lei ha menzionato il fatto che il Medio Oriente è una regione che sta andando in pezzi. Il Rojava invece sta fiorendo come alternativa in questo ambiente caotico, non crede?
Beh, quello che avviene in questa regione è una parte cruciale del mondo in termini geopolitici. Il Medio Oriente, al momento, è nel caos più totale. Tutti stanno allungando le mani sulla torta, russi, cinesi, americani, europei. È una zona di conflitti, e lo è già da un po’… voglio dire, guarda quello che sta succedendo in Siria. E poi c’è la guerra civile in Libano, la situazione in Iraq, quello che sta accadendo in Yemen, in Egitto, e così via. È una zona instabile in termini geologici e di configurazione geopolitica del mondo, il che produce disastri per le popolazioni locali.
Ma una cosa che succede di solito nei disastri è che emergono nuove cose che possono essere molto, molto significative. Credo che la ragione per cui il disastro produce novità sia che la tipica struttura di potere borghese scompare e la classe dominante è incapace di governare. Ciò crea una situazione in cui la gente comincia ad autogovernarsi al di fuori di queste strutture di potere tradizionali. Quindi è probabile che vedremo emergere nuove possibilità, non solo nel Rojava ma anche altrove. Alcune, ovviamente, non saranno particolarmente piacevoli, tipo l’ISIS, per cui non sto affatto dicendo che tutto va nella direzione giusta. È una zona di opportunità come di disastri.
Vorrei introdurre un altro argomento in questa conversazione: la città – una cosa di cui lei ha scritto molto. Nell’ultimo decennio circa, abbiamo assistito alla crescente importanza delle città nella politica curda. A Diyarbakir, dove ci troviamo ora, l’amministrazione comunale filo-curda è intervenuta nella vita politica e socio-economica della città e sta riprendendosi gli spazi urbani seguendo questa linea. Inoltre, per la prima volta la resistenza di Kobane è la resistenza di una città, a differenza delle precedenti sollevazioni nella storia del movimento curdo che tradizionalmente riguardavano più una tribù, un leader tradizionale, o un partito politico nazionalista a guida della resistenza.
Mi chiedo se possiamo mettere in relaziona la resistenza di Kobane o l’esempio del movimento municipalista di Diyarbakir e di altre città curde della Turchia con il più ampio movimento globale che negli ultimi anni abbiamo visto in atto in posti come piazza Tahrir al Cairo, il movimento Occupy partito da New York, le proteste di Gezi Park a Istanbul, o più recentemente i riot a Baltimora. Vede qualche connessione con queste forme emergenti di politica cittadina di strada?
Beh, sì, il mondo è sempre più urbanizzato e vediamo emergere sempre di più il malcontento nei confronti della qualità della vita urbana. Per cui si può vedere questo malcontento generare rivolte in alcuni casi, o proteste di massa tipo Gezi Park o quanto successo in Brasile poco dopo. C’è in effetti una lunga tradizione di rivolte urbane – la Comune di Parigi del 1871 e altri episodi ancora precedenti – ma credo che la questione urbana stia davvero diventando centrale oggi, e le qualità della vita metropolitana stanno prendendo il centro della scena di ciò su cui le proteste vertono.
Allo stesso tempo però, e sempre di più, assistiamo all’internalizzazione della protesta politica nelle città. Ciò che cominciamo a vedere con le forze di difesa israeliane che affrontano i palestinesi a Ramallah e in altri posti analoghi è che non abbiamo più a che fare con uno stato contro un altro stato, ma con uno stato che cerca di controllare il resto della popolazione urbana. Lo abbiamo visto persino negli Stati Uniti in un posto come Ferguson, dove le forze armate sono intervenute per fronteggiare la protesta, come pure a Baltimora. Quindi credo che vedremo sempre di più guerre cittadine di questo tipo tra popolazioni, e vedremo sempre di più apparati dello stato che si auto-isolano dalle persone che dovrebbero servire, divenendo invece parte degli apparati amministrativi del capitale che reprimono le popolazioni cittadine.
Stiamo quindi assistendo a rivolte metropolitane che emergono a macchia di leopardo un po’ in tutto il mondo: a Buenos Aires, in Bolivia, in Brasile, ecc. L’America Latina è piena di cose di questo genere, ma anche in Europa abbiamo visto grandi disordini cittadini: Londra, Stoccolma, Parigi, e così via. Ciò che dobbiamo fare è immaginare nuove forme politiche, che è fondamentalmente ciò che significa l’anticapitalismo. Sfortunatamente, la sinistra tradizionale si concentra esclusivamente sui lavoratori e sui luoghi di lavoro, mentre oggi è la politica della vita quotidiana che conta veramente.
A volte la sinistra è molto conservatrice in ciò che ritiene importante. Marx e Engels avevano una visione del proletariato di un certo tipo. Ebbene, quel proletariato è scomparso in molte parti del mondo, anche se è riemerso in posti come in Cina e in Messico in condizioni differenti. Quindi in termini generali la sinistra deve essere molto più flessibile nel suo approccio nei confronti di quei movimenti anticapitalisti che sono nati intorno alla questione della vita metropolitana e che abbiamo visto nelle rivolte di Baltimora, di Piazza Tahrir, ecc. Il che non significa che sono tutti la stessa cosa, perché non lo sono, ma c’è chiaramente una certa simmetria tra di essi.
Quali pensa che possano essere gli esiti di quanto è avvenuto in posti come Baltimora per il movimento globale contro il capitalismo? Si tratta solo di proteste momentanee scaturite in condizioni spazio-temporali specifiche o possono essere viste come indicazioni del fatto che c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel sistema?
Una delle maggiori difficoltà, politicamente parlando, è far capire alla gente la natura del sistema in cui vivono. Il sistema è molto sofisticato nel nascondere quello che fa e come lo fa. Uno dei compiti dei marxisti e dei teorici critici è cercare di demistificarlo, ma si può vedere come in alcuni casi questo avvenga intuitivamente. Prendi il movimento degli indignados: capita qualcosa in Spagna e poi, subito dopo, capita improvvisamente in Grecia, e poi improvvisamente ancora altrove. Prendi il movimento Occupy: a un tratto ci sono state delle occupazioni dappertutto. C’è della connettività.
Un evento specifico come Baltimora, di per sé, non fa nulla. Quello che fa, se lo sommi a Ferguson e ad altre cose che sono successe, è mostrare che ampie popolazioni sono state trattate come esseri umani usa e getta: è quanto sta succedendo negli Stati Uniti così come da altre parti. Allora la gente comincia d’un tratto a capire che si tratta di un problema sistemico. Una delle cose che dovremmo fare, dunque, è sottolineare la natura sistemica di episodi di questo tipo; mostrare che il problema è nel sistema.
Io ho vissuto a Baltimora per molti anni, e quanto sta accadendo ora è di fatto la replica di ciò in cui mi sono imbattuto nel 1969, un anno dopo che gran parte del posto era stato messo a ferro e fuoco. Siamo passati dal 1968 al 2015, e le cose non sono cambiate! Uno si chiede: “ma cos’è che mantiene tutto uguale?” Nonostante le promesse di quelli che dichiaravano che avrebbero risolto la situazione negli anni ’70, o di quelli che dichiarano di risolverla oggi, nulla di queste promesse si concretizza – assolutamente nulla. Anzi, molte cose peggiorano.
Baltimora è interessante non solo per quello che è successo nelle aree più povere. Il resto della città di fatto si è gentrificato ed è diventato facoltoso, per cui Baltimora si è davvero trasformata in due città. Ci sono sempre state due città, ma ora c’è un divario molto più ampio tra le due e la differenza è visibile a tutti. Ho letto un’intervista fatta a qualcuno a piazza Tahrir, e una delle cose che dicevano era che avevano sempre vissuto in condizioni non troppo agiate, ma quello che stavano notando era che alcuni si stavano arricchendo da fare schifo. Non capivano perché questi erano diventati ricchi sfondati mentre il resto affondava o rimaneva nelle stesse condizioni, ed è la rabbia nei confronti di questa disparità che li ha scagliati contro il sistema. Lo stesso vale anche per Baltimora: “la loro parte della città sta bene, la mia sta andando a picco.”
Per la verità questo vale per la maggior parte delle città. Se ti guardi intorno lo vedi in atto a Istanbul e dovunque. E i governi cosa fanno? Ebbene, sgomberano le persone dalle loro cosiddette slum areas perché sorgono su terreni di altissimo valore, così da poterli dare in concessione ai palazzinari che ci costruiscono uffici e centri commerciali, mentre la gente grida “non è giusto!” È così che si arriva al punto in cui la gente comincia a esercitare il proprio diritto alla città, il che significa utilizzare la città per i propri scopi.
Noi vogliamo esercitare il nostro diritto alla città nel nostro modo particolare, che è radicalmente diverso da quello del capitale; vogliamo costruire un tipo diverso di città. Come si fa? È possibile farlo? Sono domande difficili. Quando la gente avanza questa rivendicazione, sorge subito un’altra domanda: si può fare all’interno del diritto di proprietà nella sua struttura vigente? Negli Stati Uniti è convinzione che la proprietà privata e la proprietà fondiaria non costituiscano problema. Suppongo che parte della soluzione dipenda dal fatto che la gente realizzi che questo invece è parte del problema. A quel punto cominceremo a vedere che dobbiamo ideare una struttura alternativa del diritto di proprietà che non sia privato, ma collettivo, comune. E allo stesso tempo deve offrire sicurezza e togliere la paura della speculazione del capitale.
Vorrei concludere chiedendole in cosa ha trovato ispirazione durante il suo viaggio in Kurdistan. C’è qualcosa che la porterà di nuovo qui?
Beh, come ho detto, l’intera regione ha un ruolo decisamente critico. In effetti non troppo tempo fa fantasticavo di trasferirmi del tutto da qualche parte nei dintorni. Ho pensato che potrei fare base ad Atene e quindi spendere il mio tempo lavorando un po’ in Turchia, un po’ in Libano, un po’ in Egitto, perché è la zona che sta tra l’Europa e questa regione. Quanto sta accadendo qui sembra affascinante, per cui mi piace poter essere sul posto. Ho anche degli ottimi amici qui, e un meraviglioso editore, Sel. Devo dire che hanno fatto un lavoro stupendo sia con la traduzione sia invitandomi e facendomi vedere delle cose. Se riesco ad entrare a Kobane, è davvero grazie ai loro sforzi.
Spero che presto potremo vedere i suoi libri tradotti anche in curdo, e sono sicuro che la gente di Diyarbakir sarà felice di ospitarla se mai vorrà stabilirsi nella regione. La ringrazio molto per il suo tempo, Professor Harvey. Spero che riuscirà a entrare a Kobane presto.
Sardar Saadi è un attivista con base a Toronto e dottorando in antropologia all’Università di Toronto. Prima di tradurre quest’intervista in turco, per favore contattate Sardar: sardarsaadi@gmail.com
28 Maggio 2015
InfoAut
| Traduzione di InfoAut: |
| Sardar Saadi, “David Harvey: rivendicare la città da Kobane a Baltimora” pubblicato il 28-05-2015 in InfoAut, su [http://www.infoaut.org/index.php/blog/approfondimenti/item/14755-david-harvey-rivendicare-la-città-da-kobane-a-baltimora] ultimo accesso 09-06-2015. |