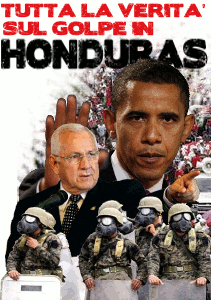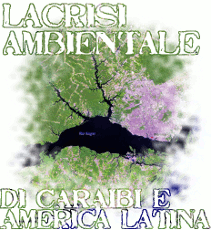Alcune riflessioni per le nuove campagne.
Nel 1989 fu firmato il primo trattato di libero commercio (TLC) del continente americano tra gli USA e il Canada. Da allora siamo stati testimoni dell’avanzata dell’agenda di liberalizzazioni commerciali, in un’epoca segnata dal crollo dell’Unione Sovietica, dalla vittoria del “pensiero unico” e dalle molteplici fini: della storia, della lotta di classe, delle ideologie, ecc. Questo contesto di sconfitta si presentava come assoluto e definitivo. Nonostante ciò, in modo antagonista a queste pratiche e discorsi, apparvero diverse organizzazioni sociali delle Americhe che propugnarono l’idea che il libero commercio fosse antagonista alla costruzione di una società più ugualitaria, e che per questo doveva essere contestato e affrontato. Queste organizzazioni stabilirono di nuovo anche il dibattito sulle alternative politiche: la costruzione di pratiche di un essere-altro, così come lo hanno fatto gli zapatisti, ma ora nel contesto della “quarta guerra mondiale”.
C’è un accordo generale sul fatto che questa nuova storia l’abbiano cominciata gli zapatisti. Ma è anche certo che a partire da lì, già alla fine degli anni novanta, è stata la maggioranza delle organizzazioni sociali (contadini, indigeni, sindacati, organizzazioni ambientaliste, femministe, movimenti territoriali urbani, piqueteros, tra i tanti altri), quella che ha individuato i TLC come uno degli assi della riorganizzazione capitalista contemporanea. Ciascuna organizzazione a partire dalla propria agenda, orientata dall’anti-neoliberismo, o il bolivarianismo, o il neo-sviluppismo, o l’autonomismo, è riuscita ad inserire il progetto ALCA (Area di Libero Commercio delle Americhe) tra le priorità della propria attività politica. In questo senso, nel 1997 nacque l’Alleanza Sociale Continentale (ASC) come uno spazio di organizzazione di fronte alla disorganizzazione e allo sconforto che la sconfitta degli anni novanta aveva rappresentato. L’ASC dette i suoi frutti: tra il 1998 e il 2005, si trasformò in uno spazio di riferimento continentale e globale della lotta contro il libero commercio. In questo ambito, gli Incontri Emisferici contro l’ALCA che si effettuavano annualmente a L’Avana si trasformarono in un centro per la costituzione di una strategia politica continentale. Ma ciò che li articolava era il rifiuto: il No all’ALCA si pose in cima alle specificità tematiche e alle cosmovisioni politiche delle organizzazioni. Dopo il 2005, quello che la paura per l’ALCA aveva unito, fu disunito dalla posizione presa di fronte ai governi progressisti e dando la priorità alle agende settoriali. Così, ciò che ha primeggiato è stata la disarticolazione e l’ASC è andata lentamente perdendo il proprio peso politico e la propria rappresentatività.
Esploriamo quello che è successo. Risultava abbastanza semplice identificare l’ALCA come “l’imperialismo yankee”, come ciò che non si vuole secondo nessun concetto: 34 paesi che negoziano nell’orbita dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), con l’obiettivo di creare un mercato aperto per i produttori nordamericani. L’ALCA implicava organizzare un’area di libero commercio dall’Alaska fino alla Terra del Fuoco, che beneficiava essenzialmente le compagnie nordamericane con la possibilità di esportare i capitali e di rilocalizzare parte della propria produzione verso economie con mano d’opera più economica di quella degli USA. Nonostante ciò, lo scenario dei negoziati dell’ALCA non è il medesimo di quello che oggi c’è nel continente. Questo non vuol dire che gli USA abbiamo perso la propria attrazione. Il progetto dell’Accordo Transpacifico (TPP) lo dimostra, quando questo paese compete con la Cina per guidare la regione Pacifico. I movimenti dei paesi che hanno firmato questo trattato (Cile, Perù, Messico, Canada e USA) hanno identificato il TPP come una specie di nuovo “grande mostro”, per la durezza di alcune sue clausole, specialmente nella richiesta di “coerenza regolatoria”, investimenti e proprietà intellettuale. La vocazione dei suoi sostenitori, inoltre, potrebbe essere quella di cercare di espandere la portata di queste clausole a nuovi accordi commerciali che si firmeranno nella regione.
Il TPP entra dal lato Pacifico, specialmente attraverso il blocco dell’Alleanza del Pacifico. Dal lato Atlantico il tema diventa più complesso. Lì c’è il Mercosur, che fino a poco tempo fa sosteneva un’agenda più orientata all’industria locale e al rafforzamento della “borghesia nazionale” imperniata nel settore automobilistico, presentandosi come una regione più anti americana. Nonostante ciò, dal 2012, il Brasile, per mano dei suoi gruppi economici “nazionali”, ha incominciato ad affrettare la firma di un trattato con l’Unione Europea, e il nuovo governo dell’Argentina permette ora di avanzare in questo senso (appoggiato anche dall’Uruguay e dal Paraguay). I negoziati tra i blocchi del Mercosur e dell’UE hanno progredito al pari dell’ALCA, ma hanno avuto meno marketing di quello. Con l’UE appare nello scenario un altro attore. Qui bisogna aprire una parentesi. Invece il blocco dell’Alleanza del Pacifico è usualmente identificato con gli interessi nordamericani, si tratta di paesi che hanno firmato anni fa anche degli Accordi di Associazione all’UE.
In terzo luogo, i paesi bolivariani dell’ALBA fino ad ora resistevano alla firma di qualche TLC. Nonostante ciò, la caduta del prezzo delle commodities ha affrettato nuove decisioni più chiaramente pragmatiche. Due anni fa l’Ecuador ha aderito all’Accordo di Associazione [1] con la UE che era già stato firmato dalla Colombia e dal Perù (adesione ancora non ratificata dall’Assemblea Nazionale). Nonostante ciò, il discorso dello stesso Rafael Correa continua a sostenere che quello che è stato firmato con l’UE “non è un TLC”.
E la Cina? Chiaramente, un altro attore che appare sulla scena, questo più nuovo e interessante perché interseca alcuni dei paesi che abbiamo valutato nei gruppi dei precedenti paragrafi. Dal 2012 la Cina ha dispiegato una strategia per inserire le sue imprese statali nel continente americano, specialmente attraverso contratti con gli stati in settori estrattivi e infrastrutturali, ma anche con Investimenti Stranieri Diretti nell’industria automobilistica e delle telecomunicazioni, tra i vari. Il governo cinese è anche stato in ultima istanza la salvezza per i paesi impegolati nelle oscillazioni del prezzo delle commodities, come il Venezuela ed l’Ecuador con il petrolio, o il Brasile e l’Argentina con il fagiolo della soia. Per i propri interessi in America Latina, la Cina ha firmato TLC con il Cile e con il Perù, e oggi anche l’Argentina si aggiunge alla lista degli interessati.
 Questa descrizione del recente scenario mostra che la firma del TLC non è solo una strategia nordamericana. Lo è anche dell’Unione Europea, della Cina, del Giappone, e di tutte le grandi o medie potenze. Di fatto, differenti paesi della regione (Perù, Cile, Messico, Colombia) hanno già TLC con questi altri paesi o blocchi. In realtà, la promozione dei TLC risponde alle nuove modalità di internazionalizzazione del capitale e alla divisione internazionale del lavoro strutturata a partire dalla costituzione delle imprese-rete, come dire, delle compagnie transnazionali. Tutte le imprese dei paesi più industrializzati competono tra loro e devono garantirsi bassi costi di produzione e mercati per il consumo dei loro prodotti. Si tratta di produrre a buon mercato e di vendere, o morire, come dire, fallire come capitalista individuale. Gli USA promuovono trattati in modo di garantirsi le migliori condizioni per la competitività delle “proprie” imprese, così come lo fanno gli altri stati. Tutti gli stati, siano grandi, medi o anche se si tratta di piccole economie, beneficiano del fatto che alle proprie imprese va bene, giacché così si garantiscono le entrate di denaro attraverso il pagamento di imposte, la creazione di lavoro, e con questo, la governabilità interna. Per questo, l’esperienza degli ultimi quaranta anni ci permette di smettere di identificare “i mali” del libero commercio dietro ad una o all’altra bandiera: con il libero commercio le imprese più potenti competono tra loro e garantiscono i propri profitti.
Questa descrizione del recente scenario mostra che la firma del TLC non è solo una strategia nordamericana. Lo è anche dell’Unione Europea, della Cina, del Giappone, e di tutte le grandi o medie potenze. Di fatto, differenti paesi della regione (Perù, Cile, Messico, Colombia) hanno già TLC con questi altri paesi o blocchi. In realtà, la promozione dei TLC risponde alle nuove modalità di internazionalizzazione del capitale e alla divisione internazionale del lavoro strutturata a partire dalla costituzione delle imprese-rete, come dire, delle compagnie transnazionali. Tutte le imprese dei paesi più industrializzati competono tra loro e devono garantirsi bassi costi di produzione e mercati per il consumo dei loro prodotti. Si tratta di produrre a buon mercato e di vendere, o morire, come dire, fallire come capitalista individuale. Gli USA promuovono trattati in modo di garantirsi le migliori condizioni per la competitività delle “proprie” imprese, così come lo fanno gli altri stati. Tutti gli stati, siano grandi, medi o anche se si tratta di piccole economie, beneficiano del fatto che alle proprie imprese va bene, giacché così si garantiscono le entrate di denaro attraverso il pagamento di imposte, la creazione di lavoro, e con questo, la governabilità interna. Per questo, l’esperienza degli ultimi quaranta anni ci permette di smettere di identificare “i mali” del libero commercio dietro ad una o all’altra bandiera: con il libero commercio le imprese più potenti competono tra loro e garantiscono i propri profitti.
Tornare a porre sul tavolo la discussione sulle alternative
Quando abbiamo sconfitto l’ALCA avevamo davanti a noi un compito chiaro, anche se non semplice: costruire l’integrazione alternativa. Ma mentre noi smantellavamo virtualmente l’ASC, discutevamo se l’integrazione fosse degli stati, dei popoli o delle comunità, se si dovesse farlo usando il dollaro, o con lo scambio o con una moneta regionale, se prima bisognasse conquistare lo stato o se si dovesse costruire potere popolare, se il capitalismo nazionale sia un passo verso il socialismo o se si possano costruire spazi socialisti all’interno del capitalismo, l’agenda liberoscambista è andata avanti con una Ferrari Testarossa. Noi ci muoviamo a 10 km/ora, loro a 200. Non abbiamo potuto o saputo costruire le alternative. Chiaro che immaginare e realizzare società alternative nel quadro delle relazioni sociali capitaliste, che ci attraversano come soggetti, non è un compito facile. Ma nonostante l’urgenza, non siamo stati all’altezza del momento storico che abbiamo ereditato dalle lotte degli anni novanta e dalle esplosioni sociali regionali degli inizi del XXI secolo.
Oggi l’idea che guadagna terreno è che il libero commercio sia l’unica opzione. In pochi casi si vede con tanta chiarezza come negli ultimi mesi in Argentina: bisogna firmare TLC “per integrarci con il mondo”, “affinché arrivino investimenti”, “per garantire mercati alle nostre esportazioni”. Non ci sono alternative, non si discute nulla, non ci sono analisi possibili. Un’altra volta il discorso unico ci viene imposto. Gli stati che parlavano di rendere più profonde le relazioni commerciali di complementarietà e di creare un’architettura finanziaria regionale che mettesse in discussione il potere del dollaro, oggi lottano tra loro per collocare le proprie esportazioni. Il risultato della disintegrazione è la competitività, e l’esacerbazione dei nazionalismi. Ora continua liberamente la corsa per la deregolazione e la liberalizzazione, parte essenziale della riproduzione del capitalismo.
I prossimi anni mostreranno una tendenza all’isolamento (economico e finanziario) dei paesi che non firmeranno TLC, con pressioni affinché si uniscano ai processi di liberalizzazione. In questo contesto, noi movimenti facciamo quello che sappiamo fare: resistere. La difensiva è sempre un luogo comodo, su cui molti di noi sono d’accordo. Torniamo a dire No al libero commercio, perché conosciamo gli effetti che questo ha. Ma, in questo contesto, saremo capaci di continuare i dibattiti sulle alternative politiche?
La concentrazione e l’internazionalizzazione del capitale degli ultimi quaranta anni mette in tensione l’idea di sviluppare una costruzione politica alternativa da un punto di vista stato-centrica. È sempre più risaputo che gli stati non sono enti autarchici, che l’obiettivo di costruire un “capitalismo nazionale” o un “capitalismo dal volto umano” è risultato essere una chimera. Gli stati si muovono nelle oscillazioni della riconfigurazione capitalista mondiale, e non possono rinchiudersi in sé stessi. Non potevano farlo sessanta anni fa, e nemmeno oggi. Se qualcosa ci ha permesso la globalizzazione è di poter riconoscere il capitale in tutta la sua durezza: come una relazione sociale globale di sfruttamento e dominio. Tocca alle organizzazioni sociali, così come all’accademia, pensare alle alternative a partire da questo nuovo contesto globale, mettendo al centro dell’analisi i pericoli che il libero commercio può significare per la vita umana e l’ambiente, ma senza opporre a questo l’idea che chiudendo le frontiere commerciali ci possiamo salvare come stato-nazione individuale. Oggi è più chiaro che mai che, o ci salviamo tutti, o non si salva nulla. La discussione non può riprodurre ciecamente vecchie formule che avevano a che vedere con patti di governabilità (o più duramente, con la pace delle classi). Il nuovo contesto, le nuove agende, ci propongono l’urgenza di pensare non dal punto di vista degli stati, ma dalla critica dell’esistente.
Nota:
[1] L’UE non firma TLC, firma Accordi di Associazione (AdA), a causa della stessa struttura dei negoziati dell’UE. Nonostante ciò, le clausole di un Accordo di questo tipo sono simili a quelle che vengono incluse nei TLC, proprio se non comprende un capitolo di soluzione dei contrasti né rimanda all’arbitrato internazionale. In ogni modo, l’UE ha incominciato a rinegoziare i suoi AdA, per esempio con il Messico e il Cile, con l’obiettivo di includere questi capitoli.
03/09/2016
tratto da La Haine
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Luciana Ghioto, “Veinte años de lucha contra el libre comercio en América Latina” pubblicato il 03-09-2016 in La Haine, su [http://www.lahaine.org/mundo.php/veinte-anos-de-lucha-contra] ultimo accesso 13-09-2016. |