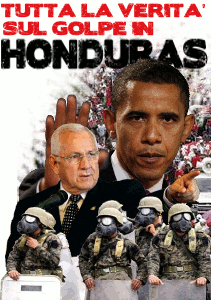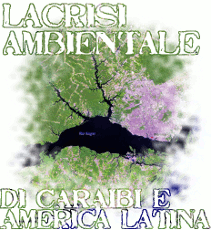Things had to change in a hurry. But socialism requires imagination and time. It cannot be made in a hurry. To create socialism in a hurry without mass support, and institutions that can channel this support, led many states to disaster. […] The intentions of the leadership, by all accounts, were not malevolent. Yet its modernist dream-to administer nature and society, and build vast industrial monuments without either a democratic governance structure or a mobilized population-led to the worst excesses of commandism and bureaucratism.
Vijay Prashad, The Darker Nations
Non ricordo più dove. Ma sono quasi sicuro che da qualche parte Giovanni Arrighi abbia scritto, probabilmente citando o parafrasando Braudel, che per conoscere ciò che è nuovo bisogna sapere riconoscere, anzitutto, quello che non lo è.
*****
Il 27 ottobre scorso, in un articolo assai critico sul fallimento, clamoroso purtroppo, del “laboratorio” politico latinoamericano e sull’assurdità di attribuirne le cause ai complotti dell’imperialismo statunitense scrissi: “La trasfigurazione di un mai ben chiarito ‘socialismo del XXI secolo’ in una cleptocrazia pretoriana in Venezuela, paese ormai sull’orlo del collasso e che rischia seriamente un’invasione e/o una guerra civile qualora certe trame geopolitiche, sociali o finanziarie fuori controllo del governo la rendessero conveniente (o necessaria), è una tragedia per chi ha accompagnato, criticamente, l’evoluzione del processo bolivariano”.1
Sospetto che sia stata questa frase più che il tono generale del pezzo, o l’avere chiamato “vice” di Evo Morales il raffinato intellettuale marxista Álvaro García Linera, come d’altronde è conosciuto affettuosamente dalle sinistre latinoamericane e dall’intera popolazione boliviana, a suscitare la reazione scomposta e priva di argomenti di Carlo Formenti, arrivando persino a sospettarmi di “incitamento all’invasione da parte del regime reazionario della Colombia sostenuto dagli Stati Uniti!?”.2
Lo scenario da me paventato, sciaguratamente, si è presentato il 23 gennaio di quest’anno. Non perché io sia un indovino, uno iettatore o un agente infiltrato della CIA, e meno che mai perché possa vantarmi di essere un analista particolarmente acuto. Ma semplicemente perché, ahimè, era una cosa persino fin troppo ovvia da prevedere per chi mastica un poco di politica internazionale e conosce sul serio, senza paraocchi ideologici di nessun segno, la situazione del Venezuela. Quella situazione, nel bene e nel male, la conosco e la seguo, quotidianamente, almeno dall’inizio del 2007.
Non è questo il momento di spiegare perché sia effettivamente convinto che il “socialismo del XXI secolo” non è mai stato un progetto chiaro (un altro “significante vuoto”, forse, del progressismo latinoamericano?). O, meglio, un progetto nuovo. Né perché l’esperienza concreta delle politiche economiche, produttive e sociali, comprese quelle energetiche, messe in atto dal chavismo dopo il 2005 si sia rivelata fallimentare e in certi casi disastrosa, con sprechi umani e finanziari giganteschi. Non è nemmeno il momento di chiarire, in questa congiuntura, perché abbia affermato senza mezzi termini che qualunque cosa fosse, il “socialismo del XXI secolo” si è rapidamente trasfigurato in una “cleptocrazia pretoriana” dopo la morte di Chávez, con regolamenti di conti interni e faide fra i “legittimi eredi” civili e militari del Comandante, facendo appello ipocritamente a una genuina base di sostegno popolare ogni giorno più esigua e man bassa sottobanco delle risorse del paese.
Chi, senza pregiudizi, conosce la storia globale del Terzo mondo e non solo i suoi mostri ed eroi impacchettati in rassicuranti mitologie e leggende nere utili soltanto ad alimentare l’esotismo metropolitano degli orientalisti di sinistra, dovrebbe immaginare di cosa stia parlando e, soprattutto, sapere che non sto raccontando nulla di nuovo.
Anche per questa ragione non ho mai preso sul serio i terzomondisti della domenica come Formenti che, rispolverando qualche testo di Samir Amin, sembrano credere che si spinge un bottone e…boom! si fa il delinking dal mercato mondiale. I contributi superficiali e fuorvianti su questi temi non sono di nessuna utilità per rinnovare la tradizione politica e intellettuale del terzomondismo con la quale, nonostante tutto, mi sono sempre identificato proprio a partire da un confronto serrato con le tesi che Amin ha difeso con perseveranza fino alla morte. Un confronto originato, tra l’altro, dall’analisi sul campo delle “rivoluzioni bolivariane” che inizialmente invocarono la “desconexión” dal capitalismo. Per lo stesso motivo, non ho mai preso seriamente in considerazione coloro che, sulla scia di Ernesto Laclau, a lungo hanno parlato con disinvoltura di “neo-populismo di sinistra” in America latina senza aver prima fatto i conti con l’esperienza complessa e ambivalente del populismo storico latinoamericano, nonché con la sua pesante eredità.
*****
Nello stesso articolo scritto ad ottobre ho sostenuto anche che: “L’imperialismo, […] come fenomeno inerente allo sviluppo storico del capitalismo, è un problema troppo serio per essere ridotto a capro espiatorio, a teorema del complotto, a deus ex machina a discolpa del fallimento dei governi ‘progressisti’”. La stessa cosa, invertendo i termini, vale per me anche per l’antimperialismo: sia quando è usato come artificio retorico e strategia discorsiva dagli obiettivi immediati, interni ed esterni alla nazione; sia, soprattutto, quando diventa una strategia politico-economica cosciente, non solo difensiva, le cui conseguenze materiali, nel bene e nel male, divengono tangibili nel medio e nel lungo periodo. In entrambi i casi, e per questo è un problema stramaledettamente serio, la premessa dovrebbe essere sempre la capacità minima di saper calcolare le risorse a propria disposizione e i punti deboli, la stabilità e la robustezza delle alleanze rispetto a tutti gli attori in campo e, soprattutto, il peso specifico reale nella correlazione di forze materiali e simboliche nei confronti dell’avversario o degli avversari. Altrimenti, la politica antimperialista può trasformarsi in un boomerang dagli esiti fatali.
Dopo le prime volte che, sotto il balcone di Miraflores, a Caracas, ho ascoltato con entusiasmo insieme al “bravo pueblo” venezuelano gli infiammati discorsi di Chávez contro “yanquis” e “pitiyanquis”, gli stessi che sono stati ripetuti spesso anche alle Nazioni Unite, all’OAS e in altri spazi, ho iniziato ad avere dei dubbi e a interrogarmi sul perché in definitiva non mi convincesse del tutto la retorica aggressiva e rimbombante dei governi antimperialisti.
Attaccando in modo ossessivo un bersaglio totalmente legittimo e meritevole delle critiche più dure, lo fanno come se fosse l’unico responsabile delle nostre disgrazie e di quelle dell’universo. Le azioni concrete, invece, quando ci sono, generalmente sono molto più circoscritte e moderate, come per esempio le nazionalizzazioni pagate con esorbitanti indennizzi. Quando i rapporti di forza sono abissalmente asimmetrici, se si può negoziare si negozia quasi su tutto, nonostante le simulazioni e l’intransigenza verbale.
Così facendo, però, la denuncia antimperialista a poco a poco perde efficacia e credibilità, finendo quasi esclusivamente per mascherare le enormi difficoltà insite nel volere realizzare a tempo record delle trasformazioni economiche e sociali in società profondamente lacerate da secolari fratture razziali, etniche, nazionali e regionali, di genere, spesso religiose e naturalmente di classe. Società, tra l’altro, il cui principale ruolo nel capitalismo mondiale è sempre stato e continua ad essere nella maggior parte dei casi quello di esportare “natura” ai centri imperialistici.
In maniera impercettibile, l’antimperialismo diventa un dispositivo rituale e rutinario per mantenere la coesione di fronte all’inerzia e ai fallimenti. Al tempo stesso finisce anche per inibire nelle classi popolari e nei gruppi subalterni una comprensione meno elementare e fuorviante dei molteplici fili visibili e invisibili che assicurano la riproduzione della subordinazione e della dipendenza.
Nel frattempo, gli imperialisti si sono legati al dito i nostri “Váyanse al carajo yanquis de mierda” e i tentativi, più o meno audaci, di emanciparci dalla loro tutela, dalla loro oppressione. Dopo averci scorticato per benino nervi e muscoli come solo i sadici sanno fare, appena se ne presenta l’occasione ce le suonano di santa ragione, fino ad umiliarci se è possibile, affinché altri non ci riprovino più in futuro.
A questo punto, in particolare se per una ragione o per un’altra è venuta meno la “grande figura eroica” che è stata leader, padre, messia, guida e arbitro, i cortocircuiti hanno già generato scintille che rischiano di trasformarsi in esplosioni. Una logica di faide fra antimperialisti “autentici” e “traditori” si impossessa del processo “rivoluzionario” che scivola progressivamente in una spirale autoritaria.
Le opposizioni, alleate dell’imperialismo, ritrovano le forze proprio grazie all’aiuto esterno, persino quando sono totalmente impresentabili e divise al loro interno. Il “bravo pueblo” comincia ad avere dei dubbi perché in pochissimo tempo vede dissolversi le conquiste realizzate che erano appena il preludio dell’eden promesso dalla “rivoluzione” antimperialista. I capi, invece, che ci dicono che è tutta colpa dell’imperialismo, inspiegabilmente sembrano non soffrire e per giunta continuano ad arricchirsi. Alle spalle del “bravo pueblo”? Si comincia a dubitare delle capacità degli eredi del leader, per definizione, insostituibile. La situazione diventa così difficile che a molti non importa più che “qué acá hay un pueblo digno carajo!”. La dignità non si mangia, non cura le malattie e non ci ripaga con un lavoro e un salario dignitosi. Che importa se è tutta colpa degli “yanquis de mierda”? Che facciamo, li invadiamo? E quando compare un civile o un militare appena un po’ più abile, appena un po’ più presentabile…
Ce lo ha spiegato Noam Chomsky svariati decenni fa: è proprio questo l’obiettivo dell’imperialismo. Creare dall’interno le condizioni per un golpe. E, lo ripeto, quando è conveniente o necessario, organizzare un’invasione in piena in regola il cui esito, però, come sappiamo perlomeno dai tempi del Vietnam, comunque sarà incerto.
Quante volte si è ripetuta questa storia nei paesi socialisti o nazional-rivoluzionari dell’ex Terzo mondo? Quanto assomiglia all’esperienza del Venezuela bolivariano e alla delicatissima situazione attuale?
*****
Ricordo che nel giugno del 2008, a L’Avana, un solerte e accortissimo burocrate appena rientrato da Caracas dove viaggiava spesso per gestire dei progetti di cooperazione bilaterale, mi disse che con il petrolio sopra i cento dollari, Chávez poteva torcere il collo agli americani. Mi spiegava anche che, dopo il 2004, l’opposizione venezuelana era stata totalmente neutralizzata e che il movimento studentesco, in sciopero in quel momento, era formato dai fighetti delle Università private i cui leader venivano pagati direttamente da Washington. Grazie ai programmi sociali con Cuba, il popolo venezuelano era al 100% chavista e si stava formando politicamente. Le “missioni” venivano replicate quindi anche negli altri paesi dell’Alba, che continuava a imbarcare nuovi soci nei Caraibi e in America centrale, per consolidare la popolarità di Evo Morales, Daniel Ortega e Rafael Correa. Erano la solidarietà finanziaria del Venezuela e i servizi professionali cubani a renderlo possibile (proprio così: a Cuba già si parlava apertamente di esportazione di servizi professionali medici, educativi e di altro genere e non solo di missioni di solidarietà internazionale).
Secondo il funzionario, la sconfitta del chavismo per poche centinaia di migliaia di voti alla fine del 2007, nel referendum di riforma in senso socialista della costituzione bolivariana del ’99, si spiegava per la troppa leggerezza del comitato incaricato della campagna elettorale convinto di poter vincere a occhi chiusi. Chávez era stato rieletto appena un anno prima con quasi il 63% dei suffragi. Il PSUV, intanto, creato sempre nel 2007 per riunire sotto un’unica sigla la maggior parte dei partiti e dei movimenti chavisti, si stava rafforzando come macchina elettorale e presenza sul territorio. E, poi, il sistema venezuelano ha sempre usato (e abusato) di uno strumento giuridico, la Ley habilitante, che concede al presidente poteri speciali di decretazione d’urgenza. Il chavismo, subito dopo la sconfitta nel referendum, aveva semplicemente deciso di ampliarlo per accelerare la transizione al “socialismo del XXI secolo”.
Il burocrate cubano mi diceva anche che la situazione geopolitica mondiale era incoraggiante per i paesi del Sud. Emergevano nuovamente la potenza della Russia e della Cina e di altre nazioni come il Brasile in America latina. Gli americani si erano impantanati in Iraq ed Afghanistan senza sapere come uscirne. Il suo palese ottimismo era più che comprensibile in quel momento. Dopo il cataclisma del “periodo speciale in tempi di pace” degli anni ’90, Cuba viveva una sorta di primavera proprio grazie all’alleato bolivariano.
C’era pure un’altra cosa in ballo, ma di questa non conversai con il funzionario. Se ne parlava un po’ ovunque anche se molti lo facevano ancora a bassa voce. L’uscita di scena del troppo “idealista” Fidel per il “pragmatico” Raúl era una buona notizia. Prefigurava l’inizio di un periodo di cambiamenti positivi per la stagnante economia dell’isola. Appena un anno dopo, i delfini del Comandante, Felipe Pérez Roque e Carlos Lage (quest’ultimo era stato l’uomo chiave fino a quel momento nella relazione con Caracas) vennero epurati come da manuale socialista real-tropicale e, quasi d’immediato, scaricati dallo stesso Fidel (ero di nuovo lì e conservo il Granma di quei giorni). Con un’alleanza tattica con gli stalinisti duri, il “cinese” (Rául Castro) e le FAR prendevano davvero in mano le redini del potere per iniziare l’“attualizzazione” del modello socialista cubano, interrotta da Fidel proprio quando intravide in Chávez e nel suo Venezuela petrobolivariano una via d’uscita per Cuba che non fosse imperniata sul turismo, gli investimenti esteri nei settori strategici e l’inevitabile formazione di una piccola borghesia commerciante con le rimesse accumulate dalla diaspora degli anni ’90.
*****
Dieci anni dopo sembra di vivere in un altro mondo. Non solo a Cuba, in Venezuela o in America latina. Adesso sono gli imperialisti yankee che, nonostante il quasi collasso del 2008, potrebbero torcere il collo alla Repubblica bolivariana. L’opposizione interna è rimasta latente per riesplodere con forza non appena fu ufficializzata la notizia della malattia di Chávez nel 2011. Da allora si è preparata per la “salida” del 2014. Il Comandante, invece, ha governato fino all’ultimo minuto con il telecomando da L’Avana, sperando nel miracolo, mentre a Caracas la nomenklatura del PSUV e dello Stato, fusesi nel frattempo, si organizzavano per il post-Chávez. Durante questo interregno, inoltre, dei “compagni rivoluzionari” un po’ furbi prelevarono illecitamente alcune migliaia di miliardi di dollari direttamente dalla Banca centrale per trasferirli su conti a Miami, in Spagna, Andorra, Svizzera. Non si disse mai apertamente, ma i militanti un po’ più anziani (e maliziosi) in America latina pensarono a una “piñata” chavista, riferendosi alle appropriazioni illecite durante l’uscita dal potere dei sandinisti in Nicaragua nel 1990.
I programmi sociali con Cuba continuarono fino a quando non si dovette ridurli per mancanza di petrolio e…di dollari. Non si sono mai convertiti in politiche pubbliche o in “welfare state” come era stato promesso. Sono rimasti degli ibridi, fra assistenzialismo ed emergenza politico-elettorale così come erano iniziati alla fine del 2003, paralleli alle già numerose strutture dello Stato venezuelano che in tutto questo tempo è stato smontato e rimontato e poi ancora smontato e rimontato come un lego. Anche i programmi di solidarietà internazionale e la costruzione dell’Alba in ambito geopolitico, economico, produttivo e finanziario per iniziare il delinking dovettero essere ridotti o sospesi dopo il 2010. Alcuni, in realtà, non furono mai iniziati. Troppi disaccordi interni e interessi divergenti fra i governi “bolivariani”. E, poi, fra la fine del 2008 e la metà del 2009, due avvenimenti misero in allerta gli analisti più prudenti. Il primo fu la caduta del prezzo del greggio che, per quanto durata pochi mesi, rivelò che la gestione delle finanze venezuelane, cioè, l’amministrazione dell’alluvione di petrodollari piovuta dal 2003, era a dir poco caotica. Il secondo evidenziò che i “Váyanse al carajo yanquis de mierda” erano scivolati su un’aiuola in cui non si dovevano mettere i piedi: una repubblichetta oligarchica centroamericana chiamata Honduras. Il suo presidente, Mel Zelaya, un esponente dell’élite del paese, con un voltafaccia aveva deciso di abbracciare la marea bolivariana. Per questo, quando risolse di partecipare all’Alba e cercò di promuovere un referendum per iniziare un processo costituente, fu prelevato in pigiama dai militari e portato in Costa Rica mediante un golpe orchestrato dall’oligarchia honduregna avallato direttamente da Hilary Clinton. A ragione, chi conosce la geopolitica del bacino dei Caraibi, come gli ana(imperia)listi di Foreign Affairs, pronosticò che da lì in poi sarebbe iniziato il “roll back” del chavismo. Ma non era una rivelazione. Un anno prima, a Caracas, una professoressa marxista dell’Università Centrale del Venezuela, che per un breve periodo era stata consulente di Chávez sull’integrazione regionale, mi aveva detto (senza che io ci facessi troppo caso in quel momento) che “l’Honduras l’hanno messo dentro (l’Alba) per fotterci”.
Il PSUV non tardò molto a trasformarsi in una macchina elettorale gestita verticalmente e totalmente priva di democrazia interna per i parametri di un progetto socialista antiautoritario. D’altra parte, dopo l’incontro “Intelectuales, Democracia y Socialismo”, organizzato dal Centro Internacional Miranda (CIM) nel giugno del 2009 per parlare pubblicamente dei problemi della “rivoluzione”, in molti iniziammo a nutrire dei dubbi sul processo che appoggiavamo criticamente.3 La creazione del CIM era stata proposta direttamente a Chávez da Marta Harnecker e dal suo compagno Michael Lebowitz. Era un centro di ricerca e di formazione politica che raggruppava parecchi intellettuali e militanti venezuelani, latinoamericani ed europei, per lo più baschi e spagnoli. Nell’intervento di apertura, Juan Carlos Monedero (sì proprio quello di Podemos…) stupì tutti affermando che la rivoluzione era soffocata dall’“iperpresidenzialismo” del Comandante. Lo stesso argomento fu sostenuto subito dopo dal rispettato militante e sociologo marxista Vladimir Acosta che enumerò altri problemi del processo fra cui la vaghezza del “socialismo del XXI secolo”. Ciò nonostante, per Acosta Chávez continuava ad essere l’anima, il cuore, i nervi e la forza del progetto bolivariano. Se invitava i sostenitori più acritici del governo a non liquidare sbrigativamente le sue critiche, allo stesso tempo riaffermava costantemente insieme agli altri oratori il suo sostegno e fede nella “rivoluzione”. Furono attaccati in modo grossolano da altre correnti del PSUV e da figure importanti del chavismo fra cui Nicolás Maduro e Cilia Flores, sua moglie, che in quel momento era vicepresidente del PSUV e presidente dell’Assemblea nazionale. Lo stesso Chávez si burlò di loro in televisione nel popolare programma Aló Presidente. Anni dopo, quando già era ammalato, chiamò in diretta un altro programma televisivo che stava intervistando Monedero per scusarsi, dicendogli che sull’“iperpresidenzialismo” aveva ragione. Nel frattempo, però, dopo quell’evento il CIM ricevette sempre meno fondi statali fino a dissolversi. Marta Harnecker e Michael Lebowitz continuarono ad essere chavisti, ma lasciarono il paese non molto tempo dopo. A partire da quel momento, qualsiasi critica al governo e al partito che valicasse la linea da essi marcata sarebbe stata stigmatizzata con il “fare il gioco dell’imperialismo”.
La Repubblica bolivariana non è diventata una “Potenza energetica mondiale” nel nuovo ordine multipolare che, come recita il Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (PPS 2007-2013), avrebbe contribuito a costruire.4 Tale ambizione è stata ribadita nel “testamento politico” di Hugo Chávez, la Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019,5 che, anzi, aumenta e rilancia nel proporre di trasformare il Venezuela in un “paese potenza in termini sociali, economici e politici all’interno della Grande Potenza Nascente dell’America Latina e dei Caraibi, per garantire la creazione di una zona di pace nella Nostra America”. Sebbene le esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti si siano dimezzate in questi anni, la dipendenza dal mercato statunitense è rimasta intatta. È l’unico grande acquirente che paga ancora in contanti. Gli altri soci, come la Cina, hanno già pagato in anticipo con enormi prestiti il petrolio che il Venezuela esporta. In sintesi, dopo la “riconquista” di PDVSA nel 2003, nonostante le numerose leggi e provvedimenti per consolidare la sovranità energetica, già da alcuni anni il governo bolivariano, per non esporsi ad ulteriori aggressioni, è diventato un semi-protettorato del “compagno Vladimir” per quanto riguarda la difesa e il salvataggio di imprese fra cui la CITGO, e del “compagno Xi” sul piano finanziario. Non è attore, ma convitato di pietra nel doloroso parto di un ordine globale multipolare che, dopo il 2008, è scivolato verso un “momento Polanyi” (Streeck), di “caos sistemico” (Arrighi, Wallerstein) e, per alcuni, persino di “crisi terminale” del capitalismo (ancora Wallerstein, Moore o lo stesso Streeck per quanto riguarda il capitalismo “democratico”). Il rinascere dello “spirito di Bandung”, cioè, la solidarietà internazionale fra i popoli del Terzo mondo, presenta oggi le stesse contraddizioni e ambivalenze degli anni ’70. L’ascesa della Cina e di un’altra manciata di paesi dell’ex Terzo mondo, oggi definito “Sud globale”, finora non sembra più benigna o favorevole nella lotta contro lo sfruttamento e l’oppressione. Nemmeno quando entra in conflitto con l’imperialismo statunitense ed europeo. La differenza fondamentale, però, è che oggi l’egemonia statunitense è davvero in disfacimento. Nella geopolitica impazzita delle sue élite militari, finanziarie e industriali, peraltro per nulla omogenee e coese al loro interno sul da farsi, innescare la profezia che si autoavvera, la “trappola di Tucidide”, ovvero, lo scontro inevitabile fra la potenza egemonica in declino e quella in ascesa, porta ad aprire nuovi scenari di guerra regionali e sub-regionali dopo il Medio Oriente. Il Venezuela è una vittima sacrificale in questo scenario, non un fuoco di resistenza.
Dal mio punto di vista, dopo la morte di Chávez e la caduta del prezzo del petrolio, la gestione di Nicolás Maduro e di Diosdado Cabello, incalzati dall’opposizione e dall’ingerenza esterna, ha solo esacerbato e fatto arrivare al limite le peggiori tendenze che il processo bolivariano ha conosciuto sin dal suo esordio e che non sono mai state rettificate, in un paese che è oggi allo stremo. Semmai, dal 2015 in poi, pur conservando i programmi sociali essenziali per mantenere un nucleo duro di sostegno popolare sempre più esiguo, ha adottato delle politiche economiche che per altri paesi e circostanze dovrebbero definirsi, senza ombra di dubbio, “neoliberali”. Fra queste, la svendita del territorio nazionale a multinazionali di mezzo mondo, fra cui anche quelle statunitensi, canadesi ed europee naturalmente. In altre parole, il saccheggio (capitalisticamente) organizzato delle risorse della nazione.
*****
Dopo l’autoproclamazione di Guaidó, il 23 gennaio, orchestrata insieme al governo degli Stati Uniti con l’appoggio del segretario dell’OAS e dei paesi latinoamericani riuniti nell’informale Gruppo di Lima, le sirene del golpe hanno risuonato nuovamente in Venezuela, per la prima volta seriamente, dopo il 2002.
Molti, a sinistra, hanno prontamente ripudiato l’aggressione rivendicando appieno la legittimità di Maduro, senza se e senza ma, seguendo la posizione ufficiale del governo di Caracas e del PSUV. Per tanti anni sono stato un tifoso dei CCCP, per cui capisco e rispetto chi decide di restare fedele alla linea (anche quando non c’è…). Tuttavia, l’equazione “se non stai con Maduro sei un traditore e un collaborazionista dell’Impero” o che, “oggettivamente”, ti stai schierando a fianco degli “yanquis de mierda” e dei golpisti, è ridicola e inaccettabile. La teoria del nemico principale è una faccenda del XX secolo, che riposi in pace. In Venezuela e in America latina, già da tempo cerca di fare sentire la sua voce chi non vuole il golpe e ripudia fermamente l’ipotesi di una guerra civile o di un intervento militare, ma si rifiuta di appoggiare o soltanto di considerare legittimo il governo di Maduro.6
Non esistono oggi argomenti di tipo legale, politico, etico, teorico o di altra natura per giustificare o squalificare totalmente nessuna delle due posizioni. Come è già successo in altre occasioni, non da ultimo per la Siria, in questo momento ci si può solo informare e fare informazione nella maniera più intellettualmente onesta possibile. A seconda di come si evolveranno le cose, specialmente se dovessero peggiorare, ognuno assumerà la posizione che considererà più giusta o opportuna, non escludendo ovviamente quella estrema di andare a combattere sul campo come ha indicato Davide Grasso. Senza dover chiedere l’autorizzazione o patenti di antimperialismo “autentico” a nessuno, ognuno sceglierà, insomma, non per chi ma dove suona la sua campana.
Note:
1- https://www.sinistrainrete.info/estero/13544-daniele-benzi-chiuso-per-fallimento-e-lutto.html. I corsivi sono stati aggiunti adesso.
3- Molti degli interventi sono ancora disponibili su https://www.aporrea.org/temas/68.
5- http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/ley_plan_patria.pdf
6- Vedi per esempio https://www.rebelion.org/noticia.php?id=251814; https://pueblosencamino.org/?p=7022; http://mareasocialista.org/2019/01/24/a-maduro-el-pueblo-no-lo-quiere-y-a-guaido-nadie-lo-eligio/
11 febbraio 2019
L’America Latina
| Daniele Benzi, “Venezuela. Per chi suona la campana?” pubblicato il 11/02/2019 in L’America Latina, su [https://lamericalatina.net/2019/02/11/venezuela-per-chi-suona-la-campana-2/] ultimo accesso 28-03-2019. |