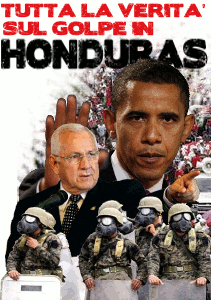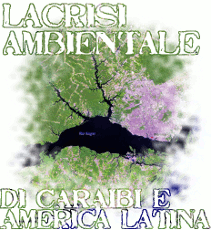La femminista boliviana María Galindo analizza il femminicidio come crimine dello stato. È un concetto teorico basato su un’esperienza concreta: il collettivo Mujeres Creando (Donne che Creano), che ha fondato e di cui fa parte María, accompagna il processo giudiziario del femminicidio di Andrea, la figlia di una delle sue aderenti.
E con questo dolore ha ricamato una bandiera di lotta sotto la quale dà rifugio a molte vittime che chiedono giustizia. Come ottenerlo? È la domanda che ispira questa riflessione partorita nella trincea.
Scrivo queste riflessioni con la rabbrividente sensazione di stare scrivendo con il sangue delle donne come inchiostro. Il sangue di Andrea versato sull’asfalto, il sangue versato sul podere che Verónica coltivava quando è stata assassinata, il sangue di lei; di quella di 50 anni, di quella di 30, di quella di 44, di quella di 18.
Ora è chiaro che quando parliamo di femminicidio stiamo parlando del “diritto universale” di ogni uomo di disporre della vita di una donna, anche fino al punto di eliminarla, diritto che caratterizza la società come una società strutturalmente patriarcale.
Sì, hai letto bene.
Non c’è errore nello scritto: il femminicidio rende visibile un diritto maschile di prendere la vita dell’ “altro”, che siamo noi, e di disporre di questa vita come gli pare e piace.
Quando parliamo di femminicidio stiamo parlando di una figura penale introdotta nei nostri codici di profilo molto recente (forse la Bolivia è uno degli ultimi paesi della regione ad averlo fatto). Una figura penale introdotta, che ha sostituito la precedente figura del “crimine passionale” con la quale ogni uomo poteva dire –di fronte al femminicidio dalla propria compagna–, di aver subito una violenta emozione, di aver subito un impulso di cui non era responsabile.
Quando parliamo di femminicidio stiamo parlando del diritto di sostituire una donna uccidendola, il diritto di eliminare una donna uccidendola, il diritto di bloccare la libertà di una donna uccidendola, il diritto di sovrapporre il potere del maschio su una donna uccidendola: è questo quello che rappresenta il femminicidio.
Per questo è un crimine contro la libertà delle donne.
Perché è la libertà di loro, di noi, quello che il femminicidio ha voluto bloccare.
Così si comprende perché moltissime volte il femminicida, nella sua narrazione criminale, non si riconosce come un assassino perché non si riconosce nel desiderio di uccidere una donna, ma nel diritto di impedire, bloccare, condizionare questo o quel comportamento di lei.
Questo è molto importante perché ci permette di comprendere che il femminicidio non è la tragedia personale di una donna che ha gestito male la sua relazione affettiva con un uomo o che si è imbattuta con l’uomo sbagliato nel momento sbagliato. Il femminicidio è un’arma patriarcale contro la libertà delle donne che consiste nell’eliminarle.
Il femminicidio è oggi un grave problema strutturale nelle relazioni uomo-donna in tutte le nostre società, perché rappresenta una forma di risposta violenta di fronte ad un processo di ribellione sotterranea che noi donne stiamo affrontando negli orizzonti di vita personale che ci siamo proposte. Abbiamo decine di casi che ci parlano di scene di femminicidio dove è la donna che voleva riscuotere gli alimenti, o è la donna che voleva divorziare, o è la donna che voleva mettere fine alla relazione. Il femminicidio è una narrazione sanguinosa di risposta di disciplinamento della totalità delle donne attraverso l’eliminazione e la morte di alcune di noi.
Il femminicidio funziona socialmente come un castigo patriarcale contro “la donna cattiva”, per questo l’insistenza di trasformare ogni femminicidio in una specie di giudizio morale sulla donna assassinata, dove è lei –che è già morta– quella che deve rendere conto della propria vita su misura della narrazione della femminilità.
Questo meccanismo del femminicidio come castigo e del femminicidio come diritto maschile universale su ogni donna, non funziona esplicitamente, ma è un meccanismo subcosciente collettivo di fronte al quale nella società c’è una negazione nevrotica. La società non riconosce che è così, pertanto, per negare nevroticamente questa realtà, si scatena intorno al femminicidio una specie di normalizzazione della morte delle donne, di rutine necrofila, di consumo della notizia della morte delle donne. Per questo si offre e si permette nei mezzi di comunicazione, all’interno dell’apparato giudiziario e di polizia la narrazione del femminicida che non si riconosce come assassino e che, anche con moltissima frequenza, diventa una vittima di fronte al “comportamento” della morta.
Il femminicidio non si misura in cifre
Questa riflessione ci porta anche a comprendere che il femminicidio non può essere misurato in cifre. Non è un crimine orribile per la quantità di donne. È un crimine orribile per il valore sociale che questo crimine ha, per l’immensa giustificazione sociale che si attribuisce all’assassino, per la grande protezione mediatica su cui conta, per la presunzione di innocenza che si trasforma in una presunzione di impunità.
Le cifre sono allarmanti, sì.
Attualmente in Bolivia stiamo parlando del fatto che ogni 3 giorni viene assassinata una donna in un contesto di femminicidio. Nonostante ciò, questa cifra è minore di quella reale perché sono molti i femminicidi che si riescono a coprire come suicidi, come incidenti o che semplicemente neppure vengono denunciati. Si uccide la donna, la si sotterra e la si sostituisce con la seguente nel paese, nel quartiere, nella famiglia, nella facoltà, nella comunità o nel lavoro.
Il femminicidio si trasforma in un castigo sociale perché funziona come messaggio per l’insieme delle donne che sono intorno alla morta: per le amiche, le vicine, le figlie e le parenti.
Quasi mi dà fastidio doverlo dire: non si tratta di trasformare la donna morta in una virtuosa perché è morta, non si tratta di trasformarla in martire. Noi amiamo la vita e siamo storicamente estremamente stanche della salvezza attraverso la via del martirio. Quello che accade è che la donna assassinata è stata assassinata a causa dell’esercizio della propria libertà, a causa del contrasto tra le sue decisioni personali e quelle del suo compagno sentimentale.
Il messaggio che il femminicidio lascia impresso nel subcosciente sociale è: per salvare la tua vita, per proteggere la tua vita, devi sottometterti. Che non si intenda che partiamo dalla necessità di convertire la donna morta in una falsa eroina perché questo sarebbe fare il gioco della tesi della salvezza attraverso il martirio.
La donna morta è quella spogliata di tutto il suo valore sociale.
La donna morta è quella che era in una lotta personale per la propria libertà personale individuale.
È quella sostituibile, è quella scomoda, è l’impiccio, è una cosa a perdere.
Questo è il contenuto politico che lo stato dà alla vittima, ed è in questo contesto che funziona come messaggio di castigo sociale su tutte noi.
La parola d’ordine Ni Una Menos (Non Una di Meno) –che mi piace e che ha percorso varie mobilitazioni contro il femminicidio (in vari paesi)– ci parla di questa percezione collettiva che noi donne, forse in modo molto intuitivo, abbiamo. È la conferma che noi collettività di donne riceviamo il messaggio che quando si uccide una donna, dietro c’è una strana sorte di annichilimento e sostituzione di noi. Per questo senza pensarlo gridiamo: “NI UNA MENOS”.
Più che una protesta, è in fondo una accettazione della morte per femminicidio come un annichilimento della libertà delle donne.
È una tacita accettazione del femminicidio come una guerra fisica, violenta ed ideologica contro le donne.
Ogni morta funziona come uno specchio.
Ogni morta funziona come una lapide che carichiamo su di noi.
Ogni morta è un messaggio di castigo.
Sono femminicidio i crimini contro le trans?
Gli assassinii contro le donne trans, per via dell’odio sociale o del maschilismo dei loro compagni, fanno certamente parte del fenomeno del femminicidio. Mi sembra che dovrebbe essere ovvio, nonostante ciò voglio spiegarlo.
Ogni donna trans non smette di essere donna essendo trans. È di più: smette di essere un uomo e si trasforma in una donna. Nonostante ciò, non si trasforma semplicemente in una donna ma carica sopra di sé un’altra forma di odio patriarcale. Lei è soggetta ad un esame maschilista di dover dimostrare se è donna o no. In molti casi, nelle sue relazioni eterosessuali, accetta forme di condizionamento che una donna –biologicamente vista come tale– non accetterebbe, perché in una società patriarcale una donna trans non ha la “legittimità di esserlo”.
Una donna trans, inoltre, carica dietro di sé l’odio di aver rinunciato, combattuto, non desiderato o non accettato, una presunta condizione di vantaggio sociale come è quella di “appartenere all’universo del maschio” e per questo la misoginia che si scatena contro di lei ha una grande carica violenta. C’è un grande desiderio di annichilirla.
Separare i femminicidi delle donne trans dai femminicidi delle donne biologicamente concepite come donne è indebolirci, è fare il gioco dell’omofobia, del maschilismo e dello stesso patriarcato. Perché loro condividono la questione di essere donne che non stanno rispettando il “concetto di esser donne”, e in questo contesto il femminicidio di ognuna di loro si aggiunge ai femminicidi commessi contro le donne, contro la nostra libertà e fa parte del medesimo massacro.
Il femminicidio di una donna trans è provocato dalle medesime regole del gioco del potere patriarcale dell’insieme dei femminicidi. Questo dovremmo comprenderlo nitidamente. È la medesima violenza maschilista e misogina di controllo del corpo e della vita che si scatena in un femminicidio contro una donna trans di quello che si scatena contro una donna non trans.
E se di femminicidi si tratta, gli attori degli uni e degli altri, agiscono con il medesimo codice del “diritto di disporre della vita dell’altro”, la cui vita vale meno della sua o la cui vita ha il diritto di controllare.
Quello che è chiaro è che per comprendere l’assassinio di una donna trans come femminicidio è necessario intenderlo all’interno di un ambito femminista di analisi di questo crimine, ed è questo che né lo stato e neppure il movimento Ellegibiti (LGBT), che si appropriano di queste morti, vogliono fare.
La responsabilità dello stato
Noi donne facciamo parte dell’Umanità?
Immaginate se i crimini commessi dalle dittature in America Latina si trasformassero, in un battere di ciglia, in un problema individuale di omicidio perché si è comportato male.
Immaginate se di repente i genocidi che l’Umanità giudica come crimini di lesa umanità perché colpiscono l’Umanità si trasformassero in un problema personale, individuale, di ciascuno dei morti.
Immaginate se cancellassimo l’Olocausto nazi contro il popolo ebreo, o se cancellassimo i crimini del colonialismo come errori dei conquistati per non essersi sottomessi.
Il femminicidio –sebbene sia stato tipificato nel Diritto Penale e in teoria riceva la pena massima– continua ad essere considerato dal nostro Codice Penale e dai codici penali su scala mondiale come crimine individuale e non collettivo.
Non sono giudicati come crimini contro le donne, né come crimini contro l’Umanità, ma il femminicidio è stato collocato all’interno del Codice Penale come un caso di crimine che si aggiunge agli assassinii, e a tutti gli altri tipi di crimine di un individuo contro un altro.
Allora la prima operazione che trasforma il femminicidio in un crimine dello stato patriarcale è nella forma teorica di come è stato concettualizzato dentro il Diritto Penale. Non ha concettualmente il carattere di crimine contro l’Umanità, non viene comparato al genocidio e lo stato, in questa misura, non lo riconosce come un crimine contro le donne in un ordine sociale patriarcale e, in questo contesto, lo stato non assume in modo diretto nessun tipo di responsabilità.
Il femminicida attenta alla vita di una donna e non contro la vita delle donne come parte dell’Umanità; questo cambia completamente la narrazione della tragedia in una narrazione personale, dove quello che si esamina è la vita della donna e non quella del femminicida. La narrazione non trascende il caso di un uomo concreto che ha ucciso una donna concreta, per ragioni personali, in contesti particolari.
Lo stato, non assumendosi nessun tipo responsabilità e di riconoscimento del femminicidio, come crimine analogo al genocidio, non si fa carico della perdita delle donne, né si fa carico della difesa della vita delle donne, in quanto metà dell’Umanità. E in questo contesto si trasforma in una specie di tacito complice del femminicida, trasformando il femminicidio in un crimine di stato.
Se intendiamo il femminicidio come effetto di una società patriarcale, lo stiamo riconoscendo come un problema sociale strutturale e non come un tipo di crimine –di uno qualunque– che si commette contro un’altra qualunque.
Il clima che dobbiamo affrontare quando in questo contesto abbiamo un caso di femminicidio è uno stato che per tutto il tempo ci strofina sulla faccia, come grande progresso e risultato, l’inserimento della figura del femminicidio nel Codice Penale. E sembrerebbe che dovremmo applaudire e ringraziare in ginocchio un simile progresso quando, in realtà, si tratta di una somma di confusioni concettuali molto importanti.
Non sono avvocata, né amante del Diritto, per cui chiedo che queste riflessioni si intendano da un contesto della riflessione politica e filosofica, che è anteriore alla riflessione concettuale giuridica.
Spogliare il femminicidio del suo contenuto di crimine di lesa umanità non è stata l’unica operazione che trasforma il femminicidio in un crimine di stato.
La seconda operazione è stata quella di isolare un caso dall’altro. Ogni donna che subisce un femminicidio appare come una storia a parte e in sé stessa. Pertanto, ogni causa è una, e ogni madre, sorella, figlia o fratello che chiede giustizia si trova afferrata nelle reti di un processo giudiziario che ha delle caratteristiche che dopo andiamo ad affrontare. Quello che mi interessa mettere in chiaro in questo è che una vittima si trova isolata dall’altra. Non possono lottare insieme, né stabilire basi di interpretazione comune dei crimini che affrontano. Questo divide le vittime e impedisce non solo che lo stato riconosca il carattere di crimine contro l’Umanità che ha il femminicidio, ma impedisce che le stesse vittime possano unirsi, manifestare insieme, delineare la grandezza del problema, unire le forze e dimostrare che siamo di fronte a crimini della dittatura patriarcale di cui lo stato è una parte organizzatrice.
E voi mi direte che il Diritto Penale è così.
Ripeto: non sono avvocata.
Ma considero che si sono dovute fare delle operazioni concettuali differenti e che la tradizione liberale di semplice incorporazione di diritti o di figure penali dentro il medesimo schema, alle donne non è servito quasi a nulla. Per questo, in realtà, l’incorporazione della figura del femminicidio ha fatto parte di una rutine del “copia incolla”, attraverso ong e agenzie di cooperazione, che dentro la nostra legislazione è stato fatto in modo quasi automatico perché tutto l’apparato non ha sentito nessun impatto né cambiamento strutturale nell’aggiungere una figura penale in più.
Isolare le vittime una dall’altra e impedire la collettivizzazione dei casi trasforma il femminicidio in un crimine dello stato patriarcale che determina l’impunità del femminicida e l’impossibilità sociale di costruire nuove forme di coscienza collettiva sul valore della vita delle donne.
Un torturato, perseguitato e morto per opera di un stato si converte in un crimine di stato.
Una quantità di crimini contro un collettivo per ragioni etniche si converte in un genocidio.
Un femminicidio, invece, non si converte in un crimine contro le donne, contro la società, né ancor meno di lesa umanità.
Si tratta di crimini isolati, di vittime isolate, di carnefici isolati e si impedisce concettualmente e politicamente l’associazione delle vittime attraverso la divisione e l’individualizzazione che lo stesso Diritto Penale impone. Come dire, si incorpora la figura del femminicidio, ma non si cambia in nessuno dei passi la logica di come lo si affronta.
La narrazione giuridica giustifica il femminicida e promuove l’impunità
La narrazione giuridica di un processo per femminicidio è determinata non solo dai pregiudizi o dal potere del carnefice, che è sempre maggiore del potere della vittima. Ma è data dalle metodologie del Diritto Penale: l’accusato è innocente fino a quando non viene provato il contrario ed è la parte accusatrice che deve dimostrare la sua colpevolezza. La parte accusatrice, inoltre, non è lo stato ma la madre o la sorella della vittima. Lì viene ratificata la garanzia dell’impunità, salvo che nei casi in cui il femminicida sia preso in flagrante o che si dichiari colpevole, che sono i meno. Il processo per femminicidio, pertanto, è un interminabile esame della vita della vittima. È un’interminabile somma delle virtù sociali del carnefice e una banalizzazione del valore centrale che è quello della vita. Chi dirime questi processi è lo stato che si trasforma in complice del femminicida trasformando, pertanto, il femminicidio in un crimine di stato.
La morte delle donne per femminicidio si diluisce nella rutine giudiziaria sotto migliaia di carte e grandi confusioni concettuali di fondo.
A questo bisogna aggiungere i pregiudizi maschilisti dei professionisti della giustizia, la corruzione che in questi casi determina sempre il vantaggio del carnefice, perché immancabilmente ogni uomo ha più denaro, più rilevanza della sua compagna assassinata, quasi come un riflesso della piramide sociale in cui noi donne ci troviamo: l’operaio avrà più rilevanza della sua compagna donna di casa o operaia, e l’impresario avrà più potere e rilevanza della sua compagna. Tutto questo che è l’unico vantaggio visibile non è altro che l’ultimo gruppo di fattori che determinano l’impunità sociale del femminicida di fronte alla vittima.
Diventa chiaro che non solo si sarebbero potute fare le cose in un altro modo, ma che si sarebbero dovute fare in un altro modo.
L’impunità riproduce impunità
Diventa chiaro, anche, che l’unica possibilità che abbiamo è costruire piattaforme collettive, che diventano molto difficili perché ogni caso penale non solo è un mondo, ma è spossante: consuma tutte le tue forze. E in questo senso, chiedere la partecipazione delle vittime ad una seconda istanza collettiva è chiedere più sangue e consumare completamente le loro vite. Se tutta la piattaforma dovesse assistere a tutte le udienze e analizzare tutte le irregolarità che si commettono –dall’autopsia fino al processo per impedire che sia garantita l’impunità del femmincidio– noi non ci dedicheremmo ad altro che non sia questo e solo a questo. Per questo noi abbiamo chiesto e preteso da Gabriela Montaño, presidente della Camera dei Deputati, una commissione legislativa di verifica giuridica che centralizzi questo lavoro e che inizi questo lavoro. Lo abbiamo fatto affinché sia chiaro che abbiamo una proposta e che la tesi su cui ci basiamo è che il femminicidio è un crimine di stato e non la tragedia personale di Carmen, Andrea, Julia o Verónica. Sappiamo che lo stato boliviano non ha nessuna volontà di fare questa commissione. Abbiamo allora formulato questa richiesta come un atto politico e come un orizzonte di lotta, coscienti che parliamo con una interlocutrice sorda e che parlare con lei era come “parlare ad un cielo sordo”.
Il femminicidio deve ricevere il trattamento del genocidio e dovrebbe, pertanto, essere trattato da tribunali speciali, come crimini di lesa umanità.
Questo è l’orizzonte di lotta.
Questa è la base concettuale per fermare l’impunità.
I crimini di femminicidio sono analoghi ai crimini commessi dalla dittatura.
Trasformando il dolore del femminicidio in lotta per la giustizia
Quello che dobbiamo intendere, avendo nelle braccia i corpi morti delle nostre amate figlie, compagne, amiche, è che la giustizia riproduce giustizia e che l’impunità riproduce impunità. Per questo apprezziamo tutti e ognuno degli sforzi che ogni vittima fa per lottare per la giustizia, anche se è in mezzo a processi che diluiscono il delitto, che mettono le vittime sul banco delle accusate, che relativizzano il valore della vita delle donne, e che si perdono nell’immensità di una tragedia femminile di grandi dimensioni.
Intendiamo, al medesimo tempo e in modo molto contraddittorio, perché sposta i processi in cui siamo immerse, che proporre il femmincidio come un crimine di stato è il modo più efficace di lotta: semplicemente perché al femmincidio bisogna creare una base concettuale di comprensione femminista del problema.
María Galindo
La Paz, Bolivia
Giugno 2016
03/06/2016
Lavaca
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| María Galindo, “#NiUnaMenos: Con la sangre como tinta” pubblicato il 03-06-2016 in Lavaca, su [http://www.lavaca.org/notas/niunamenos-con-la-sangre-como-tinta/] ultimo accesso 17-06-2016. |