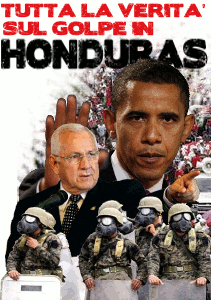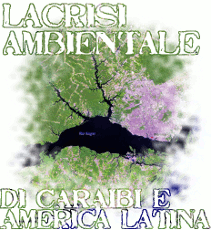Informale o Precario?
Negli ultimi giorni c’è stato un certo subbuglio mediatico per la diffusione di un rapporto dell’OIL e di un altro rapporto dell’UCA (Pontificia Università Cattolica Argentina) sulla cosiddetta “informalità lavorativa” in Argentina. La pubblicazione delle cifre vicino al 50% ha causato –secondo il Ministro del Lavoro– inquietudine. Al di là delle false intenzioni e della superficialità concettuale dei grandi media, il problema esiste e non è nuovo. Le statistiche sono disponibili da anni e riflettono un fenomeno globale: la scomparsa del paradigma del lavoro salariato come modus vivendi predominante dei settori popolari urbani.
Per comprendere meglio il tema è necessario fare alcuni chiarimenti. Ciò che riflettono le statistiche dell’informalità è la mancanza di iscrizione nei registri ufficiali di una determinata percentuale di lavoratori che si aggira tra il 40 e il 50 per cento secondo chi la misuri. Il lavoro informale o “non registrato” si divide in due grandi categorie:
- Il lavoro dipendente (comunemente conosciuto come lavoro nero) sia di imprese formali come di imprese informali;
- Il lavoro indipendente, sia individuale (per conto proprio) o collettivo (cooperative e altre forme di lavoro associativo).
Nonostante ciò, così questa categoria esprime solo uno degli aspetti del problema, non è né il principale né il più esteso. Quando si parla di informalità stiamo prendendo in considerazione l’inquadramento del lavoratore dentro le forme istituzionalizzate del lavoro e –in particolare– il pagamento dei contributi alla previdenza sociale (ANSES e altre casse). Il concetto di informalità non ci parla né di salario, né di diritti, né di condizioni reali di lavoro.
Il fenomeno lavorativo più esteso nell’ambito della globalizzazione neoliberista non è l’informalità ma la precarizzazione del lavoro. La precarizzazione non si limita al settore informale. Esiste una enorme quantità di lavoratori dipendenti registrati o parzialmente registrati (formali) in situazione di precarietà. Gli impiegati municipali e i tessili sono forse gli esempi estremi. I loro salari sono inferiori al minimo di sussistenza; le loro condizioni lavorative, deplorevoli.
Quando si parla di lavoro precario non si analizzano sistemi di registrazione ma condizioni reali di lavoro, entrate, diritti. Chi fissa la regola della precarietà? L’OIL stabilisce una regola che si potrebbe proporre come un livello innegoziabile di diritti per tutti i lavoratori. La chiama lavoro decente e abbraccia almeno i seguenti aspetti: a) rispetto dei diritti lavorativi; b) entrate adeguate e protezione sociale per la famiglia: c) sicurezza ed igiene sul lavoro; d) dialogo sociale, libertà sindacale, contrattazione collettiva e partecipazione.
Il concetto di precarietà lavorativa spiega meglio la situazione dei lavoratori in Argentina e nel mondo che l’informalità perché ci parla della violazione dei diritti. Nel nostro paese, senza alcun dubbio, più del 50% dei lavoratori –formali o informali, indipendenti o salariati– sono in situazione di precarietà. E anche così, l’Argentina ha uno dei migliori indicatori dell’America Latina!
I lavoratori esclusi e l’economia popolare
Esiste, inoltre, un nucleo duro della precarietà: i lavoratori esclusi. Per incontrarlo bisogna uscire dal “centro” del sistema economico e andare nelle periferie, mettersi dentro le villas (insediamenti informali caratterizzati da una densa proliferazione di abitazioni precarie, ndt), nelle discariche, nelle fiere all’aperto, nei laboratori clandestini, tra i raccoglitori di cartoni, nei vagoni del treno, tra i panni dei venditori ambulanti, alle fermate dei pony con le loro moto, nei monti santiaghegni, nelle fabbriche recuperate, nei gruppi dei programmi sociali.
Si tratta non solo di lavoro informale e precario ma anche di una forma di precarietà e informalità che non è suscettibile di essere superata senza un radicale cambiamento dell’orientamento dello stato. I nostri compagni non sono in nero, i loro processi di lavoro non saranno regolarizzati con moratorie, i loro problemi non possono essere affrontati dalla logica del settore privato. Perché? Perché questi lavoratori si trovano in un settore economico emergente che lo stato si rifiuta di riconoscere: l’economia popolare.
Noi definiamo l’economia popolare come l’insieme di attività economiche, unità produttive e lavori di sussistenza che portano avanti i settori più impoveriti della classe lavoratrice come alternativa all’insufficiente offerta di lavoro salariato. Questi processi hanno come comune caratteristica il fatto che i “mezzi di lavoro” (attrezzi, macchinari, merci, installazioni o spazi di vendita) sono alla portata dei settori popolari, fondamentalmente perché sono stati scartati dal Capitale come strumenti di accumulazione o perché il popolo povero li ha conquistati con la lotta.
 Così, i nostri mezzi di produzione possono giungere ad essere grandi fabbriche abbandonate dai loro padroni o importanti estensioni di terra fertile recuperata, anche se in genere si tratta di carri, piccole officine, veicoli sgangherati, piccoli appezzamenti e soprattutto, di spazio pubblico.
Così, i nostri mezzi di produzione possono giungere ad essere grandi fabbriche abbandonate dai loro padroni o importanti estensioni di terra fertile recuperata, anche se in genere si tratta di carri, piccole officine, veicoli sgangherati, piccoli appezzamenti e soprattutto, di spazio pubblico.
La forma lavorativa tipica che assume il settore popolare dell’economia è il cosiddetto lavoro indipendente. Si tratta di attività per conto proprio nelle quali non esiste rapporto di lavoro di dipendenza perché non c’è padrone, ma esiste una forte dipendenza economica dallo stato, dalla politica e dal mercato. A causa di questa forte vulnerabilità socioeconomica, sarebbe ridicolo dire che i nostri compagni sono “autonomi” assimilandoli ad un avvocato nel suo studio, ad uno psicologo nel suo ambulatorio o ad un disegnatore freelance di fronte al suo Mac. I raccoglitori di cartoni, i venditori ambulanti, i pony con le loro moto, i venditori nelle fiere, i contadini sono alcuni esempi di attività per conto proprio di mera sussistenza che si vuole inquadrare come lavoro autonomo.
Un’altra forma estesa di lavoro nel settore popolare dell’economia è il lavoro dipendente nelle imprese informali altamente precarie. Si tratta di piccole unità produttive che neanche per sogno potrebbero essere formalizzate secondo gli standard lavorativi, tributari e perfino della scienza dell’alimentazione del settore privato. Un chioschetto di quartiere, un deposito di cartoni, un’officina familiare, in genere di “proprietà” di persone della medesima condizione sociale dei propri dipendenti, molte volte vicini. In questo segmento ci sono livelli di stratificazione e –si potrebbe dire– di sfruttamento inaccettabili ma che non possono essere affrontati come meri problemi di polizia del lavoro né essere assimilati al “lavoro in nero”.
Una “terza modalità” che va crescendo dentro l’economia popolare è l’associativismo. Non si tratta di questo “cooperativismo bianco” del Banco Credicoop né delle utopie della “economia sociale” ma di qualcosa di molto diverso: sono organizzazioni produttive del popolo povero che assumono forme che non sempre si accordano ai canoni “democratici” né agli standard amministrativi del cooperativismo tradizionale. Grazie all’intervento di una militanza popolare veramente impegnata, queste unità produttive si moltiplicano e si perfezionano tanto negli aspetti tecnici come nelle forme sempre più comunitarie di coesione interna.
L’universo dei lavoratori dell’economia popolare rimane così circoscritto ai lavoratori che portano avanti attività lavorative –individualmente o collettivamente– all’interno del settore popolare dell’economia, questo con indipendenza dalla forma giuridica o dalle modalità relazionali che adotti la sua attività. Questa vera associazione degli esclusi e il suo sindacato più rappresentativo (la CTEP) devono essere urgentemente riconosciuti dallo stato se si vuole superare questa grande ingiustizia contemporanea: la precarietà lavorativa estrema, e la sua espressione istituzionale: l’informalità.
Una bolla d’accompagnamento per il superamento della “informalità”
Noi sosteniamo che il primo diritto di un lavoratore è il diritto ad organizzarsi. Non intendiamo l’integrazione sociale come un processo lineare dove un soggetto attivo (lo stato, la “società”) sussume un soggetto passivo (“gli esclusi”) dentro le proprie strutture ma come un processo dialettico nel quale le contraddizioni sociali si risolvono in una sintesi superatrice a partire dallo sviluppo dei conflitti mediante la lotta, il negoziato e l’accordo. Questo implica il riconoscimento dell’altro, della controparte, in questo caso, dei nostri compagni come soggetti sociali, delle loro lotte come legittime e delle loro organizzazioni settoriali come interlocutori. Questo è l’impoteramento (acquisizione di potere da parte di un individuo o un gruppo sociale sfavorito, ndt) di cui tanto si parla ultimamente.
Noi che attraverso le organizzazioni popolari –guidati dal movimento piquetero– abbiamo sostenuto senza strumenti istituzionali alcune delle rivendicazioni lavorative degli esclusi –questo “nucleo duro della precarizzazione”– facciamo un enorme sforzo per l’unità. Mettiamo da parte differenze politiche, personali, ideologiche, identitarie per costruire una organizzazione sindacale di massa. Lo stato, in cambio, non può farsi carico di questa sfida, forse perché è più facile dirigere questo settore sociale dall’atomizzazione organizzativa, rendendo invisibile la sua rappresentanza sindacale diluendola in una molteplicità di rappresentanze politico-sociali.
Alcuni critici della nostra proposta dentro lo stato e il movimento operaio evidenziano che il riconoscimento di un sindacato di queste caratteristiche implica istituzionalizzare la precarizzazione del lavoro, fatto che sarà utilizzato dalle associazioni degli industriali per flessibilizzare i lavoratori dipendenti e che in definitiva se l’economia marcia bene il settore “popolare” o informale tenderà a scomparire, ipotesi che l’evoluzione socioeconomica mondiale sembra scartare.
Per rispondere a questa motivazione, è necessario ricordare che anche i primi sindacati furono di lavoratori informali perché, precisamente, furono creati per regolare rapporti di lavoro che a suo tempo si reggevano su una presunta “libertà contrattuale” tra operai e padroni. Rendere visibili, inoltre, e dare voce ad un settore non implica in nessun modo legittimare le ingiustizie che subisce. Da ultimo, si deve evidenziare che il nostro stesso statuto sindacale stabilisce che nessun contratto che viene firmato possa andare a detrimento della Legge sul Contratto di Lavoro né dei Contratti Collettivi vigenti. Come ben sanno i tecnici del ministero, i diritti dei lavoratori relativamente alla subordinazione sono irrinunciabili e indisponibili per cui questo presunto risentimento al carattere flessibilizzatore della nostra proposta non ha alcun reale fondamento giuridico.
Il riconoscimento sindacale della CTEP come sindacato non è solo un dovere dello Stato Argentino nell’ambito della normativa dell’OIL e della posizione della delegazione nazionale nella 103 Conferenza Internazionale del Lavoro (nella quale, detto di passaggio, una raccoglitrice di cartoni affiliata alla CTEP ha brillato con la sua relazione), ma permetterebbe anche di discutere in un ambito paritario legittimo i problemi del settore che tanta confusione hanno creato e dirigere attraverso corsie costruttive la “conflittualità sociale” che preoccupa il potere politico. Il riconoscimento degli “informali” come lavoratori e l’istituzionalizzazione del loro sindacato è l’unico modo per superare l’informalità.
 In questo ambito, la CTEP porta avanti una serie di proposte che –in qualche modo– danno una risposta alle richieste che hanno dato origine ai dibattiti di questa settimana. Tra i vari temi possiamo enumerare:
In questo ambito, la CTEP porta avanti una serie di proposte che –in qualche modo– danno una risposta alle richieste che hanno dato origine ai dibattiti di questa settimana. Tra i vari temi possiamo enumerare:
- Universalità della Previdenza Sociale: l’ANSES dovrebbe garantire ai lavoratori dell’economia popolare l’accesso ai sottosistemi di previdenza sociale come contributi previdenziali, opere sociali, rischi del lavoro e assegni familiari; e ai basilari permessi di maternità e malattia mediante un Regime Speciale di Contributi per Lavoratori dell’Economia Popolare a partire dai contributi dei settori imprenditoriali che beneficiano del lavoro dei nostri compagni e dello stesso stato che riconosce il ruolo sociale e la dimensione soggettiva del lavoro.
- Regolarizzazione delle Unità Produttive Popolari: lo sviluppo di uno schema progressivo per la formalizzazione delle imprese informali. Questo non implica di voler far coincidere la realtà dei settori poveri con gli schemi del mercato ma, al contrario, trovare creativamente ordinamenti e normative che permettano di dare dignità alle condizioni di produzione e lavoro del settore popolare.
- Integrazione delle Entrate: lo sviluppo di una politica di massa di integrazione delle entrate legata alle attività e ai mestieri popolari affinché nessun lavoratore stia al di sotto del minimo di sussistenza.
- Modello di un’unica, coordinata e coerente politica del lavoro comunitario remunerato: la partecipazione da protagonisti dei lavoratori dell’economia popolare nel modello, mettere in funzione e controllare i programmi sociali con controprestazioni lavorative può aiutare a ridurre con il lavoro la frammentarietà, la feudalizzazione e l’incoerenza nell’amministrazione di validi programmi di entrate sociali che il governo nazionale mette in opera.
Per terminare voglio dare per sicura una posizione che non è mia ma di tutti noi lavoratori e militanti sociali che portiamo avanti l’istituzionalizzazione e la sindacalizzazione dei lavoratori dell’economia popolare: qui non si tratta del riconoscimento di un’associazione ma dell’integrazione di tutto un settore sociale escluso, processo che in Argentina abbiamo conosciuto durante il governo di Perón con l’irruzione dei lavoratori. La creazione di un sindacato democratico e riconosciuto dei descamisados (dei senza camicia, molto poveri, ndt) del presente, i nuovi cabecita (come erano chiamati in Argentina i migranti interni, nome popolare di una sottospecie di cardellini [, ndt), è condizione necessaria e il primo passo per superare l’informalità e, soprattutto, la precarizzazione del lavoro.
– Juan Grabois – Segretario della Formazione della Confederazione dei Lavoratori dell’Economia Popolare (CTEP).
16-10-2014
ALAI, América Latina en Movimiento
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Juan Grabois, “Trabajo informal, trabajo precario y economía popular” pubblicato il 16-10-2014 in ALAI, América Latina en Movimiento, su [http://alainet.org/active/78072] ultimo accesso 31-10-2014. |