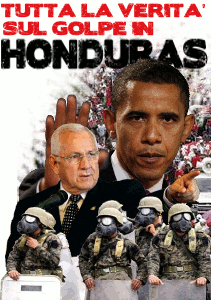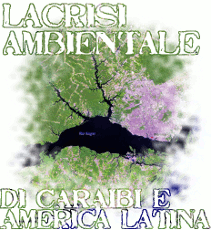Evo Morales è venuto ancora una volta in Italia, accolto da un pubblico numeroso ed entusiasta che giustamente vede in lui la nuova America Latina che resiste all’imperialismo e cerca una strada originale. Tuttavia mi sembra che il sostegno convinto a questa ed altre esperienze non debba escludere una visione a tutto tondo dei problemi e delle contraddizioni di questa ricerca del “buen vivir”. Per questo, alla presentazione sostanzialmente apologetica fatta sul “Manifesto” da Geraldina Colotti, che ha ripreso il taglio ottimistico di Luciano Vasapollo, e ha minimizzato gli attacchi di Morales all’intransigenza degli ambientalisti “che si oppongono ad alcuni progetti governativi come quello della superstrada che taglierebbe parte della foresta amazzonica boliviana”, presentati come “gruppi di persone che vivono bene”, ho pensato di affiancare questo articolo di Pablo Stefanoni, che cerca di distinguere la pratica politica del governo dalle formulazioni retoriche e propagandistiche. Stefanoni d’altra parte è un collaboratore del Manifesto. Dello stesso Stefanoni sul sito ci sono altri articoli tra cui il recente Evo riprende l’iniziativa mentre sulle contraddizioni di Evo era intervenuto precedentemente anche Guillermo Almeyra con due articoli, Bolivia, una contraddizione profonda e Bolivia: il prezzo del “capitalismo andino”
Evo Morales è venuto ancora una volta in Italia, accolto da un pubblico numeroso ed entusiasta che giustamente vede in lui la nuova America Latina che resiste all’imperialismo e cerca una strada originale. Tuttavia mi sembra che il sostegno convinto a questa ed altre esperienze non debba escludere una visione a tutto tondo dei problemi e delle contraddizioni di questa ricerca del “buen vivir”. Per questo, alla presentazione sostanzialmente apologetica fatta sul “Manifesto” da Geraldina Colotti, che ha ripreso il taglio ottimistico di Luciano Vasapollo, e ha minimizzato gli attacchi di Morales all’intransigenza degli ambientalisti “che si oppongono ad alcuni progetti governativi come quello della superstrada che taglierebbe parte della foresta amazzonica boliviana”, presentati come “gruppi di persone che vivono bene”, ho pensato di affiancare questo articolo di Pablo Stefanoni, che cerca di distinguere la pratica politica del governo dalle formulazioni retoriche e propagandistiche. Stefanoni d’altra parte è un collaboratore del Manifesto. Dello stesso Stefanoni sul sito ci sono altri articoli tra cui il recente Evo riprende l’iniziativa mentre sulle contraddizioni di Evo era intervenuto precedentemente anche Guillermo Almeyra con due articoli, Bolivia, una contraddizione profonda e Bolivia: il prezzo del “capitalismo andino”
Pablo Stefanoni, anche in questo denso articolo, mette in discussione soprattutto l’uso strumentale dei discorsi “pachamamici” in seminari di formazione o tribune internazionali, che non costano niente, ma è stato per questo accusato di disprezzo per le tradizioni indigene. Il problema della strada del TIPNIS ha comunque costretto a mettere sul tavolo tutta una serie di problemi, e su questi Stefanoni discute francamente. (a.m. 14/6/12)
Antonio Moscato
14 Giugno 2012
———————————————————
E chi non vorrebbe “viver bene”? Insidie del processo di cambiamento boliviano
Pablo Stefanoni
[da Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano] [1]
Negli anni successivi alla Prima Guerra mondiale, nel mondo si diffuse quella sensazione che il tedesco Oswald Spengler sintetizzò nel suo libro più famoso: Il declino dell’Occidente. A parte il titolo, il fascino di quell’opera stava nel fatto che Spengler vi sosteneva che i cicli culturali nascono, crescono, invecchiano e muoiono, e affermava inoltre la natura storicamente relativa della conoscenza: una sorta di “provincializzazione” dell’Europa ante litteram. Nella seconda metà degli anni Venti, più esattamente nel 1926, lo storico e giurista argentino Ernesto Quesada visitò La Paz, e vi dettò una conferenza largamente diffusa sulla “sociologia relativista spengleriana”, cui aveva dedicato vari anni della sua vita, alla quale partecipò l’allora presidente boliviano Hernando Siles. Le influenze irrazionaliste, vitaliste e mistiche segnarono, come sappiamo, quel decennio. Non c’è quindi da stupirsi che, nel 1929, il conte Herman Keyserling fosse arrivato in Bolivia e, osservando le splendide rovine di Tiwanaku, provasse la sensazione di calpestare un universo abitato da uomini esattamente “mineraloidi”, alimentando le tendenze telluriche già sviluppate nella letteratura e nella cultura boliviana dell’epoca. Di più, Quesada (attratto in vecchiaia da quei temi) discuteva con Spengler su chi avrebbe soppiantato l’Occidente, sostenendo che il cambio sarebbe venuto dagli indigeni d’America e non dagli schiavi. La questione sembrava riassumersi in chi avesse un’anima meno contaminata dalla cultura occidentale.
Erano questi gli sciocchi ed intensi anni Venti, mentre agli inizi del XXI secolo il disagio all’interno della globalizzazione, con la crisi dei vecchi progetti di emancipazione, ha potenziato lo sviluppo di nuove ricerche, in cui la cosiddetta emergenza indigena degli ultimi anni ha un ruolo centrale, in un certo senso con la stessa speranza che il passato ancestrale potrà fornirci alcune chiavi per l’ingresso in un futuro incerto, con minacce di vari tipi di crisi: economica, finanziaria, ecologica e … di civiltà?
In questo contesto in cui il cosiddetto “viver bene” (suma qamaña) o “buon vivere” (sumak kawsay) trova il brodo di coltura per la sua diffusione ben oltre i confini in cui è nato come discorso alternativo (in particolare Ecuador e Bolivia), con il controvertice sul clima di Tiquipaya come uno degli spazi in cui si è messo in gioco un discorso che contrasta la stessa mondializzazione capitalistica e i suoi modelli di produzione e consumo. [2]
Ovviamente, sono tante le ragioni del suddetto disagio, in un mondo sempre più ingiusto, consumista, infestato da disuguaglianze e iniquità. Di fronte agli eccessi di uno sfrenato produttivismo e le scommesse tecnologiche dell’economia verde, si imporrebbe la costruzione di altri rapporti con la natura (e tra gli stessi esseri umani), demercificando i vincoli e distinguendo il benessere dall’accumulazione di ricchezza. Ciò nonostante, la volontà sicuramente encomiabile di ricercare alternative non elimina la necessità di porre in discussione le inconsistenze, i punti oscuri, gli eccessi retorici e le contraddizioni del “viver bene”; meglio ancora, la possibilità di affrontare seriamente e con forza il capitalismo attuale rende indispensabili queste discussioni. Ed è questa la prospettiva sottesa al presente articolo, basato sulla convinzione che una critica fondata e sfumata è ben più proficua che non l’eterna – e acritica – reiterazione dei topici criteri del “viver bene”, un discorso – va detto – che si fonda piuttosto sul bisogno di credere che ci sia vita oltre questa insoddisfacente (post)modernità, che non sulla specifica concretezza delle proposte alternative.
Che cos’è il “viver bene”?
In una serrata riunione a La Paz con dirigenti di primo piano del governo boliviano in carica, nel 2001, la domanda stringente del dibattito fu “che cos’è il viver bene?”. Com’è ovvio, che nessuno possa essere contrario al significato letterale del termine depone contro quell’aggiunta di significato che vi si vuole inserire – spesso parlando in luogo degli stessi strati subalterni. È scontato che nessuno può essere contrario al “viver bene”, ma la cosa si fa sicuramente più complicata quando questo “viver bene” – che sarebbe non sviluppista, non consumista e anche non moderno/occidentale – viene contrapposto al “vivere meglio”, che comporterebbe, tramite il capitalismo, che altri vivano peggio.
Nell’incontro citato emersero svariate – e sorprendenti – risposte dei funzionari ivi presenti. Un importante parlamentare indicò come “viver bene” equivalga tout-court allo Stato del Benessere [Welfare State] di tipo europeo. Un funzionario della vicepresidenza – con trascorso di militanza marxista –sostenne trattarsi di un progetto “anticapitalista”. Da una prospettiva diversa, un altro funzionario indigeno spiegò che il viver bene è la costruzione di un’etica del lavoro e della personale indipendenza (fece l’esempio dei commercianti aymara che, con fatica, sono riusciti a conquistarsi una buona condizione economica e adesso vanno alla festa da ballo del Grande Potere con tanto di agenti di sicurezza privati che li proteggono da possibili furti, dato il valore dei loro gioielli). Infine, un militante del Movimento al Socialismo (MAS) di El Alto espresse l’opinione che il “viver bene” comprende l’accesso alla sanità, all’istruzione e ad altri servizi, ma dovrebbe comprendere anche alcune misure riguardanti la felicità.
 Come si può vedere, la gamma di fantasie dietro l’elusivo “viver bene” è sufficientemente ampia e in genere non viene messa in discussione. L’ambiguità intrinseca di un “concetto in costruzione” viene riempita di idee diverse e a volte da eccessive dosi di wishful thinking [un pio desiderio…]. Il problema si complica ancor più poiché i suoi promotori non invitano, come certi gruppi religiosi, alla fuga personale dalla modernità: al contrario, si postula il suma qamaña come un complesso di idee destinate alla trasformazione di sistema volta a partecipare alle lotte antiegemoniche e ad offrirsi anche come alternativa al capitalismo laddove non ci sono indigeni. Anche nel mondo sviluppato. Ignora completamente, tuttavia, che le sfide attuali in Occidente provengono da paesi – Cina, India, Brasile – basati su uno sviluppismo feroce, con strati privilegiati sul fronte culturale mondiale e senza mettere chiaramente in discussione certe idee forza della modernità.
Come si può vedere, la gamma di fantasie dietro l’elusivo “viver bene” è sufficientemente ampia e in genere non viene messa in discussione. L’ambiguità intrinseca di un “concetto in costruzione” viene riempita di idee diverse e a volte da eccessive dosi di wishful thinking [un pio desiderio…]. Il problema si complica ancor più poiché i suoi promotori non invitano, come certi gruppi religiosi, alla fuga personale dalla modernità: al contrario, si postula il suma qamaña come un complesso di idee destinate alla trasformazione di sistema volta a partecipare alle lotte antiegemoniche e ad offrirsi anche come alternativa al capitalismo laddove non ci sono indigeni. Anche nel mondo sviluppato. Ignora completamente, tuttavia, che le sfide attuali in Occidente provengono da paesi – Cina, India, Brasile – basati su uno sviluppismo feroce, con strati privilegiati sul fronte culturale mondiale e senza mettere chiaramente in discussione certe idee forza della modernità.
Il problema di fondo del “viver bene” è che i suoi diffusori non sono riusciti – né si sono sforzati di farlo – a collegare un programma che presumibilmente nasce dalle visioni del mondo indigene alle esperienze di vita degli indigeni e delle comunità realmente esistenti. In secondo luogo, queste proposte sembrano scollegate dal dibattito macro e microeconomico e dall’elaborazione di proposte di transizione connesse “all’altro mondo possibile”. Problemi come il lavoro, l’innovazione, la tecnologia, il mercato e tanti altri temi con cui è andato a sbattere il socialismo reale (Nove, 1987) – rendendo ormai chiaro come sia imprescindibile affrontarli in un progetto post-capitalista – vengono totalmente diluiti in una retorica semi-mistica in certi casi, o semplicemente utopico/alterculturale in altri, con un rischio immediato: nel caso boliviano, il processo di trasformazione si scontra ogni giorno con vecchi problemi quali la debolezza dello Stato e le insufficienze istituzionali, un accesso alla sanità inferiore ai livelli minimi di benessere, un’istruzione che riproduce le disuguaglianze di origine e un lungo elenco di eccetera, eccetera. Di fronte a tutto questo, la ricetta (quasi magica) è lo Stato Plurinazionale.
Meno ancora la proposta del “ben vivere” si ricollega al dibattito sulla specializzazione economica che la Bolivia dovrebbe scegliere, il modello produttivo, se il tipo di cambiamento debba venire dall’alto o dal basso e su altre questioni di un’altra sfera in cui, in assenza di proposte alternative, si impongono naturalmente i “tecnici”, che hanno amministrato in modo prolisso la macroeconomia nell’era di Evo, ma entro certi margini piuttosto conservatori (un dato di per sé indiscutibile, visti i precedenti insuccessi delle sinistre al potere – specie negli anni Ottanta – ma che invita a ridimensionare le aspettative di rifondazione). Risulta ovvio che tra la ritualizzazione del lavoro agricolo – e i meccanismi di reciprocità nelle comunità – che si portano normalmente ad esempio di pratiche alternative – e la costruzione di un’alternativa post-capitalista (nonché post-neoliberista) minimamente articolata c’è un tratto lunghissimo, che può riempirsi soltanto cercando di generalizzare alcune esperienze già esistenti, non tramite semplici “olistici” ideali – quali l’armonia, la reciprocità e la vita – senza base economica né sociologica, e senza una spiegazione convincente su come applicare alla città questi modelli. Nel migliore dei casi, esistono interpretazioni piuttosto discutibili sulle forme di reciprocità e l’utilizzazione di spazio nelle grandi fiere, come quella del 16 luglio a El Alto; ma queste analisi non includono il modello industriale della zona, basato sul lavoro familiare, ma anche sullo sfruttamento del lavoro.
Per giunta, però, non affrontando seriamente i problemi economici “di fondo”, le critiche al capitalismo e le analisi catastrofiste dei fautori del “viver bene” alimentano una pericolosa ingenuità politica e intellettuale che le rende facilmente confutabili, sia da parte dei neoliberisti sia da quella dei neosviluppisti. In realtà, il “viver bene” non si propone di soppiantare il capitalismo; la sua proposta – così come presentata nella nuova Costituzione – è il modello del pluralismo economico, senza che si sappia come si articoleranno economia comunitaria con economia statale ed economia privata, tranne che con l’immagine del treno usata dal vicepresidente García Linera, in cui l’economia comunitaria era l’ultimo vagone (quella statale il primo). Per altro verso, poiché non è compresa nella proposta la rinuncia ai beni di consumo tecnologicamente sofisticati, beni che è impossibile costruire nel quadro di economie comunitarie, queste ultime dipenderebbero immancabilmente dai prodotti fabbricati nella sfera capitalista. Ma non occorre andare tanto lontano: basterebbe limitarsi a pensare ai prodotti dell’industria alimentare, che incidono in misura crescente sul consumo dei contadini e che provengono dall’economia di mercato. In generale, i sostenitori del “viver bene” rispondono ad ogni richiesta di precisazione che “bisogna applicare la Costituzione”. Tuttavia, senza idee intermedie, in grado di concepire processi di transizione e demercificazione degli spazi crescenti di vita collettiva, si finisce per cadere in una sorta di feticismo costituzionale, in cui la lettera della Magna Carta potrebbe sovrapporsi al paese realmente esistente.
Chi sono gli indigeni?
Un tema aggiuntivo è quello della difficoltà di stabilire linee di demarcazione tra indigeni e non indigeni. Già fin dalla Colonia, le categorie etniche costituirono un terreno scivoloso. E, in molti casi, l’idea di continuità dei gruppi etnici precolombiani si scontra con una serie di ostacoli significativi, in parte a causa dei trasferimenti di popolazioni ad opera degli incas (i mitimaes) e alle successive politiche etniche della Colonia, volte a indebolire il potere residuale dei discendenti degli incas, comunque riconosciuti come nobili dalla Corona spagnola. Altri processi, ad esempio l’aymarizzazione degli urus, attestano le tensioni interetniche precoloniali. Esistono tuttavia, a propria volta, i confini mobili dell’“indianità”, che si manifestavano in larga misura nei censimenti. Essa comportava, nella Colonia, una condizione fiscale (versamento del tributo indigeno) e giuridica (la massa degli indios venne considerata “miserabile”, mentre i nobili incas vennero riconosciuti come tali). Diventerà poi una condizione biologica al culmine del darwinismo sociale, una condizione di classe negli anni Cinquanta del XX secolo (indigeno = contadino) e, negli anni Novanta del secolo scorso, un’appartenenza etnico-culturale grazie all’auto-identificazione, come concretamente attestato dal censimento del 2001.
 La stessa categoria di meticcio ha subito cambiamenti e, se oggi è simbolo di criollo [meticcio nato da uno dei genitore indigeno e l’altro bianco, NdT], nel XX secolo era pressoché sinonimo di artigiano urbano: falegname, confezionatore di polleras, [le gonne tradizionali, NdT] fabbro, cappellaio, ecc.. Vi furono alcuni momenti in cui bianchi e meticci si censivano insieme ad altri (alla fine del XX secolo) e si differenziarono quando, sembra, il governo popolare di Manuel Isidoro Belzu introdusse il distacco della plebe, della “chusma” [ciurmaglia] e dei cholos [meticci di padre europeo e madre andina] dagli aristocratici, tra atti di violenza da parte dei gruppi popolari urbani contro gli strati privilegiati.
La stessa categoria di meticcio ha subito cambiamenti e, se oggi è simbolo di criollo [meticcio nato da uno dei genitore indigeno e l’altro bianco, NdT], nel XX secolo era pressoché sinonimo di artigiano urbano: falegname, confezionatore di polleras, [le gonne tradizionali, NdT] fabbro, cappellaio, ecc.. Vi furono alcuni momenti in cui bianchi e meticci si censivano insieme ad altri (alla fine del XX secolo) e si differenziarono quando, sembra, il governo popolare di Manuel Isidoro Belzu introdusse il distacco della plebe, della “chusma” [ciurmaglia] e dei cholos [meticci di padre europeo e madre andina] dagli aristocratici, tra atti di violenza da parte dei gruppi popolari urbani contro gli strati privilegiati.
Non sono però cambiati solo i criteri di definizioni delle categorie etniche, ma cambiano le stesse società. E la Bolivia è diventata, nel XXI secolo, un paese in cui la maggioranza della popolazione è ubicata in città e paesi di oltre 2 milioni di abitanti, nel quadro di un processo di abbandono delle campagne e di migrazioni che, in certe zone, somigliano a una diaspora, con alcuni elementi che, perlomeno a prima vista, possono apparire sorprendenti. Lo stesso Evo Morales è un buon esempio dell’indianità contemporanea: fin dall’adolescenza, non vive più in una comunità, non usa le lingue indigene salvo in rare occasioni, ha assunto l’identità di sindacalista… ed è celibe, cosa che gli impedirebbe di rivestire una carica comunitaria tradizionale, perché lo si fa solo attraverso il matrimonio. Non c’è quindi da stupirsi, in questo scenario, che le chiavi ermeneutiche del momento attuale siano intimamente connesse alle letture dei processi migratori e degli spazi urbani post-comunitari, in cui il comunitario rurale ha una sua nuova attualità e un suo nuovo significato, all’insegna di nuove eterogeneità interne, di meccanismi di differenziazione, costruzione di prestigio, ecc. Che cosa significa, ad esempio, essere aymara (un’identità legata al mondo rurale e alla tradizione) in uno spazio, la città, che suggerisce concetti quali modernità e sviluppo?
Albó, Greaves e Sandóval affrontano il problema agli inizi degli anni Ottanta, enfatizzando le continuità rurali-urbane. Ad esempio, si riferiscono al cholo come a “una variante culturale aymara”, come dire che le pratiche culturali non sono un mero residuo dell’“aymara rurale” ma un vero e proprio “fondo culturale”. Di più, considerano l’auto-identificazione di molti aymara urbani come meticci una nuova identità fittizia. Esisterebbe dunque un’identità nascosta, che spetta al ricercatore rivelare, prescindendo dalle stesse personali auto-rappresentazioni dei soggetti.
Albó et al. sostengono, infatti, che gli aymara urbani sono a cavallo di due mondi ed ammettono che ci sono resistenze dei contadini a considerare “fratelli” e jaqi (una persona aymara) gli immigrati urbani e che questi ultimi cercano di costruire tratti marcanti che li distinguano dai contadini (abbigliamento, orecchini, nuovi stili di balli e generi musicali). E – ancor più importante – le feste avrebbero smesso di avere lo stesso contenuto di quelle in campagna. Lungi dal sottolineare l’uguaglianza, la collettività, ecc., lo status e il prestigio si stabilirebbero nello stesso modo in cui il denaro diventa il sostituto delle offerte rituali alla Pachamama nelle challas in ambiente cittadino [durante le feste di carnevale]. Paradossalmente, nel momento in cui la Bolivia diventa un paese sempre più urbano dal punto di vista demografico, sale al potere un partito contadino, in un’esperienza unica nel continente.
Il TIPNIS: un punto di inflessione
 Dopo il suo avvento al potere, è stato evidente che Evo Morales non ha vinto nessuna elezione con la proposta del “viver bene”, perlomeno con la sopracitata aggiunta di significato che le attribuiscono i fautori di questa. Ma non è stato un caso, ad esempio, che chiudendo la campagna elettorale del 2009 nella città di El Alto il leader dei contadini coltivatori di coca (cocaleros) abbia parlato solo di opere pubbliche e politiche di sviluppo, di fronte alla delusione dei tanti stranieri che ascoltavano il lungo discorso pieno di promesse concrete e di cifre. Più di recente, in un’intervista diffusa dal programma della giornalista Amalia Pando, il governatore di La Paz – Pablo Ramos – rispondeva che la principale richiesta dei contadini è l’elettrificazione rurale – oltre alla costruzione di strade -, cui il governo ha destinato rilevanti stanziamenti.
Dopo il suo avvento al potere, è stato evidente che Evo Morales non ha vinto nessuna elezione con la proposta del “viver bene”, perlomeno con la sopracitata aggiunta di significato che le attribuiscono i fautori di questa. Ma non è stato un caso, ad esempio, che chiudendo la campagna elettorale del 2009 nella città di El Alto il leader dei contadini coltivatori di coca (cocaleros) abbia parlato solo di opere pubbliche e politiche di sviluppo, di fronte alla delusione dei tanti stranieri che ascoltavano il lungo discorso pieno di promesse concrete e di cifre. Più di recente, in un’intervista diffusa dal programma della giornalista Amalia Pando, il governatore di La Paz – Pablo Ramos – rispondeva che la principale richiesta dei contadini è l’elettrificazione rurale – oltre alla costruzione di strade -, cui il governo ha destinato rilevanti stanziamenti.
Il problema è che la realtà boliviana – e degli indigeni – a volte si analizza con una visione viziata dal gusto per l’esotico. Risulta piuttosto chiaro dal documentario “Perché è crollato McDonald’s?”, nel quale si offre l’immagine dei boliviani che si nutrono di cibi sani, igienici e nutrienti, in contrapposizione al “cibo spazzatura” della catena statunitense, cosa che ne spiegherebbe l’abbandono del paese agli inizi del 2000. Su questa linea, non si dice assolutamente nulla, ad esempio, dell’estendersi del fast food in città popolari come El Alto, con ristoranti con nomi del tipo di Andrews Chicken. Stando ai dati del suo segretario generale, l’Associazione dei lavoratori del fast food di El Alto raggruppa circa 300 proprietari di ristorantini, dove si mangia prevalentemente pollo arrosto (Pagina 7, 25 febbraio 2012).
In molte di queste costruzioni della “Bolivia indigena” c’è una visione troppo ruralizzata del paese, mentre circa il 60% dei boliviani vivono in zone urbane, e gli indigeni “puri” sono connessi al mercato locale e globale (come risulta evidente dall’espandersi del narcotraffico e del contrabbando di macchine giapponesi usate tramite il Cile, che ha comportato l’assassinio di vari poliziotti). Ancor meno si inserisce nelle analisi “pachamamiche” la consistente conversione al protestantesimo tra i settori indigeni, cosa che contribuisce a ricomposizioni modernizzanti delle comunità e a trasformazioni delle visioni del mondo indigene/originarie. Presenza cristiana, va sottolineato, che è anche importante in seno al blocco indigeno/popolare governativo, come si può notare tra i membri della convenzione del MAS all’Assemblea Costituente che, insieme alla destra, si opposero alla legalizzazione dell’aborto e all’inserimento nel testo costituzionale di altri diritti sulla riproduzione.
C’è poi il problema della struttura produttiva. Sebbene in Bolivia lo Stato sia tradizionalmente debole, l’economia privata è ancor più debole, per cui le logiche dei detentori di redditi operano come legge ferrea della politica, come si può notare nei primi mesi del 2012 con il susseguirsi di vari conflitti: medici in sciopero contro l’aumento dell’orario di lavoro giornaliero da 6 a 8 ore dietro richiesta dei contadini; insegnanti sul piede di guerra per aumenti salariali; miniere occupate alternativamente da contadini e da membri di cooperative di minatori; conflitti tra municipi e dipartimenti per problemi di confini (incluso l’accesso a risorse naturali, ad esempio pozzi di gas); gente non riconosciuta come avente diritto che si scontra violentemente con la polizia per chiedere un buono sociale; popolazioni che linciano (sospetti) delinquenti e gli mettono al collo cartelli come “sono un ladro peruviano”, tra i tanti altri scontri. Senza dubbio, tuttavia, quella che ha avuto maggior diffusione internazionale è la resistenza da parte degli indigeni del Territorio Indigeno Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) alla costruzione di una strada il cui tracciato originario divideva in due il Tipnis e ne minacciava lo spazio vitale. Inoltre, secondo gli indigeni, il tracciato favorirebbe l’espandersi dei cocaleros che già si sono installati nel cosiddetto Poligono 7, a sud del parco di 12.000 chilometri quadrati.
Il conflitto del Tipnis è importante, tra l’altro, perché ha cancellato la possibilità di fare progetti neo-sviluppisti a livello delle politiche governative e di continuare a fare discorsi “pachamamici” in seminari di formazione o tribune internazionali, che non costano niente, a quanto pare. Il problema della strada ha costretto a mettere sul tavolo tutta una serie di problemi che sono, appunto, le difficoltà di mettere con i piedi per terra prospettive post-sviluppiste cui nessuno si oppone (o meglio, si opponeva prima del conflitto del Tipnis), ma anche che (quasi) nessuno sostiene quando si tratta di decidere politiche pubbliche in una riunione di gabinetto. In un paese in cui i “movimenti sociali” ormai sono al potere, i tempi delle alternative non possono restare completamente sfasati rispetto a quelli della politica. Il conflitto del Tipnis ha messo in luce diverse questioni:
– i modi a volte bruschi con cui il governo cerca di imporre i suoi piani (com’era già successo con il fallito “gazolinazo” del dicembre 2010);
– che occorre procedere in modo creativo per trovare soluzioni per le difficoltà che si vanno presentando: in questo caso, come rendere compatibile l’esigenza tradizionale di integrazione materiale del paese con i nuovi diritti dei popoli indigeni (e della natura stessa, se prendiamo sul serio il “viver bene”);
– il fatto che le fantasie di consumo dei settori popolari boliviani – per indigeni che siano – non sono poi troppo diversi da quelli degli altri settori plebeo/popolari del continente e del mondo.
Ma c’è di più: nel caso del Tipnis, i più entusiasti promotori della strada non sono gruppi oligarchici (anche se alcuni strati privilegiati della zona amazzonica e imprenditori sono favorevoli al tracciato) ma i cocaleros, ormai demonizzati da vari dei sostenitori del “viver bene” e dal gruppo di ex funzionari diventati critici che rivendicano il “rinnovamento” del processo di trasformazione.
 Tutto ciò ha posto in risalto come parlare degli “indigeni” non dia conto di alcuna concreta identità e si avvicini di più a un’identità globale probabilmente costruita nel mondo delle ONG, degli organismi internazionali e di altre aree lontane dalla vita popolare e subalterna realmente esistente. Per capire i dilemmi e le difficoltà del processo di cambiamento boliviano sembra indispensabile riproporre il concetto di “interesse”, vale a dire analizzare le posizioni in gioco in base alle situazioni di classe, geografiche, regionali, ecologiche, ecc., in cui i diversi settori costruiscono le loro identità, le loro strategie e il loro interesse collettivo. Ad esempio, l’idea – tra gli stessi aymara e quechua –che gli indigeni amazzonici siano selvaggi o primitivi ha una lunga tradizione fin dall’epoca degli incas e non è estranea al modo in cui coltivatori di coca ed altri contadini prendono oggi in esame il problema della strada del Tipnis.
Tutto ciò ha posto in risalto come parlare degli “indigeni” non dia conto di alcuna concreta identità e si avvicini di più a un’identità globale probabilmente costruita nel mondo delle ONG, degli organismi internazionali e di altre aree lontane dalla vita popolare e subalterna realmente esistente. Per capire i dilemmi e le difficoltà del processo di cambiamento boliviano sembra indispensabile riproporre il concetto di “interesse”, vale a dire analizzare le posizioni in gioco in base alle situazioni di classe, geografiche, regionali, ecologiche, ecc., in cui i diversi settori costruiscono le loro identità, le loro strategie e il loro interesse collettivo. Ad esempio, l’idea – tra gli stessi aymara e quechua –che gli indigeni amazzonici siano selvaggi o primitivi ha una lunga tradizione fin dall’epoca degli incas e non è estranea al modo in cui coltivatori di coca ed altri contadini prendono oggi in esame il problema della strada del Tipnis.
Come effetto ulteriore, la dinamica di scontri creata a partire dalla VII Marcia indigena delle Terre basse – con ampio sostegno dei ceti medi urbani – contro il progetto della strada ha spinto il presidente Evo Morales a sostenere che “l’ambientalismo è il nuovo colonialismo” (Opinión, 2012), cosa che, detta così, butta a mare molte delle sue affermazioni ai controvertici sul clima e in altre assise internazionali, ad esempio l’Onu.
In questo quadro, la lotta del Tipnis ha suscitato nel gruppo che promuove il “rinnovamento” del processo di trasformazione la tentazione di cercare lì i veri soggetti del cambiamento, il che comporta indubbiamente il rischio del disprezzo delle maggioranze popolari – rurali e urbane – che hanno trasformato i rapporti di forza aprendo il varco all’attuale processo post-neoliberista a pro di soggetti ideali che – questa volta sì – potrebbero auspicare un “reale” cambiamento. Queste concezioni non sono estranee alle prospettive politiche delle rivoluzioni eternamente tradite, in funzione di parametri costruiti al di fuori di una “sociologia” dello stesso processo politico e sociale.
Nel caso boliviano, fin dall’inizio dell’attuale ciclo politico è esistita una confusione tra la radicalità del cambiamento delle élites e quella delle nuove élites, una differenziazione non secondaria, dal momento che un’analisi basata su un minimo di realismo sociologico mostra un gioco complesso in cui i settori popolari boliviani ( e non solo popolari) sostengono il volto “buono” dello Stato (politiche redistributive), mentre possono battersi a morte – a volte letteralmente – contro quello “cattivo”: e cioè, l’imposizione di tasse, le leggi sull’importazione e altre regolamentazioni che limitano varie forme di “capitalismo popolare” presenti nel paese. Le complicate combinazioni tra conservatorismo e radicalità costituiscono un substrato ineludibile nell’analisi politica boliviana.
È ovvio che ciò ha profonde cause storiche, connesse alla stessa costruzione nazionale, e che non si tratta di criminalizzare l’“informalità”; ma oggi è chiaro che è impossibile costruire progetti alternativi al capitalismo egemone senza partire da questa sociologia economica. Sociologia economica che spiega, alla fine, perché si siano imposte strade diverse al “viver bene” più o meno mistificato, in favore del “capitalismo andino”, o perché i leader contadini hanno effettuato un “colpo di Stato” che ha estromesso dal suo incarico il viceministro delle Terre, Alejandro Aimaraz, fautore della dotazione comunitaria dei terreni. Da vari anni, infatti, gli aymara e i quechua si stanno opponendo alle Terre Comunitarie di Origine (TCO) e denunciandone i proprietari, soprattutto i popoli d’Oriente demograficamente meno numerosi, come “proprietari terrieri indigeni”.
La stessa idea di “rinnovamento” promuove un immaginario relativo a un’“età dell’oro” dell’attuale processo di cambiamento, mai esistita. Fin dall’inizio, il discorso del “viver bene” coincideva con aspettative assai più concrete di “vivere meglio”: nello stesso governo si parlava di un grosso balzo industriale e un giornalista del giornale statale Cambio poteva scrivere un lunghissimo articolo auspicando che la grande distesa salata di Uyuni fosse attraversata da enormi centrali nucleari. Tutto questo si è ridotto al potenziamento di due grandi illusioni: il neosviluppisno – che immagina un’espansione industriale di dubbie possibilità di realizzazione – e l’illusione comunitaria, fondata su soggetti ideali e su un comunitarismo astratto, zeppo di figure retoriche ma incapace di migliorare le condizioni di vita dei boliviani. Tra i due estremi, quel che resta è un neo-estrattivismo con una certa redistribuzione degli introiti e uno Stato molto più attivo che non nel periodo neoliberista – sommato all’indebolimento del colonialismo interno tramite lo Stato Plurinazionale-
Non è poco. Di fatto è molto meglio di quanto vissuto in qualunque altra fase della storia delle Bolivia. Ma quel che manca è gigantesco, non solo per costruire un’“altra civiltà”, ma per assicurare che quasi la metà della popolazione esca dalla povertà. In questo compito, però – come ha segnalato Pedro Portugal Molinado – l’esotizzazione degli indigeni li allontana dal potere – non li avvicina.
Traduzione di Titti Pierini
Note:
[1] Il testo del presente Cuaderno è ricavato da quello pubblicato dal n. 7 della rivista Crítica y Emancipación, Buenos Aires, CLACSO, 2012 (disponibile anche in www.biblioteca.clacso.edu.ar).
[2] Qui teniamo conto del solo caso boliviano; in Ecuador il “ben vivere” si articola e discute diversamente.
| Traduzione di Titti Pierini: |
| Pablo Stefanoni, “BOLIVIA – E chi non vorrebbe “viver bene”? Insidie del processo di cambiamento boliviano” pubblicato il 14-06-2012 in Movimento Operaio, su [http://antoniomoscato.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=903:bolivia-viver-bene&catid=8:lamerica-latina&Itemid=16], ultimo accesso 20-06-2012. |