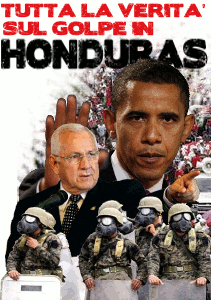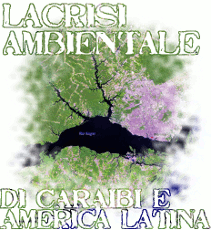(Intorno al dibattito sull’etica e la politica)
(Intorno al dibattito sull’etica e la politica)
Arturo Anguiano
La guerra della paura e dell’insicurezza
Il testo del Subcomandante Insorgente Marcos1 pone delle questioni centrali che caratterizzano l’attuale situazione del paese. La guerra contro il cosiddetto crimine organizzato, particolarmente contro le mafie del narcotraffico, che dall’inizio del suo mandato Felipe Calderón ha messo in pratica, è una guerra che non dice ciò che è, che si nasconde e, nei fatti, ha condizionato l’insieme della gestione statale, trasformandosi nel segno distintivo del panismo al potere. È chiaro che questa guerra non è stata imposta a Calderón, non è stata il risultato di una crisi specifica causata da qualche salto qualitativo del crimine organizzato che, senza rimedio, richiedeva di cambiare in modo radicale le priorità governative.
Il narcotraffico e le sue implicazioni compromettenti sono questioni che vengono da lontano, con molte spine e, soprattutto, non è, né mai è stato, estraneo ai governi, all’apparato statale né, molto meno, all’oligarchia del denaro. È un problema che ha a che vedere con il modo come da sempre la corruzione si è trasformata in un tratto non solo del regime padronale e del suo funzionamento, ma in parte della cultura politica che ha messo radici durature e profonde nel nostro paese. Si collega anche alle strategie neoliberiste che hanno impoverito ampi strati della popolazione, lasciandoli senza aspettative e, certamente, alle forme perverse di accumulazione provocate dalla mondializzazione del capitale.
La guerra di Calderón punta solo su ciò che è più evidente, che è la produzione ed il consumo di droghe verso gli Stati Uniti senza attaccare le cause di fondo che potrebbero smantellare questo affare redditizio. È, piuttosto, una specie di fuga in avanti, di arretramento, di fronte ad una situazione di crisi politica causata dal modo fraudolento con cui divenne presidente della Repubblica e dalla conseguente crisi di legittimità delle istituzioni statali che ha portato con sé. È, come ci ricorda Carlos Aguirre Rojas, un’altra forma della politica statale2, una espressione perversa dell’incapacità di formulare alternative alla crisi statale che non cessa.
All’inizio la virata verso la guerra è stata una elementare giocata in cerca di un riconoscimento attraverso delle azioni di forza, portando nelle strade l’esercito attribuendo illegalmente funzioni di polizia (condannando per cominciare le varie polizie e tutto l’apparato che assicura la giustizia ad apparire come incompetenti e sospetti).
Però, immediatamente, la situazione è scappata di mano al presidente e la violenza ha imposto la propria logica travolgente. Proclamando come obiettivo prioritario il ristabilimento della sicurezza che le sue stesse azioni non hanno smesso di peggiorare e di generalizzare, in realtà, cerca disperatamente solo un consenso sociale, un riconoscimento, che non raggiunge ma tutto il contrario. Operazioni giudiziarie fallite, criminalizzazione della dissidenza e delle opposizioni sociali, scontri frequenti e quasi sempre imprevisti tra le forze paramilitari (cartelli della droga) e militari (inclusa la marina, anche lei lanciata nella guerra fuori dal suo ambito naturale e dalle sue funzioni), posti di blocco e operazioni militari selettive e massicce hanno lasciato una lunga scia di violazioni reiterate dei diritti umani che, invece di legittimare il governo, hanno aumentato il discredito delle forze armate, che invariabilemente appaiono come arbitrarie, prepotenti e fuori della legalità. Più di 40 mila morti è stato finora il pesante costo della guerra di Felipe Calderón. Forse la maggioranza prodotto dagli scontri delle differenti mafie criminali o di queste con l’esercito, ma molti, centinaia o migliaia (inclusi bambini) estranei al conflitto, cinicamente giustificati come “danni collaterali”.
Così il governo del Partito di Azione Nazionale (PAN) ha puntato sulla sicurezza, che ha trasformato nel connotato definitivo del suo sessennio, indirizzando risorse economiche di ogni tipo e sempre più sproporzionate, come lo evidenzia nel suo testo il Sup Marcos. Ma più che una guerra per recuperare ed imporre la sicurezza perduta in certe regioni o stati sensibili a causa delle azioni del crimine organizzato, ciò che ha fatto è di generalizzare l’insicurezza in tutto il paese. La presenza massiccia dell’esercito nelle strade delle città ed in ogni tipo di luoghi altera la vita della gente, che più che sentirsi protetta si sente minacciata e subisce ogni tipo di controlli, violazioni e rappresaglie senza che cessi la presenza ugualmente minacciosa e letale del crimine organizzato. L’arbitrarietà, i montaggi e le menzogne dei militari e del governo, rafforzati dall’avallo indiscriminato e opprimente dei mezzi di comunicazione, sono l’altra faccia della guerra di Calderón, che in realtà è stata finalizzata all’aumento della paura, alla creazione tra i vari strati sociali di un consenso impaurito di fronte all’assenza di un consenso sociale effettivo. Però, mentre avanza sempre più la guerra, anche le classi privilegiate ne stanno risentendo le sue conseguenze, che non smettono di intrecciarsi con una economia massimamente diseguele che, sebbene li abbia arricchiti, va dalla crisi al ristagno.
Lo stato, pertanto, appare come il responsabile dell’insicurezza imposta con la paura. Il presidente Calderón sembra che abbia appreso dall’esperienza di George W. Bush che, attraverso le pretese minacce catastrofiche, la propaganda mediatica e le bugie di stato, impose una guerra contro l’Irak che gli permise di stabilire e accrescere il suo potere (armato di maggiore violenza ed illegalità) negli Stati Uniti e nel pianeta con la promessa della gestione dell’insicurezza stabilita sulla paura3.
Come sottolinea Sergio Rodríguez Lascano nel suo contributo al dibattito4, il proposito principale della guerra di Calderón “non è di far finire il narcotraffico, ma di distruggere il tessuto della società. Paralizzare per il timore, per la paura. Governare per mezzo di questi strumenti”. Già il precedente governo del PAN, guidato da Vicente Fox, promosse una offensiva contro i movimenti sociali – e in generale contro ogni resistenza ed opposizione –, imponendo la loro criminalizzazione e ricorrendo a forme di repressione massicce (come ad Atenco e Oaxaca nel 2006), caratterestiche della guerra a bassa intensità che dal Chiapas è andata estendendosi agli altri stati. Con il pretesto della guerra al narcotraffico, Calderón ha sviluppato, come politica di stato, l’incremento della paura e della paralisi, questo è, il conformismo, la sottomissione rassegnata, l’insicurezza come modo di vita che richiede la protezione statale e, di conseguenza, l’intervento e la presenza massiccia e generalizzata delle forze armate.
Le lotte di protesta contro lo sfruttamento, la precarizzazione ed il saccheggio, il rifiuto delle mascherate democratiche della classe politica e l’esigenza delle libertà usurpate non sono possibili in un Messico militarizzato, soggetto a regole arbitrarie e ad uno stato di emergenza virtuale. La vita nazionale è sconvolta in una atmosfera catastrofica riprodotta quotidianamente dai mezzi di comunicazione e dai governi, diretta a mettere in un angolo i vari settori sociali, a forzarli a rimandare le proprie richieste ed azioni per lasciare attuare liberamente il governo nella sua guerra sempre più coinvolgente, o correre il rischio, chiaramente, di aggiungersi alla lista dei danneggiati collaterali. La guerra contro il narcotraffico è solo una delle guerre del governo, dappertutto porta a termine anche una autentica guerra sociale contro le condizioni di vita e di lavoro, contro le comunità depredate in mille modi di terre e risorse naturali a favore del capitale globale, contro gli emigranti nazionali e stranieri, contro i giovani, le donne e coloro che pensano differentemente, contro i popoli indigeni che non smettono di resistere ricreando le proprie condizioni di organizzazione e convivenza collettiva.
Stato di polizia e autoritarismo
La centralità della guerra del governo per forza comporta un rafforzamento dell’autoritarismo, un certo tipo di legalità (di giustizia?), le libertà limitate e la violazione dei diritti umani. Come sempre, lo stato di diritto viene lasciato come una semplice aspirazione per il futuro, mentre lo stato d’emergenza e le sue regole arbitrarie viene giustificato dalla situazione di guerra, instaurata come forma fallita di legittimazione di un regime politico che fa acqua da tutte le parti.
Rodríguez Lascano sottolinea come avanza una sorta di “stato penale di controllo nella misura in cui si riduce lo stato sociale”. Anche se difficilmente di può dire che in Messico sia esistito un autentico stato sociale, la cosa certa è che, dagli anni ottanta, si stanno smantellando prestazioni, conquiste e riforme sociali che, bene o male, hanno permesso per un certo tempo certe sicurezze e, perciò, una sopravvivenza ad ampi strati della popolazione molto al di sopra della precarizzazione generalizzata che il capitalismo neoliberale ha causato. Parodiando Rancière, possiamo dire: “Lì dove la merce regna senza limiti… la forma di massimo consenso è quella che è fondata sulla paura di una società riunita intorno allo stato guerriero”. Quando lo stato “minimo” abbandona le sue funzioni di intervento sociale e lascia libero corso alla legge del capitale, appare “lo stato ridotto alla purezza della sua essenza, ossia, lo stato di polizia”. E finisce contundente: “La comunità di amore che sostiene questo stato, e che amministra in suo favore, è la comunità della paura”5.
La criminalizzazione di opposizioni e lotte sociali e la presunta guerra contro il narcotraffico stanno acutizzando la crisi dello stato e del regime politico che – come vediamo – si allontanano sempre più da una riconfigurazione democratica. Hanno abbandonato definitivamente la ricerca della stabilità assicurata da processi politici liberi ed hanno optato per la riaffermazione della dominazione sottoforma di una approssimativa protezione dell’esercito. Cercano di imporsi mediante la gestione del disordine e dell’insicurezza.
Però la paura promossa dall’alto sta dappertutto per essere vinta a causa dell’indignazione che germoglia abbasso contro i metodi della guerra e delle sue conseguenze sociali devastanti. Vengono ristabilite nuove solidarietà e reti sociali che, nelle peggiori condizioni e controcorrente, denunciano le campagne di disinformazione e manipolazione dei mezzi di comunicazione collegati al potere e svelano le sue menzogne, i suoi montaggi e fini occulti.
In questo senso accredita la proposta della menzionata prima lettera del Sup Marcos, che ha ripreso la campagna del “Non più sangue” lanciata da vari caricaturisti capeggiati da Rius, dove cita in giudizio la classe politica, organizzada nei distinti partiti, affinché smetta di puntare sul disastro nella contesa per il potere nel 2012, e propone la possibilità di un grande movimento plurale che possa fermare la guerra di Calderón.
La mobilitazione nazionale che Javier Sicilia è riuscito ad organizzare, dopo l’assassinio di suo figlio, Juan Francisco, insieme a sui tre compagni nel Morelos, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una rabbia contenuta, ha cominciato ad organizzarsi sotto forma di un Movimento Nazionale per la Pace con Giustizia e Dignità con chiari echi zapatisti. La sua Carovana del Dolore – che ha percorso il centro ed il nord del paese fino a Ciudad Juárez – lo scorso 10 giugno si è conclusa con la firma di un Patto Nazionale Cittadino il cui epilogo ancora non è chiaro.
La costruzione delle alternative
La guerra è, senza dubbio, un elemento decisivo della situazione nazionale che non può essere aggirato, di modo che la lotta contro quella in tutte le sue forme, espressioni e conseguenze è analogamente quella di unire le molteplici resistenze che sbocciano e si sviluppano con ritmi, forme di organizzazione e fini molto diversi, nei numerosi angoli del paese. Insisto su ciò che scrissi in un recente articolo6: esiste una vera rivolta quotidiana di quelli abbasso che sembra invisibile, poiché esiste il blocco deliberato dai mezzi di comunicazione. Sicuramente, le esperienze di pratiche sociali, di autorganizzazione e resistenza che si manifestano stanno dando forma a nuovi spazi pubblici recuperati e ad una politica differente da quella statale che è solo il regno della classe politica.
Il Sup Marcos menziona la distruzione delle basi dello stato che il capitalismo neoliberale e la guerra del governo stanno provocando. In realtà, questo ci rinvia alla decomposizione del regime politico e all’impossibilità di un suo recupero, ciò che urge è che si discuta ampiamente per trovare le crepe e le
essure che possano essere aggredite per la sua caduta. La fine delle vecchie mediazioni (corporativismo, clientelismo, padronalismo) e l’esaurimento prematuro delle nuove (i partiti, le istituzioni statali degradate) acutizzano la crisi politica, la crisi statale che avanza verso una possibile uscita autoritaria. La classe politica vive presa nella sue lotte per il potere puntando sulla decomposizione ed il disastro nazionale con il proposito di migliorare ciascuno la propria relazione di forze. L’autismo sociale di tutti i partiti contrasta con i loro sforzi di legarsi o di diventare graditi (gestori credibili) all’oligarchia finanziaria disincantata dall’incompetenza dei governi del PAN. Le elezioni presidenziali e nazionali del 2012 non saranno se non un momento in più del declino di una politica statale bloccata, che molto probabilmente esprimerà la delusione e la rabbia della società.
Se non si possono fare cambiamenti effettivi dall’alto, è necessario tesserli dal basso. Però, bisogna dimenticarsi completamente di ciò che succede in alto? Non si dovrebbe anche provocare la caduta di quelli che sono in alto, la distruzione definitiva di ciò ch rimane delle loro basi e reti di potere, della dominazione che in qualunque modo continuano a garantire in nome dell’oligarchia del denaro?
Questo ha a che vedere con l’idea che viene presentata nel dibattito in corso rispetto al fatto che tutto il mondo attuale sarà distrutto, e si intende che non sarà una autodistruzione, una immolazione, quantunque quelli in alto facciano molto per questo. Distrutto, sì, ma da chi? come? con che tempi? costruendo poco a poco spazi autonomi e autogestiti? riformulando geografie e calendari? aspettando che la gente sia stanca, si organizzi da sé stessa e si ribelli?
La rivolta quotidiana di quelli abbasso assume molte ed innumerevoli forme e vie, ma il problema senza dubbio più incalzante è il suo carattere frammentato, e di qui l’urgenza di esplorare come collegarle e trovare la loro continuità, la loro persistenza, la loro capacità di creare sedimenti.
L’esperienza dell’Altra Campagna deve essere ripresa, per cominciare, ridiscutendo il modo in cui è stata portata a termine, il suo significato ed i risultati. È stato un modo per incontrarsi dal basso, di riscoprirsi, di creare lagami, confrontare condizioni e situazioni, ma ugualmente per scorgere il futuro.
A differenza dei partiti e delle loro oligarchie corrotte, abbiamo bisogno di pensare a lungo raggio, di ridefinire le prospettive, di pensare di nuovo in termini strategici. Il movimento per la pace con giustizia e dignità guidato da Javier Sicilia è, anche, un’altra esperienza che si colloca abbasso, contro gli altri che sono il governo e le oligarchie politiche ed economiche. I tentativi, come quelli che stanno realizzando le comunità ribelli zapatiste, stanno continuando in vari luoghi del paese mediante forme specifiche. In altri terreni e spazi, in altre geografie, non smettono di scoppiare rivolte contro la miseria, il degrado e l’oppressione imposta dal capitalismo, ma anche contro la guerra del governo. Come articolarle stabilmente?
L’accerchiamento e la situazione di sopravvivenza, la paura e la rassegnazione che il governo di Felipe Calderón ha preteso di imporre, non sono riusciti ad impedire la fioritura delle opposizioni di quelli abbasso. Ancor più, l’esclusione che implica il monopolio della politica statale da parte dei partiti, produce anche un allontanamento crescente di quelli abbasso dai circuiti istituzionali caratterizzati dal clientelismo e dalla corruzione, e stanno qualificando spazi pubblici sempre più spesso, come dicono gli zapatisti.
La nostra società mai è stata completamente polverizzata dall’individualismo e dalla generalizzata mercantilizzazione causata dal capitalismo, ma il collettivo è stato sequestrato dal corporativo, sottomesso e gerarchizzato. Le figure politiche che lo hanno accompagnato nei paesi industrializzati (la democrazia rappresentativa e le libertà individuali) non hanno creato in Messico se non cittadini mutilati, con diritti usurpati. Né cittadini, né individui. Il collettivo è apparso per iniziativa dei settori oppressi e sebbene sia stato confiscato dal corporativismo gestito dal PRI, ha ora più possibilità di riaffermarsi dal e per mezzo di quelli abbasso, costruendo autonomie e replicando la politica degli oppressi, nelle comunità ribelli che in molte varie forme e circostanze germogliano in lungo ed in largo della nazione.
Il collettivo deve, inoltre, staccarsi dal clientelare che è alla base delle relazioni con il potere e, generalmente, con quelli in alto e con la classe politica. Il collettivo implica solidarietà e uguaglianza che necessariamente possono essere costruite solo collettivamente, da tutte e tutti. L’individuo si può sviluppare solo in relazione agli altri individui, nella sua socializzazione, e per questo il collettivo lo potenzia, più che annientarlo o diminuirlo. Chiaramente, con una logica solidaria, non di concorrenza, di guerra di tutti contro tutti.
Non puoi avere alternative individuali né alla guerra contro il narcotraffico e le sue conseguenze, né contro la guerra sociale che il capitale e l’oligarchia statale fanno contro quelli abbasso, i loro interessi, necessità ed esigenze di ogni tipo. Le soluzioni saranno solo collettive, dal basso e alla sinistra, come dice l’EZLN.
Un’altra politica etica
Più che i temi dell’etica e della politica, ciò che vedo nel dibattito realizzato su Rebeldía è una preoccupazione (una necessità) di una nuova politica, sotto principi chiari, conforme agli interessi di quelli abbasso. Come costruire una alternativa anticapitalista, democratica e autogestita sul lungo periodo? L’organizzazione è decisiva, ma quale (o quali), come, con quali principi, su quali terreni e, soprattutto, all’interno di quale prospettiva, questo è, che ruolo gioca in una visione strategica.
L’etica e la politica dal basso implicano la dignità, la coerenza, la verità, esattamente il contrario di ciò che caratterizza la politica statale, la politica dall’alto e l’oligarchia statale che tutti qui chiamiamo classe politica e che possiamo ben definire come dell’angoscia. Certamente, implica anche l’uguaglianza, la solidarietà e la fraternità, quest’ultima quasi sempre anche dimenticata.
Mi sembra pertinente e centrale che venga recuperata la riflessione critica sul processo e le circostanze che stiamo vivendo, in realtà, soprattutto sull’esistente che certamente ci riguarda. Ma richiede che venga assunta collettivamente, non solo come somma di riflessioni individuali che si confrontano in dibattito. Soprattutto in vista di, e per, la pratica, l’azione, il pensare ed il fare collettivi. E qui mi sembra sbagliato criticare coloro che pensano, convivono, affrontano in modi diversi quelli in alto ed anche resistono e lottano negli spazi dell’accademia, delle università, dei centri di ricerca ed insegnamento. La critica vera, radicale nel senso di Marx, è per sé stessa una espressione di ribellione, di dissidenza rispetto al potere e ai suoi mandarini.
“Mettere il corpo”, come dice Raúl Zibechi7, è compromettersi, agire, non solo scrivere o lanciare idee, ciò che può succedere in una grande varietà di terreni e per vie molto diverse. Di fronte agli intellettuali “istituzionali”, diventati anche controrivoluzionari, come tanti in Messico negli ultimi decenni (in realtà da sempre), sedotti dal potere e dal denaro, c’è una lunga lista di resistenti, di ribelli, anche rivoluzionari, le cui analisi e critiche sono importanti per decifrare le chiavi della dominazione e per aiutare ad affrontarla, certamente, dal basso. Sono una fonte inesauribile di pensiero critico, compromesso.
Non percepisco nessuna crisi terminale né nessuna fine della politica, come quelle che annuncia Carlos Aguirre Rojas nel suo contributo. Per cominciare, considero che non esistano crisi terminali del capitalismo senza l’azione dei soggetti sociali collettivi che lo demoliscano, distruggano i suoi poteri, le sue relazioni, il suo stato. La politica che vedo in crisi è la politica in alto, la politica statale che pretende sottomettere qualsiasi altra forma di politica, la politica dei giochi di illusoria rappresentanza e degli spazi pubblici istituzionali monopolizzati dagli attori politici ufficiali, la politica divenuta mediatica, al piacere e sotto l’agenda dettata dai monopoli della comunicazione di massa.
Però la politica può essere un’arma di quelli abbasso, che possono riprenderla come lo spazio del confronto, della dissidenza, della enunciazione di decisioni e pratiche collettive dirette a dar vita e convivenza alle comunità nello spazio comune.
Di nuovo riprendo Jacques Rancière: “La politica, nel senso forte del termine, è la capacità di qualunque di occuparsi degli affari comuni. Comincia con la capacità di cambiare il proprio linguaggio ordinario ed i propri piccoli dolori per appropriarsi del linguaggio e dei dolori degli altri”8. E va ancor più in là: “C’è politica, dal mio punto di vista, in ogni forma di lotta, di azione, di intervento che riaffermi la decisione sugli affari comuni come affare di qualunque, e come la dimostrazione di uguale capacità di qualunque” (p. 181).
La politica dal basso è il contrario della politica di specialisti che la monopolizzano e la trasformano in uno spazio esclusivo e ristretto, estraneo alla maggioranza della società, soprattutto, a coloro che non sono i padroni del denaro. È la politica dei veramente uguali, non nella formalità delle leggi, ma nella vita quotidiana, come compagni, colleghi, vicini, amici, eccetera. La politica dal basso è l’invenzione quotidiana della politica su tutti i terreni, in tutte le circostanze, in tutte le lotte. Non riconosce la separazione del sociale e del politico, ma parte come presupposto della sua interrelazione, del suo carattere complesso, sempre politico-sociale. La politica dal basso, la politica dell’oppresso, non riconosce rappresentanti né delegati, quantunque in qualche momento siano necessarie delle mediazioni, e per questo la revoca del mandato è una condizione. È, allora, l’azione diretta, l’autonomia, l’autogestione realizzate da quelli direttamente coinvolti.
La politica dell’oppresso è una politica di resistenza, ma anche di riaffermazione di identità, di scontro, di lotta per ristabilire le condizioni e le basi della covivenza ugualitaria nello spazio comune. Dire che è una politica dal basso e a sinistra, significa che non si realizza negli spazi predisposti dallo stato, ma attraverso altri canali e negli spazi che recupera, riadatta e crea. È, certamente, una politica che scommette sul futuro, che cerca di preparare l’avvenire ugualitario, giusto, dove la democrazia, la libertà e la uguaglianza prevalgono. Ma lo fa da qui e da ora, senza interessarsi delle conseguenze né delle conclusioni sempre incerte. Come scrisse Daniel Bensaid: “Se l’ordine esistente è inaccettabile, bisogna sforzarsi per cambiarlo, senza nessuna garanzia di ottenerlo”9. Come diceva Mario Payeras10, la politica dell’oppresso è, infine, “l’assedio dell’utopia”.
Note :
1. Subcomandante Insurgente Marcos, “Apuntes sobre las guerras. (Carta primera a Don Luis Villoro Toranzo)”, Rebeldía, México, núm. 76, 2011.
2. “La guerra, la política y la ética. Reflxiones sobre una carta”, Rebeldía, México, núm. 77, 2011.
3. Vedere Jacques Rancière, Moments politiques, La fabrique éditions, Paris, 2009, p. 124.
4. “La clase política y la guerra”, Rebeldía, México, núm. 77, 2011. Sullo stesso concetto, dello stesso autore, “2010: de la crisis de dominio a la organización independiente”, Rebeldía , México, núm. 76, 2011.
5. Ídem, p. 125.
6. “La revuelta cotidiana”, Rebeldía, México, núm. 75, 2010.
7. “La ética necesita un lugar otro para echar raíces y fl orecer”, Rebeldía, México, núm.77, 2011.
8. Libro citado, p. 67.
9. Daniel Bensaid, “Por une politique de l’opprimé”, ContreTemps, Paris, Nouvelle série, n 6, 2e trimestre 2010, p. 42.
10. “Credo nel valore dell’utopia come strumento euristico e come riferimento teoretico in questo momento di crolli e ricomposizioni, di confusione e pessimismo sulle possibilità di raggiungere una società dal volto e dall’anima umani… credo nel dovere degli oppositori sociali di assediare l’utopia, pensandola, analizzandola, costruendola come progetto a partire dai fatti nuovi e dalle necessità di oggi. Non partiamo da zero. Nell’esperienza abbiamo appreso, e nei movimenti sociali distinguiamo di nuovo, in fretta, il clamore di una società ugualitaria, demolitrice del vecchio, creatrice di nuovi concetti e pratiche riguardo le relazioni sociali, contro ogni forma di oppressione sociale e sessuale, come preoccupazione e azione per fermare l’etnocidio ed il genocidio” (Asedio a la utopía. Ensayos políticos, 1989-1994, Luna y Sol, Guatemala, 1996, p. 45).
14 settembre 2011
Revista Rebeldía n° 78
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca da |
| Arturo Anguiano, “Guerra, política, resistencias y alternativas” traducido para Revista Rebeldía por S., pubblicato il 14-09-2011 su [http://revistarebeldia.org/revistas/numero78/08anguiano.pdf], ultimo accesso 11-11-2011. |