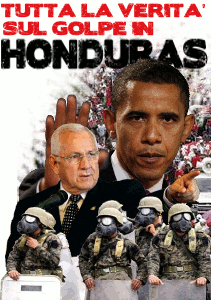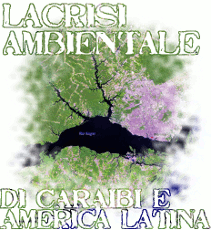Silvio Schachter
“La questione che città vogliamo non può essere dissociata da che tipo di persone vogliamo essere, che tipo di relazioni sociali cerchiamo, che relazioni vogliamo con la natura, che stile di vita, e che valori estetici consideriamo”.[1]
La produzione e riproduzione dello spazio urbano è uno dei meccanismi con cui il capitalismo affronta le proprie crisi di sovraccumulazione, che è assorbita attraverso la propria costante ristrutturazione. Nella sua espansione effettua una redifinizione della città e di quanto è urbano, della sua demografia, della sua dimensione, creando una nuova relazione centro-periferia.
Così inteso, lo spazio è molto più che il contenitore, l’ambito fisico dove si riesce a materializzare il consumo. È di per sé stesso un prodotto creato per essere consumato, e facendolo rafforza la trama multidirezionale dove garantisce la salvaguardia delle relazioni di proprietà, il controllo sociale e politico, mediante una organizzazione spaziale che formalizza la gerarchia del potere e del dominio.
Le grandi città, particolarmente le metropoli, si sono progressivamente trasformate nella sfera centralizzata dove si esercita questo dominio, attraverso una serie di trasformazioni accelerate che si sovrappongono alle precedenti forme, componendo un nuovo quadro di molteplici conflitti e tensioni. La tradizionale città borghese è devastata dallo sfrenato sviluppo capitalista, trasformata in una vittima della necessità di disporre dello spazio per l’accumulazione di capitale, avanzando verso una crescita senza fine, senza che abbiano importanza le conseguenze sociali, ambientali o politiche.
Mentre più si globalizza, attraversata da una rete di flussi informatici, comunicativi e di affari, più si polarizza e rompe la percezione del tempo e dello spazio. In questo cammino si acutizza la contraddizione tra la centralizzazione in centri generici globali, sempre più omogenei, e la frammentazione dello spazio locale, provocata dalle strategie di agenti immobiliari che operano secondo le nuove forme produttive e speculative. Specialmente per realizzare grandi progetti, favoriti dalla flessibilità che gli permette l’integrazione dei mercati finanziari. Quasi tutte le grandi città sono state testimoni di un picco delle costruzioni, prevalentemente destinato a soddisfare i settori più ricchi, mentre proliferano habitat precari, verso dove sono espulsi e messi in un angolo i più impoveriti.
Questi fenomeni contestualizzano l’interpretazione del processo di urbanizzazione dell’Area Metropolitana di Buenos Aires. La sua attuale configurazione è il risultato dell’influenza e dei condizionamenti dei modelli globali, della riconfigurazione socio-territoriale, che con la sua dinamica ridimensiona il significato del globale e del locale, del macro e del micro, del fluire e dell’abitare, del reale e dell’astratto. L’AMBA è il riflesso di queste tendenze, legate ai grandi processi di cambiamento economico, demografico, sociale e politico operati nella nostra società. La sua attuale configurazione è il risultato delle mutazioni avvenute soprattutto a partire dagli anni 70, come conseguenza delle politiche neoliberiste che erano cominciate ai tempi della dittatura militare e sono aggressivamente continuate nei ’90. Queste hanno generato una struttura di relazioni sociali inedite, per i loro livelli di disuguaglianza e di frattura socioeconomica, e hanno dato luogo a nuove contraddizioni interurbane e intraurbane.
Gli interventi selettivi e le omissioni deliberate dello stato hanno condizionato la sua evoluzione spaziale accompagnando la trasformazione dei modi di produzione, creando nuove localizzazioni e ristrutturando compulsivamente le esistenti. Si è allora prodotta la decadenza di importanti zone e si è creata una nuova rete di centralità. Aspetti importanti sono l’aumento delle urbanizzazioni chiuse, la crescita delle aree di servizi e del lavoro informale, la rilocalizzazione di imprese in parchi industriali lontani dagli insediamenti abitativi. Il consumo portato al parossismo, che abbandona la strada per rinchiudersi in shopping e ipermercati con gigantesche aree di parcheggio, prodotto dell’imposizione dell’automobile come trasporto predominante. Come una trama di nodi isolati, si uniscono attraverso vie rapide e autostrade sempre più saturate e con spostamenti che comportano ore di tempo perso tanto sociale come familiare e produttivo. Un urbanesimo senza città si adatta ad un nuovo modello di abitare, produrre e consumare.
La regione ha modificato la sua morfologia concentrica, continua e considerevolmente centralizzata –caratteristica della città moderna industriale– verso uno schema disperso, frammentario, discontinuo e diffuso. Materializza una accentuata dinamica di occupazione differenziale che spiega gli effetti di segregazione e polarizzazione, che rispondono ad un differente modello di appropriazione dello spazio, dove la proprietà privata del suolo è causa fondamentale nella determinazione delle possibilità di uso delle parti e delle funzioni della città. La conurbanizzazione fagocita territorio: non è più circolare né estesa radialmente, ma si frattura in territori insulari di enorme ricchezza, circondati da zone altamente pauperizzate.
Estesa sul terreno, senza piano né direzione, Buenos Aires, non solo si espande: si allontana, fisicamente e simbolicamente, non può più essere compresa come un tutto, risulta difficile localizzare i bordi, i passaggi dentro una illimitata diffusione, che modifica la relazione dentro e fuori. Evolve in una permanente mutazione e auto negazione, costituendo il paradosso di cercare il proprio luogo nella rete di città globali come una totalità, ma dividendosi continuamente al suo interno.
 La metropoli è diventata multipolare, il centro ha perso la sua esclusività, anche se nominalmente le venga assegnato questo luogo, a somiglianza dei suoi abitanti che continuano ad essere considerati porteños (del porto, sono così chiamati gli abitanti della città di Buenos Aires, ndt) anche se il porto ha perso rilevanza nella sua vita. Non esiste più solo un centro, esistono anche varie periferie. Sebbene persista l’esistenza di questo confronto gravitazionale, c’è stata una rottura delle forme e delle gerarchie in cui si esprimono i contenuti emblematici e funzionali. Questo modello interpretativo è mutato a Buenos Aires, perché si sono moltiplicati i centri o perché esiste centralità senza periferia o, bene, urbanizzazioni estese senza un punto nodale di riferimento.
La metropoli è diventata multipolare, il centro ha perso la sua esclusività, anche se nominalmente le venga assegnato questo luogo, a somiglianza dei suoi abitanti che continuano ad essere considerati porteños (del porto, sono così chiamati gli abitanti della città di Buenos Aires, ndt) anche se il porto ha perso rilevanza nella sua vita. Non esiste più solo un centro, esistono anche varie periferie. Sebbene persista l’esistenza di questo confronto gravitazionale, c’è stata una rottura delle forme e delle gerarchie in cui si esprimono i contenuti emblematici e funzionali. Questo modello interpretativo è mutato a Buenos Aires, perché si sono moltiplicati i centri o perché esiste centralità senza periferia o, bene, urbanizzazioni estese senza un punto nodale di riferimento.
La nozione e la percezione della città sbiadiscono anche sulle altre scale minori, tra le quali quella del quartiere. Il concetto di vivere in un determinato luogo non è più uguale al sentimento di far parte di un quartiere, come elemento identitario e di appartenenza. L’eccezione, come unità morfologia e strutturale, sopravvive in quei luoghi dove l’affare immobiliare non è ancora dominante e lo stato ha una debole presenza.
La rottura della tradizionale centralità della città non significa la sua scomparsa, in quanto espressione di potere o contropotere, mondialmente c’è una spinta e un anelito alla sua restaurazione, che si propone di volta in volta, nella ricerca di produrre atti di forte ripercussione politica, come recentemente lo abbiamo visto nelle piazze e nei luoghi centrali del Cairo, Madrid, Atene, Barcellona, Istanbul o Rio de Janeiro.
La macchia urbana
Prendere la regione metropolitana di Buenos Aires come scala di analisi non presuppone di ignorare l’esistenza di molteplici livelli e delle loro rispettive interazioni; è assumere questa dimensione come il prodotto essenziale della globalizzazione. L’AMBA è una metropoli di 5.000 chilometri quadrati, con quasi 15 milioni di abitanti, concentra più di un terzo della popolazione di tutto il paese nello 0,2% della sua superficie, in America Latina è la terza per la sua grandezza e densità e una delle 20 più grandi del mondo (occupa il 18° posto).
È suddivisa in 40 municipi, e la CABA (Città Autonoma di Buenos Aires, la Capitale Federale) ha 48 quartieri e 15 comuni. La globalizzazione non ha fatto altro che acutizzare questo modello centralista e squilibrato. La sua dimensione e densità hanno superato tutte le previsioni, con una crescita caotica che sfida le ipotesi teoriche, politiche e sociali con cui si è cercato di spiegare la sua condizione e proiezione. Ha una grandezza che ammette solo diagnosi parziali e approssimazioni settoriali, che quasi sempre si limitano a rimedi e tentativi di ricucitura di fronte alle rotture e carenze del tessuto.
La produzione dello spazio urbano bonaerense, intesa come costruzione sociale, e i conflitti che la attraversano, si trovano occultati da una sinergia di fenomeni e relazioni che nascondono e simulano fantasie nei modi di vivere, sentire e pensare l’habitat cittadino.
1- Crescita senza controllo dell’urbanizzazione;
2- Assenza di pianificazione urbana e regionale;
3- Privatizzazione dello spazio pubblico;
4- Speculazione sul suolo urbano, concentrazione da parte di grandi imprese immobiliari e costruttrici;
5- Cambi nell’uso del suolo per privilegiare le grandi iniziative immobiliari;
6- Suburbanizzazione della classe medio-alta in quartieri chiusi senza collegamenti con la città preesistente;
7- Crescente privatizzazione dei servizi della sanità e dell’educazione e il loro conseguente insediamento asimmetrico;
8- Deterioramento della qualità della vita per l’inquinamento dell’aria, visivo (per l’invasione della pubblicità) e sonoro;
9- Mancanza di manutenzione e di nuove infrastrutture della rete dell’acqua potabile, pluviale, elettrica e del gas;
10- Supersfruttamento e contaminazione delle sue risorse d’acqua, distruzione dei polmoni verdi che le alimentano di ossigeno e riforniscono il manto freatico;
11- Aumento della creazione di residui prodotti dal consumismo, gravi carenze nel sistema di raccolta, deposito e trasformazione dell’immondizia;
12- Degrado dell’ambiente naturale, sfavorevole rapporto degli spazi verdi per abitante;
13- Sistema dei trasporti pubblici insufficiente, inefficiente, degradato, di carattere privato o amministrato da imprese private;
14- Traffico caotico, basato sull’irrazionale supremazia dell’automobile;
15- Mobilità ostacolata: quotidianamente gli abitanti della periferia devono fare estesi e prolungati percorsi, consumando ore della propria vita familiare e sociale;
 16- Mancanza di abitazioni, le politiche della casa che non tengono in considerazione l’habitat sociale;
16- Mancanza di abitazioni, le politiche della casa che non tengono in considerazione l’habitat sociale;
17- Segregazione e frammentazione territoriale;
18- Rottura delle dinamiche collettive, solidali e comunitarie, aumento dell’isolamento, della diffidenza, dell’insicurezza e della violenza.
Questa enumerazione parziale rende conto della grandezza e varietà dei problemi che affronta l’AMBA. Sebbene sia noto che non danneggi allo stesso modo tutti i suoi abitanti e non si distribuisca in modo omogeneo in tutta la sua geografia, deve essere trattata come un insieme, allo stesso modo di un sistema complesso, eterogeneo, dove le sue parti si inter-influenzano ma non agiscono integrate. Pertanto, è impossibile da affrontare attraverso una sola disciplina, giacché è formata dall’interazione di numerosi agenti, cause ed effetti difficilmente comprensibili con la semplice analisi di una delle sue parti. Non ammette nemmeno un esame temporale diacronico, come una sequenza successiva di fenomeni. In un processo di permanente entropia negativa, ha bisogno di prendere energia da altre fonti per equilibrarsi, ma questo a sua volta produce nuovi scompensi in un sistema in continuo degrado.
L’AMBA è la scena di un veloce passaggio verso una nuova entrata di condizioni non previste, con molteplici effetti che definiscono situazioni estreme e distruzioni che si presentano come insuperabili.
Di chi è la città?
“È necessario ammettere che alla base della sua crisi c’è l’implicita differenziazione tra la produzione sociale dello spazio e la sua appropriazione privata”.[2] Pertanto, il dibattito sullo spazio pubblico e comunitario acquista una speciale rilevanza, in quanto la sua appropriazione privata, e perciò la sua trasformazione ontologica, gli cambia sostanzialmente la sua essenza: diviene un altro spazio, un territorio differente che è integrato alla logica della città-affare, creando una nuova asimmetria.
Il comune creato dal lavoro collettivo investito nella città, è riappropriato dalla capitalizzazione individuale, escludendo dal suo uso la maggioranza che ha operato per la sua creazione. Di modo che la città, un bene creato da tutti, offre i propri benefici solo ad una parte. Un chiaro esempio è la tendenza a vedere ogni volta di più la città come parte dell’affare turistico. La creazione dell’ambiente e l’attrattiva di una città è il prodotto combinato di azioni fisiche, culturali, paesaggistiche di risonanza molteplice e polivalente; ma è l’industria turistica quella che approfitta commercialmente di questo campo comune per estrarre rendita.
Lo spazio pubblico e comunitario non è solo la piazza o il parco, come ossigenatore destinato a dare porosità e aria fresca ad un modello sempre più compatto di cemento che diminuisce la possibilità di ricreazione e godimento della bellezza della scena. È costituito da una molteplicità di ambiti: la strada, il centro culturale, la scuola, l’ospedale, la fiera, il club sociale e sportivo, luoghi di dibattito e gestione. È da lì che si possono fondare e determinare le politiche e i progetti collettivi. Contribuisce a recuperare il senso di appartenenza ad una comunità, cambiando la prospettiva, con un punto di vista aperto, che situa l’individuale, l’intimo e il collettivo come stadi differenti, ma non contrapposti né antagonisti.
Quando lo spazio vissuto è solo privato, senza nessi, senza socialità, la possibilità di un fare critico e trasformatore collettivo si restringe e limita. L’attività politica è rimpiazzata dal non luogo, i sondaggi e i media. All’opposto il recupero e la creazione dello spazio comune afferma la propria potenzialità di creare integrazione e dare visibilità al popolare e all’azione politica.
Le strade delle nostre città sono sempre meno aperte, più regolate, più vigilate, anche privatizzate. I suoi marciapiedi sono sempre in riparazione: sono perforati, sono modificati, con martelli, scavatrici, picconi e pale in un rumore assordante; a volte per chiudere e a volte per aprire. Le strade che si intasano con il traffico, sono quasi inservibili come spazio pubblico, sono dominate dai conducenti dei veicoli e andare a piedi si trasforma in un atto rischioso e subordinato. Prima di essere occupate dagli autoveicoli, le strade erano della gente, del pedone, del passante, un luogo popolare di socialità, di festa, uno spazio di gioco per i bambini. In una sola generazione i bambini, i residenti, gli anziani, sono stati espulsi dalla strada, portati a differenti forme di reclusione, che sviluppano e consolidano una architettura della paura, della diffidenza e dell’isolamento.
È la conseguenza di un vero attacco dell’automobile che la regione metropolitana ha subito. La circolazione dei veicoli è colei che la definisce, non i suoi luoghi: in essa circola il 52% del totale del paese. Loro sono i responsabili dell’ 83% degli incidenti e del 76% della contaminazione dell’aria. Nei giorni di picco della contaminazione le morti per malattie coronariche aumentano. Ma non è solo questione di respirare tossine, la congestione veicolare può costare il 10% del PIL. Il tempo di inattività non viene mai conteggiato, anche se supera largamente le ore non lavorate per scioperi o conflitti sociali. Per paradosso, i governi che parlano di ambiente e di sviluppo sostenibile celebrano l’aumento della produzione di autovetture, accreditando una visione produttivista, divoratrice di energia e combustibile fossile, con lo stesso modello che sostiene le megaminiere, la produzione di soia o l’utilizzo del fracking per alimentare questo irrazionale sistema dei trasporti.
Nei processi di privatizzazione, il capitale metabolizza rapidamente lo spazio in un ordine esistente, integrando forme e contenuti alla sua struttura sociale. In questo fare di fatto consolida la sua forma di proprietà e, insieme ad essa, le relazioni culturali, sociali e giuridiche che la sorreggono. Questo meccanismo di sussunzione si realizza sulla base di modelli che sostengono i privilegi di classe e i meccanismi di dominazione sullo spazio.
 Questa condizione socio spaziale diminuisce la capacità della società di incidere e agire nella città, non solo per una perdita quantitativa di superficie dove agire, ma quanto più il dominio si sottrae alla sfera comune, meno sovranità e potere ha la comunità di intervenire e perciò il tessuto sociale si debilita. Naturalmente, i soggetti fanno parte di questa metabolizzazione, dove il nuovo costruito stabilisce nuove relazioni e soggettività che vincolano proprietari, consumatori, professionisti, impresari, lavoratori e abitanti; che sono integrati in questa materializzazione dell’attività urbana, omogenizzati da una matrice patrimoniale. Il carattere pubblico del suolo è sotterrato da una trama di beni immobili privati, la cui futura de-costruzione e recupero nell’ambito comune presuppone una catena di conflitti di difficile risoluzione.
Questa condizione socio spaziale diminuisce la capacità della società di incidere e agire nella città, non solo per una perdita quantitativa di superficie dove agire, ma quanto più il dominio si sottrae alla sfera comune, meno sovranità e potere ha la comunità di intervenire e perciò il tessuto sociale si debilita. Naturalmente, i soggetti fanno parte di questa metabolizzazione, dove il nuovo costruito stabilisce nuove relazioni e soggettività che vincolano proprietari, consumatori, professionisti, impresari, lavoratori e abitanti; che sono integrati in questa materializzazione dell’attività urbana, omogenizzati da una matrice patrimoniale. Il carattere pubblico del suolo è sotterrato da una trama di beni immobili privati, la cui futura de-costruzione e recupero nell’ambito comune presuppone una catena di conflitti di difficile risoluzione.
Lo stato, lontano dall’apportare norme di compensazione e regolazione –come storicamente ha proposto la teoria urbanistica della modernità– sta agendo come facilitatore di questi processi. Rende più visibili gli spazi che strategicamente permettono meglio la riproduzione del capitale nell’affare immobiliare. Presentate come innovazioni e valorizzazioni, le azioni si dispiegano con il presupposto di favorire lo sviluppo urbano, senza meditare sulle conseguenze e gli effetti di una concezione depredatrice del progresso.
Elaborare un vero progetto socio-spaziale nella città implica di disfarsi del significato del concetto tradizionale di sviluppo urbano, inclusi i nuovi termini di intelligente e sostenibile, con i quali si cercano di coprire mega iniziative dietro la fraseologia del capitalismo verde.
Con la sua esperienza di successo, in termini di rendita speculativa, e a venti anni dal suo lancio, nel nostro paese Puerto Madero ha stabilito un precedente, raccogliendo operazioni simili di altre latitudini, così sono state espropriate alla società decine di ettari in una zona privilegiata di fronte al fiume. La modalità continua ad essere utilizzata con l’argomento di valorizzare aree degradate e trascurate dallo stesso stato, operazioni immobiliari che aumentano il prezzo delle proprietà limitrofe, creando plusvalenze addizionali, il cui risultato è la gentrificazione e segregazione dei settori più poveri in zone marginali.
Questo cammino, di saccheggio urbano, percorso specialmente a partire dei 90, ha contato, oltre al piano pilota per Puerto Madero, sulla vendita dei terreni dopo la demolizione del Warnes, la proprietà della Società Rurale, il Mercato trasformato in shopping. Continua oggi, sostenendosi su illeciti accordi politici, con la vendita degli ultimi lotti di Catalinas, di 20 proprietà in distinti quartieri della città, dell’edificio del Plata, la concessione di 37 ettari del parco Roca, i progetti per i cosiddetti Nuovi Quartieri di Palermo, Caballito e Liniers nei piazzali di manovra delle ferrovie, il mega quartiere premium della Città Sportiva di Boca e le nuove proposte per l’Isola Demarchi, come casi più significativi.
L’investimento privato dispiegato per una modernizzazione superficiale è il velo che nasconde una delle tante dualità che misurano la città, nel substrato sottostà una infrastruttura collassata e senza manutenzione. La sua obsolescenza è rimasta esposta alle inondazioni del 2 aprile, che hanno colpito principalmente La Plata e la CABA, tragedia dalle molteplici origini, segnata dall’inerzia e dalla negligenza. Tutti i servizi essenziali per la vita sono nelle mani private, di proprietà o amministrati da compagnie imprenditoriali. I trasporti, il gas, la luce, l’acqua sanitaria, il sistema fognario, la telefonia, la raccolta dei rifiuti. Forse possiamo trovare l’esempio in Bolivia, quando a Cochabamba nella cosiddetta “guerra dell’acqua” si riuscì ad espellere la multinazionale che la gestiva, permettendo di recuperarla come bene pubblico per tutta la comunità.
Disegno del caos o pianificazione
Il sogno liberatore della vita cittadina si è trasformato in uno stato di permanente malessere e ostilità. Per milioni dei suoi abitanti la vita nella non civilizzata Buenos Aires, come quella di tante metropoli, è diventata insopportabile. Scomoda, ingrata, non si lascia percorrere né guardare, non compie più il suo ruolo agglutinatore, il suo effetto è disintegratore nel sociale e nell’individuale. Il tentativo di scappare dall’incertezza che la società di rischio promuove si trasforma nell’accettazione di un modello urbano che rafforza l’introspezione, il ripiegamento interiore, nell’immergersi nel fare individuale e privato; l’esterno e il pubblico si presentano come un mondo incomprensibile, criptico e carico di minacce, che tende in modo crescente ad approfondire l’isolamento, l’ansietà e le nevrosi. “Si parla della città come se fosse un organismo biologico, il ventre, le arterie, il suo centro nervoso, il cuore della città, ma non è un organismo, è un corpo di altro tipo. Un corpo che assorbe e espelle altri corpi, inghiotte senza digerire”.[3]
Il registro è di perdita e stimola un senso comune conservatore, impregnato di sentimenti nostalgici per una città perduta, un immaginario che non riesce a spiegare come la città di cui si ha nostalgia svanisca sempre più, fino a diluirsi in un territorio inafferrabile. La ricerca nel passato rivela anche il nuovo asse mediatico e politico, la paura urbana, e l’insicurezza; incentivati da trasformazioni che si sono accumulate quasi sempre con un segno negativo.
Invece di affrontare la crisi, per le elite è più semplice la fuga, occupare gli spazi vuoti dove incominciare da zero, senza storia né condizionamenti, omogeneo ed isolato. L’habitat fabbricato diventa un surrogato di un fatto di consumo.
Il trasferimento verso il quartiere chiuso o la “gated community” verticale ricrea un ambiente di natura artificiale, costituisce un modello che propone fantasiosamente la possibilità di far parte di una città ideale, immobile, con codici immutabili che presentano il futuro come un presente ripetuto, dissimulato dalla pulizia sociale che simula la sensazione di appartenenza al primo mondo.
 Una condizione del cosiddetto capitalismo flessibile, basato sul just in time, è la messa in questione e il discredito della pianificazione in genere, e di quella urbana in particolare. Gli urbanisti, che per un lungo periodo sono stati guidati dalla metodologia di utilizzare strumenti tecnici, fisici, per risolvere patologie e conflitti di ordine sociale, hanno garantito più fracassi che successi. Il riconoscimento del ruolo degli abitanti nella formazione della città e nella politica urbana è abbastanza recente, solo ora incominciano ad essere considerati, tanto sul piano teorico come nel mondo della pratica radicale.
Una condizione del cosiddetto capitalismo flessibile, basato sul just in time, è la messa in questione e il discredito della pianificazione in genere, e di quella urbana in particolare. Gli urbanisti, che per un lungo periodo sono stati guidati dalla metodologia di utilizzare strumenti tecnici, fisici, per risolvere patologie e conflitti di ordine sociale, hanno garantito più fracassi che successi. Il riconoscimento del ruolo degli abitanti nella formazione della città e nella politica urbana è abbastanza recente, solo ora incominciano ad essere considerati, tanto sul piano teorico come nel mondo della pratica radicale.
Per decenni, ad una debolezza dell’approccio teorico si è sommata la cattiva gestione, la sistematica inadempienza di numerosi progetti e l’assenza di partecipazione dei coinvolti. L’incredulità e la sfiducia in qualsiasi previsione o piano che superi l’immediatezza sono associate ad una realizzazione dal finale dubbio, dove predomina il sospetto –molte volte fondato– di flagranti atti di corruzione. La subordinazione prosaica a politiche di breve termine sempre agisce a detrimento della genuina e sincera ricerca di soluzioni necessarie, possibili e sostenibili nel tempo.
Questo quadro è servito come argomento manicheo per giustificare il disegno del caos, cedendo l’organizzazione socio spaziale alle mani del mercato, in modo conforme ad un assioma basilare del neoliberismo: guardare il pubblico dal privato. Premessa che non è sostanzialmente cambiata con il cambio dei governi, nonostante i differenti modelli che tendono a affrontarlo o dicono di volersi confrontare.
La menzogna del mercato regolatore parte dal considerare il suolo urbano come mercanzia prodotta, quando in realtà non è il risultato di nessun atto di produzione, come non lo è una montagna, un fiume o il mare. Chiaramente l’appropriazione lucrativa del “lavoro della natura” rende legittimo recuperarlo per disporre del suo uso come bene sociale.
L’offerta e la domanda generano prezzi differenziali, sulla base delle loro condizioni costitutive, il suolo urbano è essenzialmente limitato, unico e irriproducibile. Questa caratteristica, fa sì che il mercato non possa “fabbricare” più terra –se non rubandola al fiume, storica pratica ricorrente nella città di Buenos Aires– impone come opzione, per garantire la riproduzione della sua quota di profitto, di aggiungere nuovo territorio per poterla realizzare, a costo di estendere la città o densificarla verso l’alto. Siccome questo processo ha come unico obiettivo la valorizzazione del capitale, l’ipotesi di una crescita pianificata sulla base del carattere sociale dell’habitat svanisce. La fotografia dell’AMBA è la dimostrazione grafica di questa operazione espansiva.
I terreni urbani continuano ad essere il nocciolo della questione, in una società patrimoniale come la nostra, la mancanza di pianificazione è legata ad un problema strutturale, al suo carattere prevalentemente privato. Come disporre di un progetto urbano, come pianificare qualcosa di cui non si ha la proprietà, che non si possiede? Pertanto il progetto deve considerare la riappropriazione comunitaria di quanto alienato, e deve includere come primo atto la difesa di ciò che ancora sopravvive di proprietà pubblica.
La pianificazione non è neutrale, non interviene in una società omogenea e indifferenziata, al contrario coinvolge una comunità le cui relazioni sono contraddittorie e antagoniste, sia per conservarle, riformarle o sovvertirle radicalmente. Deve essere intesa come un mezzo per esercitare la critica alle forme di rappresentazione socio-spaziali, alla loro struttura, alle loro funzioni e forme e alla feticizzazione di quanto percepito e concepito.
La pianificazione e la gestione urbana non possono essere solo pensate come pratica dell’apparato statale, pregiudizio basato sul fatto evidente che è lo stato che monopolizza gran parte delle risorse necessarie per attivare interventi. Questi atti generalmente si esauriscono nella semplice raccolta di dati per modelli normativi di scarsa esecutività. Normativa di segno passivo, che si riduce, nella migliore situazione, a porre certi limiti all’intensività, alle volumetrie e ai tipi di uso. La mappa si offusca perché le aree di competenza dividono rigidamente la problematica su scala locale, regionale e nazionale, secondo il groviglio istituzionale burocratico, invece di porre in primo piano la forma e la natura delle relazioni sociali e pensare su una multi scala, integrando nello spazio continuità e discontinuità. La divisione politico amministrativa impone di trattare grandezze e risorse dissimili e finisce per sclerotizzare i collegamenti necessari e possibili.
L’attivismo collegato solo ad un particolarismo settoriale e come reazione limitata da un danno diretto, in genere di carattere patrimoniale, rende manifesta la difficoltà di agire in un universo più ampio, dove la città si visualizza integralmente e, conseguentemente, poter frenare un processo evolutivo con prove di progressivo peggioramento. Le azioni puntuali non possono essere trasferite su tutti i piani: misure che possono sembrare opportune in un’area ristretta molte volte, al contrario, si trasformano in negative fuori da questo contesto. Nel frattempo gli interessi di classe e di settore sono contrapposti, le soluzioni non saranno polivalenti, pertanto avranno il segno di chi egemonizza la produzione dello spazio, che presuppone limiti e frontiere controverse.
Le esperienze di udienze pubbliche, di bilanci partecipativi o in consigli comunali, quando sono sprovvisti di decisione e di reale incidenza nella definizione delle politiche locali e regionali, perdono spessore. In molti casi sono sottoposte a limitate occhiate di una geografia che non può essere pensata come un rompicapo che si monta con i numerosi pezzi dell’apparato amministrativo dello stato. Affrontano il pericolo che dietro la difesa della partecipazione istituzionale si nasconda la tendenza alla cooptazione, a promuovere la smobilitazione della base sociale, a delimitare e diluire il tema e a settorializzarlo dietro valutazioni tecniche e a politiche burocratiche.
 Il dibattito deve assumere la crisi in tutta la sua dimensione, riproporre il carattere, il senso e la direzione del cambiamento necessario. La negazione della realtà, la naturalizzazione dei problemi tende a bloccare ogni memoria che permette di determinare la sua origine e alimenta una interpretazione rassegnata che neutralizza l’ipotesi, ovviamente perturbatrice, di una trasformazione sistemica.
Il dibattito deve assumere la crisi in tutta la sua dimensione, riproporre il carattere, il senso e la direzione del cambiamento necessario. La negazione della realtà, la naturalizzazione dei problemi tende a bloccare ogni memoria che permette di determinare la sua origine e alimenta una interpretazione rassegnata che neutralizza l’ipotesi, ovviamente perturbatrice, di una trasformazione sistemica.
Il diritto alla città è un significante vuoto. Dipende da chi e come lo riempirà di senso, presuppone la conquista di un diritto negato e alienato e il necessario, permanente adeguamento di una vita urbana che permetta l’accesso ad un habitat sociale, alla casa, ai trasporti, all’educazione, alla sanità, ai servizi, alla cultura e alla ricreazione. Ma l’aspirazione che questi diritti diventino realtà impone modifiche necessarie, profonde; permettere la revisione di storiche pratiche che partono dall’accettazione di un paradigma di città svuotato.
L’attenzione non deve essere solo sulla messa in questione delle politiche ufficiali, c’è una soggettività costruita, legata a visioni patrimoniali. È consueto sentire che la vicinanza dei poveri svaluti le proprietà, che si somma alla cultura postmoderna del consumismo e dell’edonismo, ad un atavico rifiuto dell’altro, che alimenta pregiudizi raziali, di classe, xenofobi, stereotipi discriminatori. Processi di perdita di legami comunitari, di degrado dell’uomo pubblico, un’abitudine di reazione negativa di fronte a quanto è differente, una nozione di pericolo, dove la povertà è associata al delitto e la sicurezza al determinismo sociale. I profondi impatti della recente ondata di privatizzazioni e l’ideologia che la sostiene giustificano una vita urbana sempre più sorvegliata, inibiscono le potenzialità di nuove forme di relazioni sociali, sostengono un processo alterato e dominato dagli interessi delle classi dominanti.
Rifondare Buenos Aires
La produzione dello spazio costituisce un elemento centrale della problematica del mondo contemporaneo, la riproduzione della vita si realizza in relazione ad uno spazio tempo concreto. Dobbiamo riconoscere che ancora non si è riusciti a promuovere un dibattito pubblico e aperto su cause e origini, che non esiste una organizzazione sociale e politica effettiva che permetta di neutralizzare gli effetti negativi propri di questo modello urbano.
Non si tratta solo dei movimenti sociali, il pensiero critico e la sinistra in generale non riescono ancora a valutare la rilevanza di quanto è urbano, la città appare come uno sfondo o con letture e azioni parziali. Con questo modo interpretativo, agiscono sotto l’influenza della logica borghese, che storicamente sostiene che la problematica della città è patrimonio di specialisti, che siano urbanisti, geografi o sociologi, e dei settori tecnici dello stato. Continua ad essere assente la ricerca di integrare la comprensione dei processi di urbanizzazione e dello spazio costruito, come parte della teoria del movimento del capitale e della sua relazione con i processi politici, culturali e del mondo del lavoro.
Henry Lefebvre ha sviluppato il concetto di eterotopia, come la demarcazione degli spazi sociali di collegamento dove si può fare qualcosa di differente, qualcosa che non è solo possibile, ma fondamentale per la definizione delle traiettorie trasformatrici. Il differente non sorgerà solo da un piano cosciente, esistono forme diverse di riappropriazione del territorio, aree e luoghi della metropoli che sono un prolungamento delle lotte materiali e per il riconoscimento. Sono i punti d’incontro e di costruzione della solidarietà: l’occupazione di terre e gli insediamenti, le comunità di emigranti che formano i propri quartieri, i movimenti giovanili o le subculture urbane, i media alternativi. Offrono una varietà e ricchezza di pratiche di autorganizzazione sociale e di resistenza, di fronte a questi luoghi e ribellioni le forme di cordone sanitario sono innumerevoli: accerchiamento, per mezzo della separazione fisica sia attraverso infrastrutture specifiche o sia approfittando dei confini naturali; segregazione sociale, attraverso pratiche di criminalizzazione e condanna; degrado e depauperamento urbano, per mezzo dell’abbandono istituzionale o la repressione diretta. Una politica differente sarà anche quella che sa localizzare questi punti di connessione e simbiosi, favorendo la sua organizzazione autonoma.
Con l’attuale conformazione del territorio urbano bonaerense sembra difficile parlare di luoghi vissuti dove acquisire esperienza capace di sovvertire logiche egemoniche; è nelle fenditure o negli interstizi che questa topografia crea dove possono questi luoghi sopravvivere e ricrearsi. È nei quartieri popolari, sia per esclusione o scelta, dove gli abitanti possono ancora essere portatori della produzione del loro proprio spazio.
Trasformare Buenos Aires è un’impresa equivalente a una rifondazione. È riproporre e rompere la sua centralità, limitare l’urbanizzazione del suo territorio basata sulla speculazione e gli affari, svoltare verso la crescita equilibrata di altre città e regioni, cambiare l’aria, trovare il suo equilibrio ecologico, modificare il modello della proprietà privata come motore strutturale. Pensarla su una scala dove l’umano torni ad essere la misura del vivere bene: una città con valore d’uso, non come astrazione pubblicitaria, capace di dispiegare nuove politiche spaziali e di tempo urbano liberato e creatore.
 Senza dubbio non è un compito semplice immaginare ciò che non esiste. Una svolta di tale dimensione, che sembra un sogno irraggiungibile, può essere frustrante, ma il motore ne deve essere il processo della sua ricerca per affrontare la rassegnazione di fronte allo statu quo. Un orizzonte emancipatore che parte da azioni nel qui e ora, ma che non si esaurisce nell’immediatezza della protesta o nel calcolo di agende politiche. La scala e la grandezza dei problemi da risolvere non permette unicamente soluzioni a breve termine, ma senza dare inizio ad un percorso di rinnovamento radicale della questione, mai saranno risolte.
Senza dubbio non è un compito semplice immaginare ciò che non esiste. Una svolta di tale dimensione, che sembra un sogno irraggiungibile, può essere frustrante, ma il motore ne deve essere il processo della sua ricerca per affrontare la rassegnazione di fronte allo statu quo. Un orizzonte emancipatore che parte da azioni nel qui e ora, ma che non si esaurisce nell’immediatezza della protesta o nel calcolo di agende politiche. La scala e la grandezza dei problemi da risolvere non permette unicamente soluzioni a breve termine, ma senza dare inizio ad un percorso di rinnovamento radicale della questione, mai saranno risolte.
Il progetto di una città di nuovo tipo è il progetto di una società differente, non si risolve con un piano, deve passare per l’intervento di tutti coloro che sono coinvolti, non si risolve con consultazioni di solito travestite da partecipazione popolare.
La percezione generale, che pensa che i cambiamenti mai arriveranno, che è una battaglia contro i mulini a vento, alimenta l’incertezza che accetta i mali conosciuti di fronte al rischio di cambiamenti verso percorsi sconosciuti. La dimensione di un nuovo modello urbano può sembrare utopistica, anche se è più utopistico pensare che i conflitti che gravano sul divenire della metropoli si risolveranno, ricordando le parole di Marx, senza “abolire l’attuale stato delle cose”.
Note:
[1] David Harvey, Rebel cities, Verso Books, Londres, 2012.
[2] Ana Fani Alessandri Carlos, “Ciudades, diferenciación socio espacial”, v. 4, n. 6, 2007, p. 45-60, Cidades, 2007.
[3] La ciudad a lo lejos, Jean- Luc Nancy, Bordes-Manantial 2013.
Silvio Schachter. Architetto, membro del comitato di redazione di Herramienta.
Herramienta
| Traduzione del Comitato Carlos Fonseca: |
| Silvio Schachter, “Buenos Aires, una metrópoli sin ciudad” pubblicato in Herramienta, su [http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-14/buenos-aires-una-metropoli-sin-ciudad] ultimo accesso 04-12-2013. |